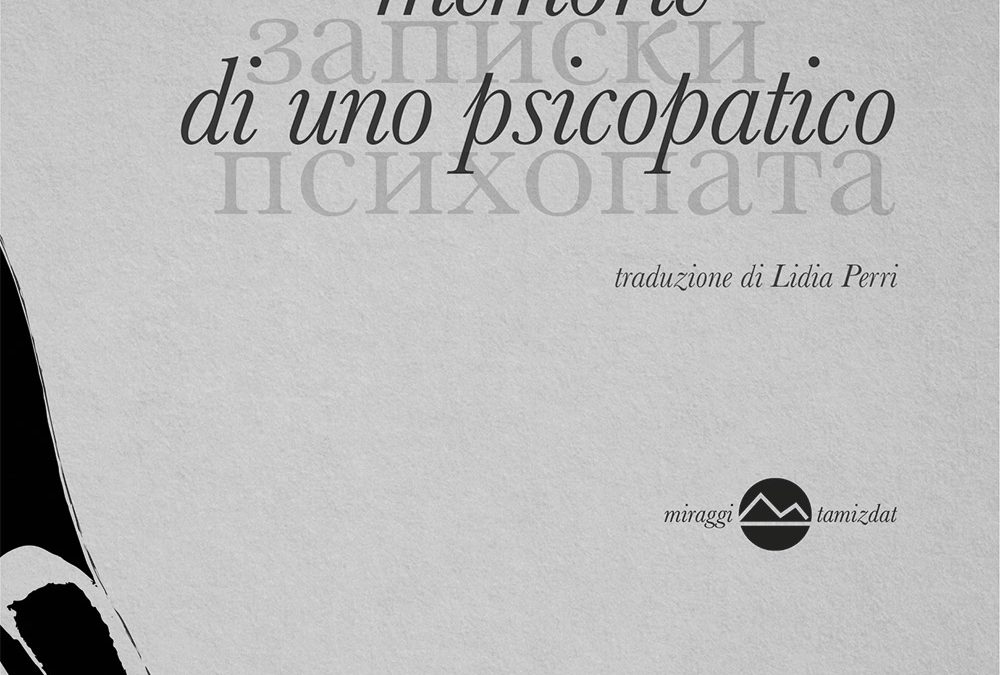Alcol, fumo, zuppa di cipolla e detersivi universali: di tutte queste cose insieme sapeva probabilmente l’interno russo in cui Venedikt Erofeev cominciò a scrivere le sue prime pagine. Non ancora diciottenne si era trasferito dalla provincia settentrionale della regione di Murmansk, ai confini della Norvegia, nella capitale russa, dove si era iscritto alla Facoltà di Lettere dell’Università, che prima lo aveva ammesso con lode e dopo pochi mesi lo avrebbe espulso per inadempienza degli obblighi militari. Giornate di ebbrezza, stordimento e desolazione, quelle che videro la scrittura di Memorie di uno psicopatico, pubblicato in questi giorni da Miraggi Edizioni con la traduzione di Lidia Perri. Un po’ era una questione personale: Venedikt cominciava a riconoscere dentro di sé una vocazione autodistruttiva che lo portava all’inconcludenza, alla paralisi, e faticava a gestire il flusso di scrittura con l’imponente mole di letture che da anni affrontava, mescolando generi, autori, passioni. Il risultato, in queste pagine giovanili (che però già contengono il gesto artistico che si ritroverà più tardi), è una matassa di pensieri interni, talvolta ostentatamente intervallati da puntini di sospensione – à la Céline – talaltra invece asciutti e cristallini come poesie: «E la luce brillava. Non era la sua luminosità a irritarmi. Ma la debolezza del sogno sulle tenebre. E io sputai. Sputai nel buio. E mi deliziavo del sibilo corrispondente. Di più non potevo fare». Un po’ però c’entrava anche la storia. Non era un anno qualsiasi per l’Unione Sovietica. Stalin era morto da tre anni, e in quel 1956, durante il XX Congresso del Partito Comunista, l’allora segretario Nikita Kruscev scoperchiò il sarcofago degli orrori, denunciando deportazioni e esecuzioni di massa in nome del culto della personalità del capo. Fu un anno di liberazione e sconvolgimento insieme, in cui un enorme numero di cittadini sovietici fece ritorno a casa e si vide finalmente riabilitato dall’accusa infamante di «nemico del popolo» (solo a Mosca rientrarono 200 mila detenuti politici). Il resto della popolazione, d’altra parte, realizzò di aver vissuto, per decenni, in un incubo senza eguali, in cui regnavano insicurezza, delazione, sprezzo degli affetti e morte. Ecco, se Erofeev può dirsi interprete di quell’epoca fosca ed eccitata, lo fu nel senso di intercettarne l’assenza di lucidità, la difficoltà nel «farsene una ragione» – la psicopatia collettiva, viene da dire. Come un potente getto d’acqua, nelle pagine giovanili di Erofeev si era riversata anche l’intera tradizione letteraria russa dell’Ottocento, che ha sempre trovato nella scrittura coscienziale, nella forma-diario, un’irresistibile valvola di sfogo. «Ti fa solo male leggere Dostoevskij – scrive a un certo punto Erofeev in Memorie di uno psicopatico – Sarai senz’altro così cupo, se ti rinchiudi in camera… là sentirai qualsiasi orrore… e tutto ti sembrerà cupo e orribile… Ti hanno detto bene… Ecco, tu odi il riso e guardi tutti come una fiera dal tuo letto… E sentiamo, che hai da lagnarti? Tu sei incomprensibile, diavolo… Insomma, tutti vivono bene, come persone normali… Non ti dimenticare che vivi nella società sovietica… e non in una qualunque». Un’appartenenza necessaria, quella russo-sovietica – e allo stesso tempo da espiare – sembra ammettere Erofeev nelle pagine che preludono alla sua grande opera unica, il Mosca-Petusky, pubblicato poi nel 1970. Ed è così che riga dopo riga, episodio dopo episodio – alcuni irresistibilmente comici, altri volutamente sconci – i discorsi da ubriachi perdono la loro sconclusionatezza e si trasfigurano, tanto che se l’occhio torna indietro, li ritrova preghiere.
Ultimi articoli
- Valeria Carletti e Antonio Di Martino a Deejay Summer Camp Aprile 15, 2024
- Bianca Bellová / Il potere della parola Aprile 15, 2024
- Lory Muratti ospite del NUOVO ROXY BAR di Red Ronnie con Dana Gillespie Aprile 5, 2024
- “L’Italia è la mia Atlantide perduta”, una conversazione con Bianca Bellová sul suo ultimo romanzo “L’Isola” Aprile 5, 2024
- Recensione a L’animale nella fossa su Casadeilettori.blogspot.com Marzo 24, 2024