«E così la rivoluzione è rimandata a tempo indeterminato». «Già» dissi, infilandomi l’ancia in bocca. «Per motivi tecnici, no?».
Questo scambio di battute rappresenta il fulminante incipit del romanzo I vigliacchi di Josef Škvorecký (Miraggi 2025, pp. 480, euro 26, prima edizione del 1958), bel botta e risposta tra il trombettista e il sassofonista tenore della jazz band di una cittadina cecoslovacca sospesa tra guerra e pace, liberazione e rivoluzione.
Ecco di che pasta è fatto un vero racconto jazz. Kazuo Ishiguro – uno che di letteratura dovrebbe intendersene- ha dichiarato al New York Times: «Non ho mai letto un buon romanzo sul jazz», poi continua censurando Jack Kerouac ed elogiando A sud del confine, a ovest del sole (1992) del suo connazionale Haruki Murakami. Un po’ poco per una musica che ha solcato da protagonista il Novecento. Gli autori che hanno nobilitato il jazz portano nomi altisonanti: Francis Scott Fitzgerald.
Julio Cortázar, Ishmael Reed, Michael Ondaatje, Geoff Dyer, il Nobel per la letteratura Toni Morrison. Di jazz è intriso il filone noir di autori adorati dalla critica come Cornell Woolrich, Jean-Claude Izzo o James Ellroy.
Adesso nel quadro della grande narrativa jazz entra di diritto Škvorecký, che in Italia fino a pochi anni fa avremmo contemplato solo per la novella Il sax basso (1967, edizione Adelphi 1993, fuori catalogo).
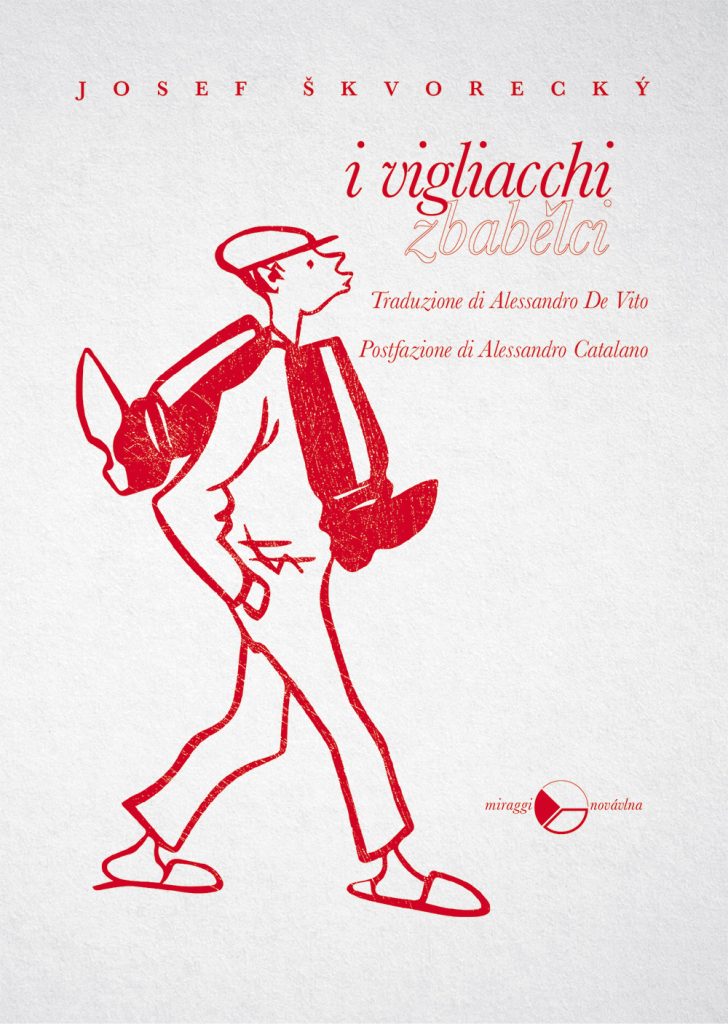
PAGINE
Una nuova traduzione dal ceco di Alessandro De Vito fa finalmente risplendere anche I vigliacchi di Škvorecký: un romanzo intenso, pubblicato da Rizzoli nel 1969 e poi abbandonato al suo destino. Adesso prende posto al centro della miglior letteratura jazz.
La trama: attraverso lo sguardo di Danny, sax tenore della jazz band, protagonista e alter ego dell’autore, rivivono gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale. Il conflitto, la resistenza, la rivoluzione, l’amore, le pulsioni sessuali e le inquietudini adolescenziali o esistenziali, la morale borghese, la patria, l’onore, l’amicizia, la religione cattolica… Tutto, ogni convenzione o potere costituito è visto con gli occhi disincantati di Danny che nel momento in cui si consuma lo snodo più drammatico del Novecento ha solo due cose per la testa: le donne e il jazz. Un dualismo altalenante, dove l’amore per Irena (e molte altre ragazze: dice Danny «l’amavo in mancanza di mercanzia migliore») cede spesso il passo alla musica.
Il jazz diventa senso e motore della vita, unico argomento che in tutto il libro rimane, se vogliamo, serio. Il resto passa attraverso un intenso processo di dissacrazione, con pagine divertentissime che raccontano ora le schermaglie d’amore ora le esercitazioni dell’improvvisato esercito di liberazione cecoslovacco. Chiese, partiti, scuole e istituzioni borghesi di ogni genere vengono bonariamente ridicolizzati dall’autore e ovviamente ricambiano. Danny è il fratello maggiore del Giovane Holden (1951): non solo perché ideato nel 1948 (anche se pubblicato dieci anni dopo), ma soprattutto in quanto punto focale di un groviglio di temi come amore, arte, guerra, morte e rivoluzione non semplici da maneggiare. Škvorecký danza su questi macigni con la grazia di Danny al sassofono.
Il confronto con Holden pare squilibrato perché Danny – rispetto al primo – si trova controvoglia a fronteggiare i tragici eventi della storia; proviamo allora a immaginare un parallelo con un altro personaggio emanato da uno scrittore europeo immerso nello stesso tema come il Beppe Fenoglio di Una questione privata (1963). Il protagonista è un ragazzo alle prese con la resistenza negli ultimi mesi del conflitto, studia l’inglese, ama la letteratura americana, il jazz e deve sciogliere il dubbio d’amore che lo attanaglia. Tante somiglianze ma esiti diversissimi: l’eroe di Fenoglio rimane austeramente piemontese e non abbandona mai il senso della «missione resistenziale» da compiere, le sue inquietudini sono puro male di vivere. Danny invece semina confusione, sottigliezze esistenziali. Tra i due il più americano è forse il Milton di Fenoglio che rimane comunque duro, mentre Danny riassume in sé tutte le contraddizioni, i pensieri alti e bassi e i sofismi della società europea di fronte all’inabissamento finale senza riscatto tra milioni di morti e cumuli di macerie.
GLI OTTO GIORNI
L’aspetto cronologico della storia riveste un ruolo primario: lo si deduce dai titoli dei capitoli che scandiscono in otto giorni l’arco narrativo tra il 4 e l’11 maggio. La fine della guerra. Ragioniamo sulle date: il 28 aprile è stato fucilato il «coraggiosissimo» duce degli italiani mentre tenta la fuga verso la neutrale Svizzera, il 30 mattina si toglie la vita Hitler che con i cannoneggiamenti russi a pochi metri dal bunker ha finalmente realizzato di aver perso. La notte dello stesso giorno la bandiera rossa sventola dal palazzo del Reichstag. Le sacche di resistenza dei nazisti si prolungano per alcuni giorni, fino al 2 maggio.
La resa mostra già i segni del futuro: rivalità militari, incomprensioni politiche e fusi orari fanno sì che si festeggi l’8 maggio in Stati Uniti e Regno Unito mentre per Mosca e altri paesi dell’Est l’anniversario viene proclamato per il 9 maggio. La rivolta e la battaglia di Praga si svolgono tra il 5 e il 12 maggio. Danny e gli amici coprotagonisti de I vigliacchivivono questo tempo sospeso dove l’oppressione della dittatura nazista è il passato mentre il futuro è rappresentato dalla rivoluzione o dalla normalizzazione. Sperimentano uno stato di frenetica attesa: che scoppi la rivolta contro i tedeschi o arrivi la rivoluzione, con i liberatori russi.
Le abiezioni della seconda guerra mondiale sembrano dietro le spalle eppure se nelle prime giornate (e pagine) del libro domina un sentimento di attesa, poi il tempo della storia risucchia i protagonisti nel suo vortice quando arriva comunque la guerra tra gli ultimi irriducibili nazisti e l’Armata Rossa. La seconda parte del libro sembra una discesa agli inferi anche se ancora domina lo humour. Solo la morte, con la propria insensatezza, accomuna nazisti, resistenti, vittime civili. Per cosa si muore ancora in quei giorni di maggio, quando le ceneri di Hitler sono fredde e tutto è finito? E come vivono i sopravvissuti, quelli che prima sono stati collaborazionisti o amici dei nazisti e ora cercano di rifarsi una verginità o i codardi in battaglia che poi diventano aguzzini con il nemico prigioniero e inerme? Danny e con lui il suo creatore hanno una risposta «swing» diversa dal conformismo, ma anche dal nichilismo. E il libro termina come è iniziato: con la jazz band che suona.
CLANDESTINI
Un certo Novecento ideologico non tollera bene l’esuberanza della musica nera. D’altro canto esiste un jazz europeo che negli anni del conflitto resiste alle pastoie della censura. Piccoli gruppi di appassionati si ritrovano segretamente per parlare di musica o suonare.
Questi incontri servono anche a scambiarsi i dischi di musica americana, proibita dal regime tedesco e da quello italiano e, in seguito alle invasioni, vietata anche in paesi occupati come la Francia e a est Polonia o Cecoslovacchia. Nonostante le imposizioni di regime, il jazz si sviluppa durante gli anni Trenta e Quaranta in modo clandestino, investendo l’intero continente occupato. I teorici del nazismo lo avevano bollato come Entartete Musik (musica degenerata), nel quadro della condanna di tutta l’arte d’avanguardia «negroide», da Stravinskij a Picasso.
Anche il boemo Škvorecký porta le stimmate della censura: il potere ufficiale comunista lo osteggia per anni. Quello che non va giù è il presunto qualunquismo del romanziere poco «impegnato», come il suo personaggio Danny che candido afferma: «Non avevo niente contro il comunismo. Non avevo niente contro nessuno, finché potevo suonare il jazz con il sassofono e guardare le ragazze».
Esule dopo l’invasione sovietica del ’68 quindi cittadino canadese e da lì campione della letteratura «dissidente zero» dell’ex patria, sua è la migliore analisi del rapporto tra jazz e dittatura in un paese passato, in meno di tre anni, dal dominio nazista all’influenza russa.
I regimi hanno nei riguardi dello swing un atteggiamento di condanna simile; ma lo Škvorecký saggista in esilio lo spiega in modo meno urbano: «Il jazz è sempre stato un bastone nel deretano di tutte quelle sanguisughe che, da Hitler a Breznev, si sono alternate al potere nella mia terra natia».
La Cecoslovacchia ha provato il peso di due regimi contrapposti sul piano ideologico, ma simili nell’atteggiamento verso la creatività. Racconta Škvorecký che un burocrate nazista aveva predisposto un decalogo di norme che le orchestre di musica da ballo dovevano rispettare per non incorrere nelle sanzioni della censura.
I punti dell’elenco sono ridicoli fino a sfiorare la stupidità. Il terzo impone che per quanto riguarda il ritmo, venga data preferenza alle composizioni veloci rispetto alle lente (i blues), anche se il tempo non deve «superare un certo grado di allegro commisurato al senso ariano della disciplina e della moderazione». Non sono permessi «gli eccessi negroidi». Il punto sette precisa che nel jazz si può suonare il contrabbasso solo con l’archetto, mentre si proibisce di pizzicare le corde. Anche questo andrebbe a discapito della sensibilità musicale ariana.
La storia del jazz nell’Europa dell’Est è funestata da vicissitudini inenarrabili che coprono tutti i ruoli in commedia, dal tragico al comico. Prendiamo Eddie Rosner, funambolico trombettista ebreo in fuga dal nazismo (la sua vita è descritta ne Il jazzista del gulag (2008) di Natalia Sazonova. Scappando verso Est Rosner attraversa Germania, Polonia e Bielorussia, per approdare alla Russia comunista dove viene soprannominato la «tromba d’oro» e all’apice della gloria si esibisce per Stalin. Poi il jazz in Unione Sovietica finisce al bando e lui si ritrova in un gulag, dove – ironia della sorte – gli chiedono di dirigere un’orchestra… jazz.
Tenta per anni di emigrare in occidente, continuando clandestinamente a fare musica sovversiva e quando finalmente può tornare in Germania Ovest, scopre la dura legge del mercato: lì il jazz è libero ma lui è stato dimenticato e muore povero, abbandonato da tutti. Una vicenda simbolo del jazz nell’Est europeo del periodo sovietico, quando era considerato un prodotto «dell’Occidente pervertito».
ENERGIA CATARTICA
Questa musica sopravvive perché incorpora un élan vital, un’energia creatrice «esplosiva», dall’effetto catartico. L’arte è moto dell’anima che si sottrae alle pastoie di regime. Solo quando il controllo degli ideologi e dei burocrati di partito diventa troppo pressante l’anelito vitale si trasforma in protesta. In Cecoslovacchia la situazione del jazz ha avuto diversi rovesci con l’oscillazione del governo tra moderate aperture e repentine chiusure, giustificando la durezza delle parole di Škvorecký.
Il critico Giampiero Cane nel saggio Le formiche e l’orso (1976) scrive che in Cecoslovacchia c’è un atteggiamento di ostracismo pervicace, passato senza soluzione di continuità dalla dittatura nazista al regime comunista.
Negli anni dell’occupazione tedesca, a Praga si pubblicava una rivista clandestina dal nome O.K. (Okruznì korespondence, corrispondenza circolare); quei pochi fogli, che potevano costare il campo di concentramento a chi ne era trovato in possesso, erano un bollettino che si occupava di musica swing. Veniva distribuita in un numero limitatissimo di copie nelle osterie di provincia dove si continuava a fare del jazz, stando attenti all’esercito tedesco. Il carattere di protesta politica della musica era solo la conseguenza dell’ostilità delle forze di occupazione naziste contro le composizioni ispirate al jazz e le canzoni straniere.
Finita la guerra, gli amatori del jazz cecoslovacco poterono uscire allo scoperto, pubblicare riviste, organizzare concerti, suonare.
Questo periodo di libertà durò poco: nel 1948 il governo comunista vietava nuovamente la musica jazz adducendo motivazioni diverse che celavano gli stessi scopi e si servivano degli stessi metodi. Il jazz tornò rapidamente nella clandestinità. La burocrazia osteggia l’organizzazione di concerti e la programmazione radiofonica, i sindacati di musicisti gestiscono ogni attività e qualunque altra iniziativa è illegale. Per i musicisti di jazz l’iscrizione al sindacato è impossibile. Di nuovo si torna alla «corrispondenza circolare» con lettere scritte, ad esempio, in esemplare unico per non incorrere nell’accusa di stampa proibita. Si tratta di bollettini informativi che aggiornano i pochi iniziati sui concerti clandestini in Cecoslovacchia e su ciò che avviene nel jazz in campo internazionale.
Contemporaneamente gli appassionati organizzano incontri negli appartamenti privati di qualche adepto per una jam session o per l’ascolto dei rari dischi.
Questo stato di cose si protrae oltre la destalinizzazione: il jazz rimane pericoloso per il regime fino all’avvento del rock’n’roll. Il pubblico giovane, quello che negli anni Quaranta ha costituito la base di massa dello swing, dagli anni Sessanta si rivolge al rock, più affine alle nuove esigenze. Il jazz diventa musica per pochi o per intellettuali e spaventa meno. Il regime ha un nuovo nemico: è la musica rock, che fa presa sui giovani ed eredita tutti i significati negativi che per anni erano pesati sul jazz. Il rock sprofonda nella semiclandestinità: tra concerti illegali e riunioni segrete; negli anni Settanta diventa la musica sotterranea della Cecoslovacchia e paga il peso della repressione oscurantista.
Il jazz negli anni Sessanta non acquista comunque la totale libertà anche perché l’organizzazione dei concerti e la produzione dei dischi sono di competenza statale.
Ad esempio a Praga il free jazz negli anni Settanta non è conosciuto perché i dischi di questo genere non vengono distribuiti, mentre il più effimero jazz rock circola senza ostacoli. Forse la libertà, anche solo in un’etichetta – free jazz significa pur sempre «jazz libero» – è comunque pericolosa.
ESULI
Dal coté culturale cecoslovacco, così ricco di fermenti jazzistici, escono eccellenti musicisti, a partire dai tre esuli di belle speranze che hanno sfondato negli Stati Uniti: Miroslav Vitouš, primo bassista dei Weather Report, il collega di strumento George Mráz, al centro del miglior mainstream del periodo nel trio di Oscar Peterson e nei gruppi di Stan Getz o Chet Baker e, per finire, il pianista-compositore della Mahavishnu Orchestra Jan Hammer, sbarcato in Usa per studiare a Berklee prima di entrare nell’orbita di John McLaughlin. Hammer diventa così «americano» da comporre la sigla del telefilm Miami Vice.
Meno noto ma dalla vicenda singolare Karel Krautgartner, clarinettista e sassofonista della vecchia guardia che muove i primi passi negli anni Trenta e suona nella Karel Vlach Orchestra. Lavora al Reduta Jazz Club di Praga con un proprio quintetto per anni e guida l’orchestra leggera della radio di Stato. Lascia il paese a malincuore dopo l’invasione russa del ’68, destinazione Vienna.
Václav Havel primo presidente nel 1989 della Cecoslovacchia post comunista e post muro di Berlino, è stato uno dei promotori di Charta 77, la più importante iniziativa di dissenso nel paese che deriva dall’omonimo documento firmato nel gennaio di quell’anno. Quel movimento aveva avuto tra i motivi scatenanti l’arresto dei membri di una band locale di musica psichedelica, i Plastic People of the Universe. La carta criticava il governo cecoslovacco per la mancata attuazione degli impegni sottoscritti in materia di diritti umani.
Nel gennaio del 1994 al club Reduta andò in scena una serata memorabile. Havel, allora capo di stato amante della musica, omaggiò Bill Clinton di un sassofono e questi lo suonò (non troppo bene a dire il vero) con il gruppo che sul palco stava conducendo una jam. Si trattava di soft power jazz, in salsa americana e non solo. Erano gli anni del crollo comunista e il capitalismo si presentava trionfante con la mitezza luccicante del tenore di Clinton. Anche uno stonato presidente che suona in un paese dove visceralmente si è amato il jazz – e dove Škvorecký ha creato i propri sassofonisti letterari – diventa simbolo della fine delle grandi narrazioni novecentesche.
QUI l’articolo originale; https://ilmanifesto.it/cecoslovacchia-rivoluzione-swing




