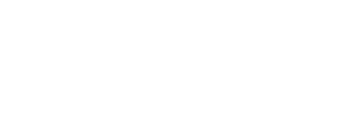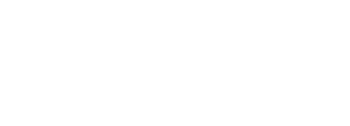Il bigliettino compare all’improvviso: “Provi a farsi vedere, è gratis!” con tanto di indicazioni del dottor Guido Klammermann, specialista, internista, immunologo, medico a tutto tondo. In effetti da un po’ di tempo Ulisse Orsini soffre di disturbi vari, soprattutto incubi molesti che gli impediscono di riposare come si dovrebbe. Sono tante e forse sono ovvie le ragioni del suo malessere: vive in un quartiere periferico di Milano, in via Giambellino, ed è disoccupato, diciamo che la vita non gli sorride e che questa sua precarietà gli porta ansia. Necessario dunque un urgente consulto medico. Lo studio del dottor Klammermann si trova in uno dei tanti palazzi in ristrutturazione di un’altra periferia degradata: un palazzone anonimo, senza tanti fronzoli, che non richiama nessuno stile architettonico specifico. Ulisse si incammina nell’androne e comincia a salire le scale, ma può solo ipotizzare che lì ci sia uno studio medico, visto che non ci sono targhette, indicazioni, regna piuttosto la polvere tipica di un edificio in stato di abbandono. Dalle scale fioccano piume: lo scenario è quasi inquietante, ma Ulisse non si lascia andare e prosegue finché non incontra su un pianerottolo una serie di malati che si accalcano fra materassi, sedie a rotelle. I pazienti sono caoticamente in fila, qualcuno seduto, qualcuno in piedi, tutti che si raccontano di un dolorino, un’artrite, una pressione strana sullo sterno. Finalmente appare una segretaria del dottor Klammermann che soccorre lo smarrito Ulisse chiedendogli però di prendere il numerino: anche in quel caos ci vuole un numero, c’è una progressione. Ulisse procede fra i malati finché non incappa in un paziente che ha una crisi: si sbraccia, chiede aiuto, ma viene bloccato dagli altri pazienti che gli urlano contro perché li sta disturbando. E poi Klammermann non è in studio, è un incompetente e non si presenta mai allo studio. Ulisse è in preda al panico, non gli resta che scendere velocemente in strada e dileguarsi nelle rovine della sua città…
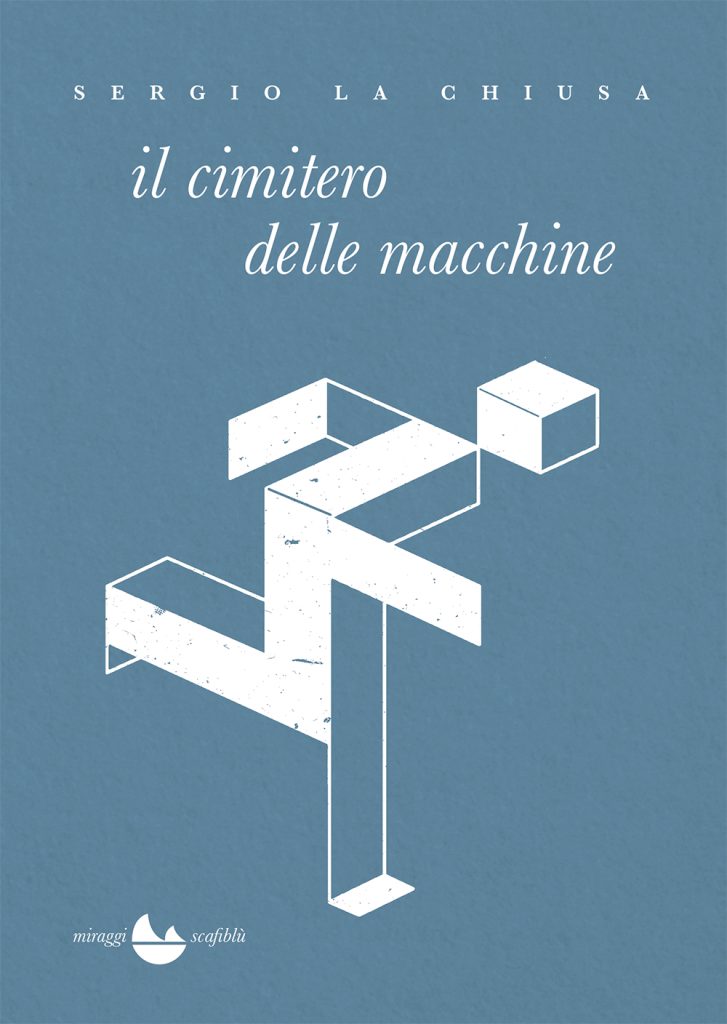
Dopo una felice esplorazione del rapporto con il padre (I pellicani. Cronaca di un’emancipazione, Miraggi 2019) e di quello con la madre (Madre nel cassetto, Industria & Letteratura, 2023), Sergio La Chiusa si dedica alla ricognizione della figura del figlio, ovvero del giovane. Il cimitero delle macchine è infatti la storia di un’odissea urbana, quella di Ulisse Orsini, appunto, nome che richiama tanto il protagonista del testo omerico, che Leopold Bloom di James Joyce. In effetti è la storia della peregrinazione di un giovane fra le macerie di una Milano periferica e precaria, ovvero fra le proprie ansie, le paure, ma anche le aspirazioni e le illusioni ormai sfumate. Ulisse è un disoccupato, è un emarginato di una società decaduta afflitta dal male di vivere, occupata a trovare Sergio La Chiusa lavora sul confine fra letterario e metaletterario: il suo testo è infarcito di citazioni implicite ed esplicite di modelli dialogici e visivi, come la plastica ripresa del Cristo che entra a Milano ricalcato su quello di James Ensor che entra a Bruxelles. La Chiusa vuole proprio che il suo romanzo sia un macrotesto che richiama altri autori, altre immagini, altri romanzi. Il tutto strizzando l’occhio al lettore, che viene spesso richiamato e rimesso in situazione: la narrazione per questo oscilla dalla terza persona alla prima persona, dal narratore onnisciente al punto di vista di Ulisse. Romanzo visionario e post-moderno, rompe diversi schemi anche se diventa quasi vittima, per converso, di una sorta di manierismo da canone inverso. Il plot narrativo decadente è una evidente metafora di una società a brandelli che si concretizza, in perfetto richiamo simbiotico, a metà via fra lo sguardo di Ulisse e il susseguirsi di situazioni post-apocalittiche.
QUI l’articolo originale: https://www.mangialibri.com/il-cimitero-delle-macchine