L’inesauribile questione dei rapporti tra opera e autore e tra autore e contesto, che si è a fatica districata nel Novecento tra frigido strutturalismo, critica storicista (marxista e post-) e letture psicanalitiche, incontra uno scoglio particolarmente aspro quando ci si imbatte in opere che trattano dall’interno il fenomeno estremo del lager. Ancor di più, poi, se si parla di quelle concepite nel lager stesso, ineludibilmente marchiate da contingenze tanto atroci da restituirne come monumentale la semplice esistenza. In tali casi, se richiesti di un giudizio di valore, ci si sente quasi obbligati a quell’atto della sospensione del giudizio di cui parlava, ma da un punto di vista morale, Primo Levi ne “I sommersi e i salvati”, riferendosi alla ‘zona grigia’ dei piccoli collaborazionisti ebrei, dei kapo, degli appartenenti ai famigerati Sonderkommando. Salvo poi registrare che i testimoni capaci di raccontare e dunque di svolgere l’insostituibile funzione sociale della memoria sono stati molto spesso proprio coloro che hanno militato tra quelle discutibili file, e che grazie ai minimi privilegi che il loro ruolo comportava, hanno conservato la vita. E con essa, talvolta, la voce.
Tale inquietante cortocircuito, che sembra adombrare il sospetto dell’arte/testimonianza nell’orbita-lager come correità, assume peraltro nel caso de “L’imperatore di Atlantide” (opera lirica composta da Viktor Ullmann e Petr Kien nel 1943-44, mentre erano prigionieri del ghetto di Terezín) una misura inaspettatamente calzante.
Alla breve opera in un atto e quattro quadri, della durata di un’ora circa, dedica ora un agile saggio il regista e critico teatrale Enrico Pastore (“L’imperatore di Atlantide o l’abdicazione della Morte di Viktor Ullmann e Petr Kien”, Miraggi Edizioni 2019), uno scritto pieno di non celato amore, e insieme strutturato con efficaci strumenti critici. Amore, perché l’autore confessa già in sede di prefazione di aver subito una fascinazione immediata per il lavoro, nato nel ghetto-lager ceco di Terezìn: ne era stato colpito durante gli studi universitari, aveva ipotizzato di farne l’oggetto della propria testi di laurea, e infine si è cimentato, dopo un lavoro teorico di studio di documenti e di viaggi di reperimento di fonti, nella sua messa in scena, seppure con i dialoghi parlati, in Italia e all’estero. Una lunga appassionata frequentazione, che però non tarpa mai le ali a considerazioni scientifiche, benché l’autore ritrosamente rifiuti per sé la definizione di «studioso di professione». Strumenti critici, si è aggiunto: perché a una ricostruzione storica sono affiancate, nell’architettura del saggio, l’analisi dell’opera, che occupa un buon quarto del libro, una lettura più strettamente musicologica della partitura, affidata a Marida Rizzuti, e l’edizione del libretto con testo a fronte (traduzione di Isabella Amico di Meane) che segue le poche ma significative varianti che ci sono pervenute, tra cui quella del finale – dell’opera è peraltro disponibile dal 2015 un’edizione critica.
È noto che Terezìn fu un campo particolare: organizzato nel 1941 come “ghetto degli anziani”, o “degli artisti”, divenne pian piano il volto, o meglio la maschera pseudo-umana, del disumano progetto di genocidio nazionalsocialista accelerato con la conferenza di Wansee e la Soluzione Finale. Era, o meglio doveva diventare per un momento ciò che si riteneva potesse essere accettato dalla comunità internazionale quando si affrontava lo spinoso argomento ‘condizione degli Ebrei nel Reich’. Terezìn fu infatti visitata in due occasioni dalla Croce Rossa e da rappresentanti di Svezia e Danimarca che, bene o male, caddero nella trappola ordita da Eichmann e collaboratori, per cui Theresienstadt (così fu rinominata Terezìn, con quel revisionismo toponomastico prurito delle dittature, da Stalingrado ad Agrigento) apparve agli inviati come ghetto modello, una «città donata da Hitler agli Ebrei». Una normalità di cartapesta, costruita per durare poche settimane, preparata nel modo e con gli accorgimenti che Pastore riporta, e visibile seguendo il link agli spezzoni superstiti di un “documentario” che fu girato su un set così accuratamente allestito, nel quale non poteva mancare la finzione di una vita culturale: caffè, scuole, concerti e opere liriche e di prosa di nuova composizione dovevano brillare agli occhi dei visitatori. Tra di esse il nostro Kaiser, l’altrettanto famosa Brundibar e un’esecuzione straziante del Libera me domine dal “Requiem” verdiano, con un’orchestra dai ranghi più volte falcidiati dalle improvvise deportazioni.
Ecco quale fu la temperie in cui prese forma l’opera di Ullmann e Kien, dei quali non manca l’appassionante ricostruzione biografica e a cui si tenta con acume di restituire uno spessore artistico e psicologico. Uno, musicista che il successo non aveva ancora sfiorato, psicologicamente provato da affanni privati e dalla condizione di perseguitato, entrato nell’orbita antroposofica e sostanzialmente prosciugato nella vena compositiva; l’altro artista visivo, assai più giovane, praticamente esordiente nella scrittura poetica.
Quanto all’opera, essa fu probabilmente proibita ancor prima della messinscena, dopo una prova generale che doveva rivelarne i caratteri intrinsecamente provocatori più che le forme e i modi schiettamente afferenti alla vasta galassia della Entartete Kunst, etichetta di cui fecero le spese Brecht, Hindemith, Schoenberg, Kokoschka, Grosz e infiniti altri, molti dei quali nati dal fertile e doloroso laboratorio della repubblica di Weimar – ma di tutto ciò conviene approfondire nelle pagine del libro e attraverso i richiami bibliografici.
Ecco, ciò è curioso e paradossale: che nella particolare situazione di Terezìn, quegli stessi autori che altrove sarebbero stati ridotti al silenzio, non solo sono tollerati, ma, poco per volta, vengono incentivati alla produzione artistica, in un contesto che, come nota Pastore, fa di Terezìn la città probabilmente più libera dal punto di vista creativo dell’intero Grande Reich. Il tutto pur mantenendo, tranne che nella prossimità delle visite internazionali, le usuali privazioni, a partire dalle razioni alimentari.
Ma il paradosso maggiore è un altro, ed è ciò a cui si faceva riferimento nella spericolata estensione della citazione leviana: e cioè che la libertà creativa che si è costretti ad ammettere nel ghetto-lager, era funzionale a un obiettivo il più antitetico a quella stessa libertà, ne era il più radicale capovolgimento, giacché fungeva da copertura allo sguardo internazionale per l’intero sistema dei campi di sterminio. Il tutto nell’assurdo metateatrale di un’opera scritta e messa in scena in una città a sua volta di finzione, che sarebbe stata di lì a poco spazzata via, con l’avvicinarsi del fronte orientale, insieme alle vite dei due autori, passeggeri di uno degli ultimi ‘trasporti’ verso est.
Le qualità del libro, agile nell’impaginato (136 pagine escluso il libretto con testo a fronte), sono soprattutto due. La prima è quella di riunire, riassumendole con garbo e spigliatezza, una considerevole mole di notizie sulle condizioni materiali del ghetto di Terezìn, nelle quali Ullmann e Kien hanno operato, attraverso testi più generali, tra cui l’irrinunciabile Hilberg e altri più particolari, accompagnati anche da qualche lacerto dell’essenziale “Theresienstadt 1941-1945” di Hans Günther Adler, tempestivamente pubblicato in tedesco nel ’55, recentemente tradotto in inglese ma di cui ancora manca una versione italiana.
Il secondo evidente pregio è invece il coraggioso tentativo di ricollegare in sede analitica ogni momento del Kaiser a un movente politico, con la chiara e spesso convincente tesi di farne un’opera coscientemente e persino apertamente ribelle, a partire dalla scelta della città di Atlantide quale ribaltamento del mito fondativo nazista di Gorsleben e Lindt-Lindenhoff per i quali era, in modo diverso, figura del Reich, passando attraverso dati cronologici citati nel libretto che si riferirebbero a contingenze storiche precise, per concludere col riconoscimento di citazioni all’interno del testo musicale riferibili a opere di compositori di origine ebraica: Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach. Né manca l’attenzione ai particolari, come l’accurata ricostruzione del nome di uno dei personaggi, Bubikopf, che alluderebbe al motto «Arish ist der Zopf, judisch ist der bubikopf», ariana è la treccia, ebreo il Bubikopf (taglio di capelli a caschetto, acconciatura evidentemente più espressionista che wagneriana).
Di contro, un punto debole potrebbe essere la tentazione, comprensibile ma a suo modo consolatoria, di “far quadrare il cerchio” percorrendo in avvio di ‘Conclusioni’ l’evitabile strada dell’etichetta: “Der Kaiser von Atlantis” costituirebbe un «mito» in un secolo, il XX, che, a detta dell’autore, non sarebbe stato in grado di proporne altri, a parte forse “Il signore degli anelli”. Senza entrare nel merito, l’inesausta analisi e il competente uso di fonti e testi avrebbero già reso il libro autoportante, senza bisogno del ricorso a un sigillo teorico che potrebbe suonare affrettatamente sistematizzante e correrebbe il rischio di offrire il fianco a una leva tale da mettere in discussione porzioni più ampie dell’opera.
Rimane a concentrare su di sé l’attenzione quel paradosso a cui si accennava, e così brillantemente suggerito, che trascina le vittime nella complicità e mette gli artisti davanti alla lacerante scelta tra il silenzio, tetro anticipatore della morte, e un’attività che, per quanto fin nell’intimo resistente, caparbia, antagonista, inevitabilmente si sporca di quel grigio stigma evocato da Levi. Contingenze inaudite, certo, quelle di Terezìn, tali appunto da sospendere il giudizio. Capaci però di consegnare a una penna altrimenti spuntata e a una voce ancora acerba un’imprevedibile fiammata di genio.

L’imperatore di Atlantide di Viktor Ullmann e Petr Kien. Testo tedesco a fronte
Enrico Pastore
Traduttore: Isabella Amico di Meane
Editore: Miraggi Edizioni
Collana: Janus-Giano
Anno edizione: 2019
Pagine: 208 p., Brossura
EAN: 9788833860329



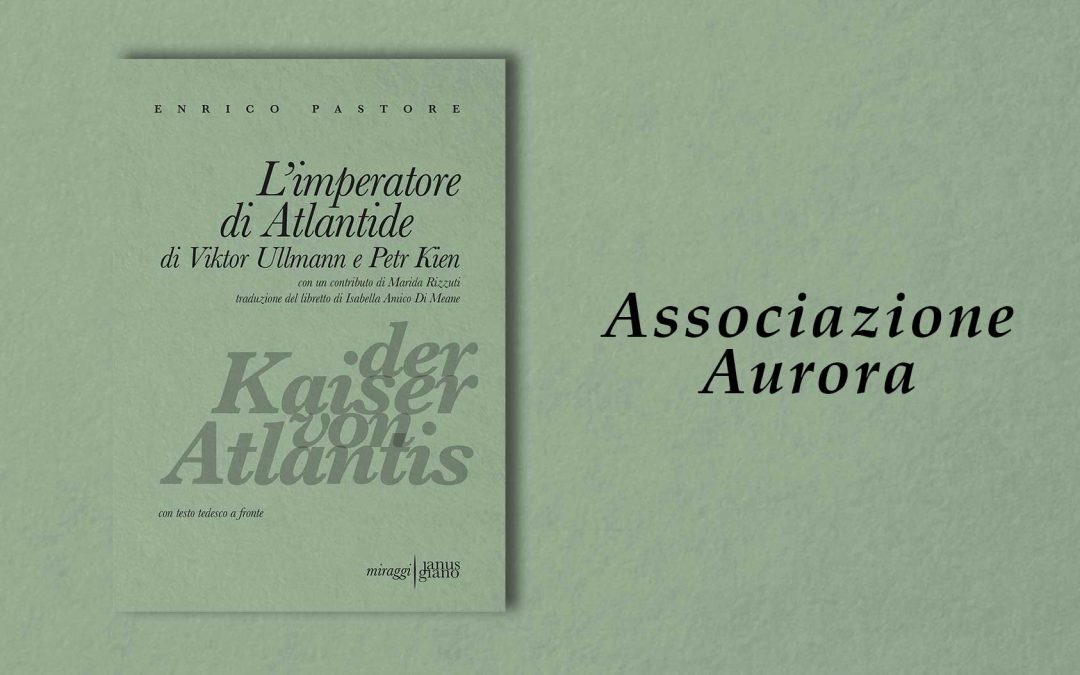




 E che c’entra Salvini? Boh, mi è venuto in mente, perché ce l’ha con i tedeschi e ci scassa la minchia con la questione di star fuori dall’Europa. Che però, si legga tra le righe, la storia gli da ragione: i tedeschi sono sempre i tedeschi, i soliti tedeschi, cattivi, che mai un Salvini potrebbe emularli: stiano tranquilli gli immigrati pertanto. Ma gli immigrati sono tranquilli, chi non è tranquilla è la sinistra (PD: può chiamarsi sinistra? ‘nsomma!!!); e poi ci siamo tutti noi, perché paradosso dei paradossi, Salvini, risulta essere la consecutio temporum dell’anti germanicità messa in atto dagli ebrei! Stupore? Prendetevela con Enrico Pastore, che a furia di scavare per trovare fonti ci ha messo in crisi!!!
E che c’entra Salvini? Boh, mi è venuto in mente, perché ce l’ha con i tedeschi e ci scassa la minchia con la questione di star fuori dall’Europa. Che però, si legga tra le righe, la storia gli da ragione: i tedeschi sono sempre i tedeschi, i soliti tedeschi, cattivi, che mai un Salvini potrebbe emularli: stiano tranquilli gli immigrati pertanto. Ma gli immigrati sono tranquilli, chi non è tranquilla è la sinistra (PD: può chiamarsi sinistra? ‘nsomma!!!); e poi ci siamo tutti noi, perché paradosso dei paradossi, Salvini, risulta essere la consecutio temporum dell’anti germanicità messa in atto dagli ebrei! Stupore? Prendetevela con Enrico Pastore, che a furia di scavare per trovare fonti ci ha messo in crisi!!!




 Il riferimento ai concerti sinfonici mi dà lo spunto per introdurre il libro che qui si vuole presentare. Si tratta di un documento di grande importanza e di un libro straordinario:
Il riferimento ai concerti sinfonici mi dà lo spunto per introdurre il libro che qui si vuole presentare. Si tratta di un documento di grande importanza e di un libro straordinario: