Tra i tanti libri che mi arrivano in visione da vari editori, spesso di genere, per fare cassetta, più o meno omologati, ogni tanto me ne capita tra le mani qualcuno fuori dagli schemi, bizzarro, spumeggiante, originale. E allora la vita mi torna a sorridere, provo la sensazione di stringere un gioiellino tra le mani e me lo tengo stretto. È il caso di questo romanzo: “Lo Straordinario” di Eva Clesis, pubblicato dalla piccola Las Vegas edizioni. Già il nome della casa editrice rimanda alla memoria un mondo scintillante e fibrillante di colori, gioiosità, brillantezza, dissolutezza anche. E la storia raccontata dalla Clesis è in perfetta sintonia con tutto ciò. Un romanzo fresco, giovanile, esuberante; quasi frenetico direi. Letteratura pura che non guarda agli indirizzi di mercato e se ne frega altamente, con la strafottenza propria di chi sa che, con una penna in mano, è in grado di conquistare il mondo. È incredibile cosa possa inventarsi uno scrittore dalla fantasia straripante, coma riesca a rendere verosimile una storia che nella realtà non potrebbe esistere. Eva Clesis, con leggerezza e delicata ironia, senza mai strabordare, senza mai volgarizzare, gioca con le infinite sfaccettature dell’animo umano per creare una storia che tende al magico realismo di stampo bontempelliano. I dialoghi sono frizzanti, con battute a effetto che inducono al sorriso, la trama solida, personaggi caratterizzati, tutto l’impianto narrativo regge alla perfezione. Un coro di voci in sintonia come un’orchestra, che sprigiona musica creata con le parole. Lea, la protagonista del romanzo, si è lasciata con il suo ragazzo, ha perso il lavoro presso una rivista di moda, sogna una carriera da giornalista d’assalto, ha una sorella gemella di successo e una madre che sembrano perennemente sapere come affrontare la vita, a differenza sua, che si trova in difficoltà ad ogni bivio. Lea è alla ricerca di una casa in affitto. Ne troverà una speciale; anzi “straordinaria”, in un condominio che sembra la proiezione dell’Eden sulla Terra: canone di affitto straordinariamente basso, sveglia al mattino col canto degli uccelli, musiche soavi e profumo di gelsomini, pavimento riscaldato, persino il frigorifero riempito di leccornie da mani misteriose; coinquilini gentilissimi e premurosi di esaudire ogni suo desiderio. È un sogno? O un incubo? Forse le premure sono un po’ troppe! Forse le invadenze sono eccessive! C’è qualcosa di stonato in tanta generosità. Un campanellino d’allarme si fa largo nella mente della ragazza. Lea sembra avvolta da una coperta calda che lentamente la stritola, fino ad asfissiarla. Non si raccapezza più. È andata a finire in una gabbia di matti? È vittima di un complotto? È caduta nelle mani di una setta satanica, decisa a immolarla durante un rito sabbatico? E poi c’è quell’uomo dagli incredibili occhi verdi che contribuisce a farle girare la testa. Come andrà a finire? Bisogna arrivare alla fine del libro per saperlo.
 Eva Clesis, non ho letto gli altri tuoi romanzi, ma questo l’ho trovato “straordinario”, di una grande forza. Mi è sembrato di cogliere la volontà di presentare o di deformare la società in cui viviamo attraverso un aspetto grottesco e paradossale. È così?
Eva Clesis, non ho letto gli altri tuoi romanzi, ma questo l’ho trovato “straordinario”, di una grande forza. Mi è sembrato di cogliere la volontà di presentare o di deformare la società in cui viviamo attraverso un aspetto grottesco e paradossale. È così?
Direi di presentarla, non di deformarla. La vita per come ho avuto modo di conoscerla io è spesso grottesca. Ci sono momenti di felicità, molti momenti di noia in cui ci impegniamo a costruire qualcosa, e la paura che basti un niente a portarci tutto via, perché forse intuiamo che la giustizia non è di questo mondo e perché esistono il dolore e l’incertezza. E, d’altra parte, siamo aperti al magico anche quando ci sforziamo di essere logici. Forse per questo la storia di Lea intriga. Condividiamo le sue incertezze e in parte abbiamo vissuto le sue sfortune: sappiamo che la fregatura è dietro l’angolo, soprattutto davanti ad atti di gentilezza. Ci è stato insegnato che i regali non esistono, eppure sogniamo che non sia (sempre) così.
Quanto è importante il senso dell’ironia nella scrittura e nella vita?
Direi fondamentale. Mio marito tempo fa mi ha detto che io sono quasi sempre una persona divertente. Non lo faccio per piacere agli altri, sono proprio così di natura. L’ironia è un po’ la mia forza, un po’ la mia corazza, e non a caso sono attratta anche dalle scritture brillanti, o con qualche guizzo di ironia anche se hanno trame piene di conflitti. Sono ironica anche con me stessa, non solo quando scrivo. L’ironia è un controcanto che mi ha permesso e mi permette tuttora di affrontare situazioni spiacevoli, a volte tragiche. Immagino che ci siano altri modi per vivere bene o scrivere meglio. Io, che spesso non trovo un senso nel vivere, tutelo il mio modo.
Esiste una scrittura al femminile? Ed esiste, a tuo parere, un pregiudizio che in qualche modo penalizzi i libri scritti dalle donne?
Esiste ed esisterà una scrittura femminile quando ci metteremo d’accordo su cosa voglia dire “femminile”. Poiché non trovo un significato univoco, non mi piace parlare di scrittura al femminile. Ci sono buoni o cattivi libri. Chi li scrive per me non conta un accidente. Considero inconsistenti i pregiudizi sui libri scritti dalle donne. “Scrivi come un uomo” è una cosa che mi dicono spesso. Mica ho capito cosa vogliono dire, però. E infatti quando lo chiedo mi danno risposte differenti, a parte due particolari. L’idea che la scrittura al femminile sia una scrittura sentimentale, e l’idea che la scrittura al femminile sia lagnosa o ombelicale. Ma io conosco tantissime donne che non sono né sentimentali né lagnose. Non capisco perché con una penna in mano dovrebbero cambiare carattere.
So che di recente è uscito il tuo ultimo romanzo: Amor, pubblicato da Miraggi edizioni. Ce ne vuoi parlare?
Amor è un romanzo per me molto sofferto. Può anche essere il mio ultimo romanzo, e in tal caso ne andrei comunque fiera. Vorrei che fosse letto da più persone possibili, perché dice qualcosa di diverso dagli altri romanzi, e lo dice in una lingua diversa. Infatti è un romanzo che possiamo definire esistenzialista. C’è una donna che si interroga sul senso che una serie di eventi tragici ha avuto sulla sua vita, e nel frattempo deve anche sparire, perché un pazzo la sta cercando. Se prima la sua depressione era una scusa per nascondersi, adesso è costretta a farlo. Ma come fai a identificare il tuo nemico se negli ultimi anni tutto ti ha fatto paura?
Sei mai stata in Sicilia? Se sì, che impressioni ne hai riportato?
Mi piacciono molto i siciliani e la Sicilia, ma la conosco a metà. Mi manca, e vorrei visitare al più presto, la metà che comprende Agrigento, Trapani e Palermo. Insomma, un bel pezzo! Sono stata invece più volte a Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Vivendo a Reggio Calabria da anni, considero Messina una città parallela alla mia città adottiva, la vedo praticamente ogni volta che passeggio sul lungomare, assieme all’Etna. Proprio stamattina ero tentata di fare l’ennesima foto del panorama siciliano al di là del mare. Dalla mia posizione la Sicilia è un’isola non isolata, amica, e con tanta bellezza e passione da offrire. Sono sempre contenta di prendere l’aliscafo e tornarci. Ma negli anni mi ricordo interminabili spostamenti, tra bus, treni e auto, e purtroppo in questo la Sicilia, come anche il mezzogiorno peninsulare, sono penalizzati. I meridionali vanno al nord facilmente, ma dal sud al sud è sempre un’impresa spostarsi.
Una volta ho conosciuto un tizio californiano che aveva dei parenti siciliani da parte del padre, a Noto. Ma essendo orfano pensava di non poterli rintracciare, mentre per me non esisteva cosa più triste di avere origini siciliane e non essere mai stati in Sicilia. Alla fine riuscii a metterlo in contatto con loro. Gli traducevo le loro lettere e ai parenti traducevo le sue, e alla fine decise di andarli a trovare. Nonostante non si capissero, l’ospitalità e il calore di quella famiglia ritrovata lo commosse moltissimo: scoprì l’infanzia di suo padre, la sua storia prima dell’America, i suoi luoghi, i sacrifici dei genitori per farlo studiare. Al ritorno mi scrisse che quel viaggio, restituendogli il passato di suo padre, gli aveva cambiato la vita.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:












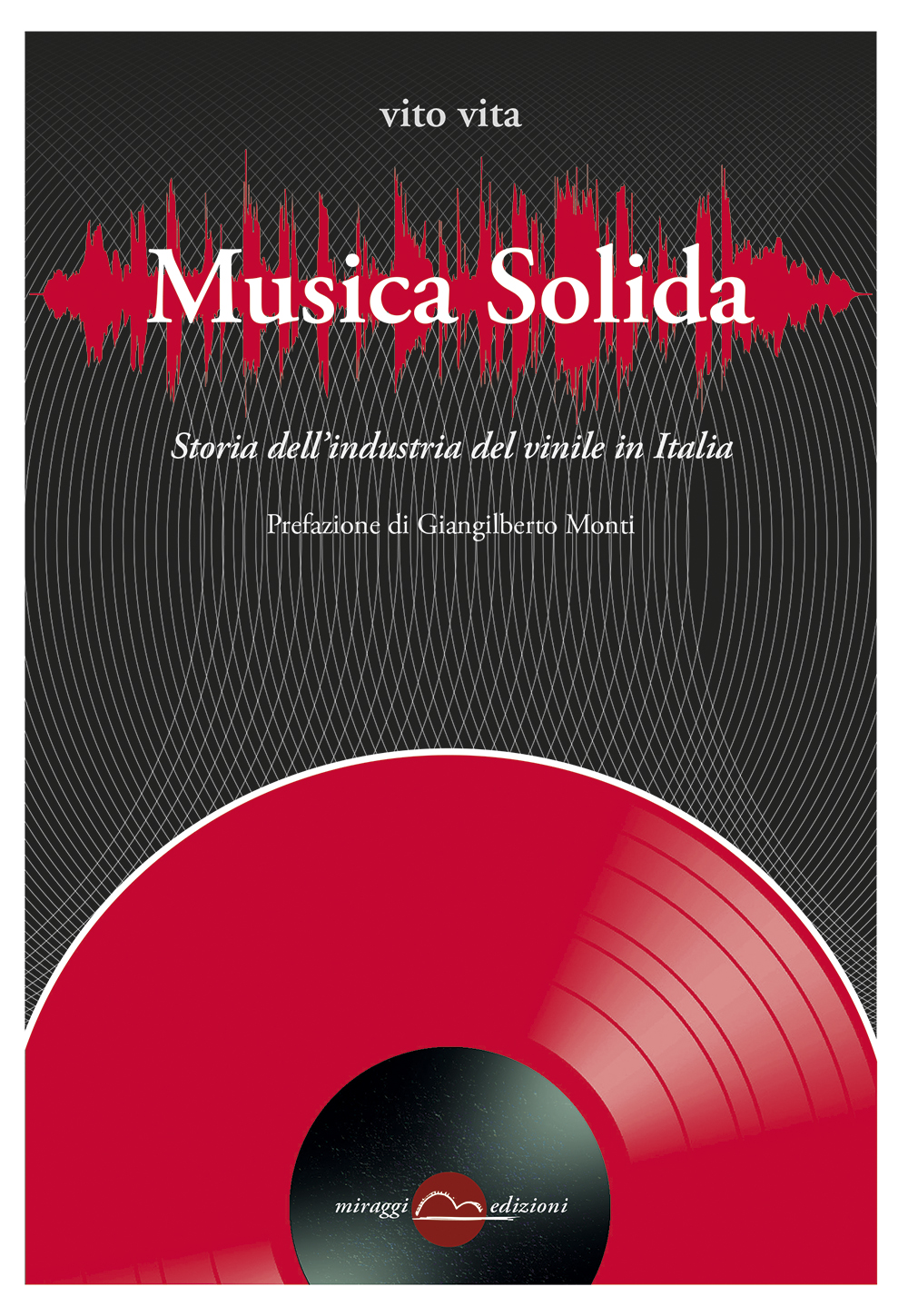





 Buongiorno Daniela! Grazie di essere con noi di LiveCinema&Libri; le congratulazioni sono d’obbligo, per il bellissimo risultato di essere arrivata in finale con il tuo romanzo Matelda cammina lieve sull’acqua, al premio Un libro per il cinema, edizione 2019. Vorremmo conoscere tutto di te, della tua vita da scrittrice, o almeno il possibile, adesso: perciò, che cosa ti ha spinto a diventare scrittrice? Qual è stata la scintilla che ti ha messo davanti un foglio di carta, o una tastiera del PC per cominciare a scrivere?
Buongiorno Daniela! Grazie di essere con noi di LiveCinema&Libri; le congratulazioni sono d’obbligo, per il bellissimo risultato di essere arrivata in finale con il tuo romanzo Matelda cammina lieve sull’acqua, al premio Un libro per il cinema, edizione 2019. Vorremmo conoscere tutto di te, della tua vita da scrittrice, o almeno il possibile, adesso: perciò, che cosa ti ha spinto a diventare scrittrice? Qual è stata la scintilla che ti ha messo davanti un foglio di carta, o una tastiera del PC per cominciare a scrivere?



 Il tuo successo non annunciato, lo è però diventato: è anche il tuo esordio?
Il tuo successo non annunciato, lo è però diventato: è anche il tuo esordio? «Scrivo per quell’esigenza spietata di raccontare una storia, inventare, creare luoghi, personaggi e azioni. Credo che creare qualcosa sia una delle più grandi soddisfazioni della vita, c’è qualcosa di divino nel creare, è come se l’essenza divina si mescolasse all’uomo.
«Scrivo per quell’esigenza spietata di raccontare una storia, inventare, creare luoghi, personaggi e azioni. Credo che creare qualcosa sia una delle più grandi soddisfazioni della vita, c’è qualcosa di divino nel creare, è come se l’essenza divina si mescolasse all’uomo.


