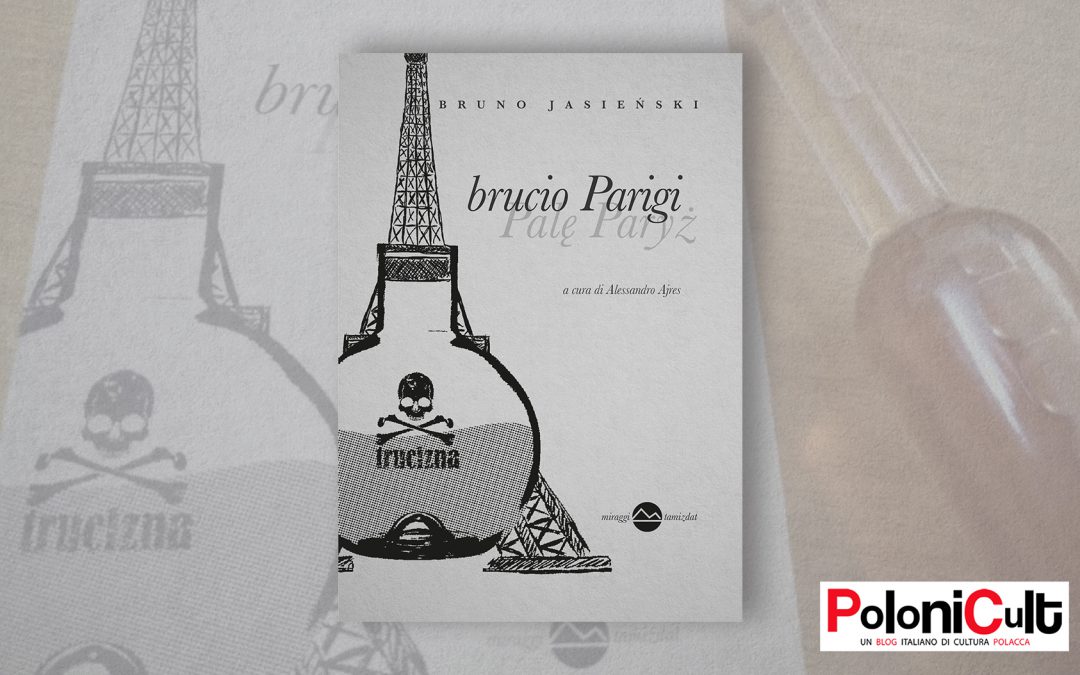
Gen 14, 2020 | RECENSIONI
BRUCIO PARIGI – MANIFESTO RIVOLUZIONARIO DI UN FUTURISTA POLACCO
A novant’anni dalla sua prima uscita, arriva finalmente in Italia un romanzo polacco che ha scandalizzato la Francia

E vengano dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!… Suvvia! date fuoco agli scaffali delle biblioteche!… Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!… Oh, la gioia di veder galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!… Impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite, demolite senza pietà le città venerate!
Chissà cosa devono aver pensato i borghesi parigini la mattina del 20 febbraio 1909 sfogliando la copia appena acquistata di Le Monde. Perché proprio quel giorno, lo storico quotidiano francese ospitò questa e altre affermazioni incendiarie, provocatorie e violente firmate da un poeta italiano ancora poco noto e sotto un titolo che annunciava un movimento nuovo sulla scena letteraria: Manifesto del futurismo.
Sappiamo bene invece cosa pensarono quegli stessi borghesi parigini quasi vent’anni dopo, nel 1928, quando sulla rivista L’Humanité apparve a puntate un romanzo ispirato da quei concetti di futurismo e che parlava della distruzione della città venerata per definizione, la loro Parigi. Sdegno, raccapriccio, e la volontà di cacciare l’autore di quell’opera così dissacrante. Il libro in questione si intitolava Palę Paryż, era firmato da un polacco che si faceva chiamare Bruno Jasieński e oggi finalmente possiamo leggerlo in italiano, nella traduzione di Alessandro Ajres uscita per i tipi di Miraggi edizioni, con il titolo di Brucio Parigi.
Quando pensiamo al futurismo, noi italiani pensiamo subito a Marinetti e a un movimento artistico bruciato di un ardore intenso e consumatosi in fretta, stinto poi mestamente in un entusiasmo demenziale per la parabola mussoliniana. Dimentichiamo l’esistenza del futurismo russo che ha regalato alla letteratura mondiale l’estro dinamitardo di Majakovskij o le visioni siderali di Chlebnikov. Ancora di più dimentichiamo l’esistenza di altri futurismi, come quello polacco di cui proprio Jasieński è stato uno degli ideatori.
Gli anni Venti e Trenta del ventesimo secolo sono stati in Polonia un periodo di fervore letterario e della grande esplosione delle avanguardie. Il motivo è semplice: dopo l’ottenimento dell’indipendenza del 1918, gli intellettuali polacchi si erano finalmente liberati del ruolo di cantori patriottici che il romanticismo gli aveva lasciato in eredità, e poterono finalmente dedicarsi alla sperimentazione, alla provocazione, all’edonismo e anche alla militanza politica.
Jasieński era uno di questi. Da figlio di un ebreo assimilato e studente spiantato all’università di Cracovia, l’avvicinamento alla nascente ideologia comunista fu quasi automatica per lui. E arrivarono le tappe obbligate di un poeta futurista e giovane rivoluzionario di quegli anni: il teatro, i recital di poesie, le provocazioni, gli arresti. Jasieński era un comunista convinto, ammaliato dal fascino della rivoluzione, cresciuto leggendo Majakovskij, e lo sarebbe rimasto fino alla fine (ci arriveremo).
Nel 1929, non ancora trentenne, Jasieński si sposa, lascia Cracovia e va a vivere a Parigi. In Francia organizza circoli teatrali per i locali operai polacchi e fa da corrispondente per alcuni giornali. Non guadagna quasi niente, sopravvive a stento, matura per Parigi un sentimento oscuro che, unito alla sua missione politica, è alla base di Brucio Parigi.
La trama del romanzo è semplice e diabolica: un giovane operaio di nome Pierre viene licenziato dalla fabbrica dove lavora, viene sfrattato da casa e abbandonato dalla fidanzata Jeanette. Passa qualche giorno da senzatetto e poi viene arrestato per aver partecipato a dei tafferugli, fino a che alla fine non trova un nuovo lavoro come custode dell’acquedotto cittadino. Ed è da questa nuova posizione che Pierre matura il suo diabolico sogno di vendetta: dal laboratorio chimico dove lavora un amico, ruba una fialetta piena di batteri letali e la versa nell’acquedotto, iniziando un’epidemia che si diffonderà per tutta Parigi.
Nel giro di poche settimane, la capitale francese è presa dal caos. Agli abitanti è fatto divieto abbandonare la città per evitare di propagare ulteriormente la malattia e la città si trasforma in un enorme lazzaretto dove i gruppi sociali si trasformano in vere e proprie comunità combattenti. Un gruppo di comunisti cinesi, uno di ebrei guidati da un rabbino, gli emigrati russi e persino i francesi stessi, divisi tra repubblicani orfani della Comune e nostalgici della monarchia, prendono le armi gli uni contro gli altri occupando i rispettivi quartieri come piccoli fronti di guerra. Parigi così si consuma e muore lentamente, bloccata dentro i suoi confini e destinata a mostrare al mondo le ipocrisie imperialistiche del mondo capitalista. Gli unici rimasti immuni, per caso, al contagio sono i detenuti di un carcere riservato ai prigionieri politici. Sono perlopiù comunisti incarcerati che si ritrovano improvvisamente liberi dopo che le guardie muoiono una dopo l’altra e si aprono a una Parigi irriconoscibile. Quando capiscono cosa sta succedendo, rifondano la Comune prendendo facilmente il controllo della città dilaniata, trasformando Parigi in un Soviet ma tenendolo segreto al mondo esterno fino al giorno fatale in cui annunciano al resto della Francia quello che è successo e si preparano a espandere la rivoluzione e il verbo dei Soviet.
Agli occhi di un lettore contemporaneo, Brucio Parigi ha degli elementi che non si possono che definire ingenui, specie alla luce del destino delle rivoluzioni tentate a più riprese in Occidente e a quella dei fallimenti del socialismo reale in Urss e nei Paesi satelliti. Di certo non aveva lo stesso sapore in bocca ai parigini di allora che lessero terrorizzati questo romanzo e costrinsero Jasieński a lasciare la città e la Francia. Se filtrato nella sua prospettiva storica e ideologica, e se concediamo all’autore alcuni risvolti narrativi un po’ ingenui e dovuti a una stesura durata soli tre mesi, leggiamo in Brucio Parigi un romanzo dissacrante nei contenuti e straordinariamente interessante nella forma.
Quello che colpisce maggiormente sono delle fiammate di prosa geniale, tracce di una formazione da poeta futurista, con le quali Jasieński racconta Parigi e che ad Ajres va dato merito di avere tradotto con soluzioni molto efficaci. Concentrate soprattutto nella prima e nella terza parte di Brucio Parigi, alcune descrizioni di Parigi restituiscono un ritratto della città ben diverso da quello che tradizionalmente si fa della capitale francese. La Parigi di Jasieński è cupa, avvolgente, geometrica, alienante e ostile alla vita.
E la città che misuriamo ogni giorno si trasforma in perline di immagini distaccate, che fissano il nostro sguardo sulla pellicola della memoria. Esse si fondono in noi in un’idea uniforme della città dopo essere state infilate sul filo invisibile dei nostri passi sparsi, e formano la nostra mappa sfuggente di Parigi, molto differente dalle Parigi degli altri, che percorrono come noi le medesime strade (p. 25)
Strade lunghe e flessibili si moltiplicavano, si allungavano nell’infinità come una fune di gomma legata a una gamba; fuggivano da sotto i piedi come lucertole nei riflessi delle luci sfuggenti; ammiccavano consapevolmente dal buio con gli occhi di migliaia di alberghetti a ore (p. 29)
Il muro scricchiolava e oscillava. Il fiume innalzato dai corpi, da banconote, azioni, bottiglie, sforzi, lampade, chioschi, gambe, con un’onda rigonfia passava sopra i tetti con boati e tumulti. Dalle fauci spalancate degli alberghi, come cassetti degli armadi con le porte aperte, si spandevano materassi secolari, stantii, insonni, che crescevano e s’innalzavano come una gigantesca Babele di cento piani, dai gradini che parevano molle (p. 42)
L’estetica di Jasieński in questa prima parte sembra più simbolista che futurista, nel suo approccio scettico alla città e nel timore che essa evoca. È dovuto senz’altro alla visione che Jasieński aveva di quella Parigi capitalista vicina al collasso e alienante agli occhi di un operaio. Più genuinamente futurista, nella sua furia di distruzione, è il racconto, e l’idea stessa, di Parigi decimata e distrutta, baccello di una grande rivoluzione:
Nel silenzio mortale della città estinta, lungo il viale muto si spostava quello strano corteo, una manifestazione di gente deperita, dalle teste rasate, nelle grigie casacche della prigione, senza striscioni, con la bandiera rossa con il sole levata in alto sopra le teste; mentre negli anfratti vuoti delle viuzze quella canzone di vendetta risuonava stranamente minacciosa. La canzone dell’ultimo assalto colpiva con il proprio ritornello come il calcio di una pistola contro finestre chiuse e vuote. (p. 312)
Alla vista che si presentava davanti ai propri occhi la folla rabbrividì, come se una zampa fredda di terrore avesse toccato il suo cuore scoperto.
Nelle verande dei bistrot, sulle sedie intrecciate, sui marciapiedi e per la strada, in pose deformi e indecifrabili, così come li aveva trovati la morte, giacevano cadaveri umani che iniziavano a puzzare. (p. 313)
Ai lettori che troveranno Brucio Parigi in libreria dico di pensarci poco, svegliarlo in fretta e portarlo a casa. Non ci troveranno una trama travolgente da romanzo catastrofico scritto da sceneggiatori di Netflix per arrotondare né riflessioni fataliste nello stile di Jonathan Franzen quando la mattina si sveglia particolarmente male. Mi permetto di dire: per fortuna. Ci troveranno in compenso una Parigi che non hanno mai visto in nessun altro libro, l’attenzione alla bellezza della prosa che solo certi poeti sanno dare e che i nostri tempi di romanzieri professionisti hanno perduto, la genuinità di una brama rivoluzionaria che negli anni Trenta era sincera, mirata e che è stata tradita nel modo più tragico quando Jasieński nel 1938, da nuovo cittadino sovietico, ha pagato il prezzo di credere più al comunismo che a Stalin ed è finito fucilato a Mosca, vittima delle purghe e della rivoluzione tradita a cui aveva dedicato la sua intera vita.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:
Brucio Parigi – manifesto rivoluzionario di un futurista polacco

Gen 14, 2020 | RECENSIONI
LA PIANURA DEGLI SCHERZI DI OSVALDO LAMBORGHINI: RISCOPRIRE UN MAESTRO TRA SESSO E VIOLENZA
Il nome di Osvaldo Lamborghini potrebbe non dire tanto al lettore medio italiano, ma dovrebbe suonare invece familiare agli indagatori più scrupolosi della letteratura sudamericana. Durante un’intervista ho avuto modo di chiedere ad Alan Pauls, uno dei massimi autori argentini dei nostri giorni, quali libri e quali autori gli avevano fatto capire come raccontare un Paese estremamente complesso come la sua Argentina. Tra le sue influenze personali, in mezzo a nomi e titoli più conosciuti, spiccò Il fiordo: un testo molto breve scritto proprio da Lamborghini.
Quel Fiordo che non era edito in Italia fino alla pubblicazione de La pianura degli scherzi, il libro con cui questo autore arriva nel nostro panorama grazie all’editore Miraggi e al lavoro di cura e traduzione di Vincenzo Barca e Carlo Alberto Montaldo. Una proposta editoriale non immediata, ostica, per alcuni aspetti scomoda, che necessita di essere contestualizzata, tanto coraggiosa quanto indispensabile. Una raccolta di quattro romanzi brevi di difficile classificazione, attraverso cui scoprire una delle voci più inafferrabili della seconda metà del secolo scorso.
Partiamo dal contesto storico: dobbiamo immaginare la Buenos Aires tra gli anni ’60 e ’80. Nel ‘73 Juan Perón era tornato dall’esilio ed era ritornato protagonista con un’efficace formula patriottica di stampo socialista. A una iniziale ricrescita economica seguì il suo tramonto definitivo ed ebbe inizio un marasma sotterraneo di sparizioni, continui golpe e giunte auto-incaricate per ristabilire un ordine politico-sociale sempre più precario. In questo clima Osvaldo Lamborghini raccontò la sua Argentina, la sua polveriera. Il fiordo, nel ’69, veniva venduto su richiesta in una sola libreria di Buenos Aires. Un testo che, oltre ad alimentare un vero e proprio mito, può essere considerato al tempo stesso l’esordio e l’apice più alto di tutta la scarna produzione di altissima qualità che Lamborghini produrrà nei 25 anni successivi.
«Un’orgia di sesso e violenza politica», questa la definizione di Alan Pauls. Definizione accurata, ma c’è dell’altro. Nel racconto violento di un’orgia frenetica, il fiordo riuscì ad anticipare tutta la letteratura politica che avrebbe caratterizzato l’Argentina nei decenni successivi. Solo un autore fu in grado di essere ancora più anticipatore tanto che, durante l’immersione lamborghiniana, non sarà difficile ripensare a Roberto Arlt (1900-1942) e alle sue narrazioni allegoriche.
Allora, il Folle Rodríguez, nudo, con la terribile frusta attorno alla vita – il Folle Rodríguez, padre di quello sgorbio infingardo, precisiamo –, piantava i suoi gomiti nel ventre della donna facendo sempre più forza. Eppure, Carla Greta Terón non partoriva.
L’immagine che apre Il fiordo è quella del parto di Carla Greta Terón, la compagna del Folle Rodríguez, un uomo sadico che sta favorendo la nascita del figlio. La violenza del Folle rispecchia il clima che la città respira fuori dalle finestre dell’appartamento in cui, nonostante le urla della donna, si sta verificando un’orgia.
In questa scrittura, in questa forma schizofrenica, il significato (così come il nascituro) non trova né luce immediata né vita facile. Tutto è metafora, tutto ha un significante distorto, mutilato, seviziato. Basti osservare la stessa Carla Greta Terón, le sue iniziali e l’acronimo che si andrà a formale: C.G.T., Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Allo stesso modo il fiordo, l’insenatura costiera che il lettore osserverà sempre da quella finestra, si farà metafora e critica della società del tempo (tra grida e sevizie, così come spesso fu la politica di Perón). Questa pianura degli innumerevoli scherzi è una bandiera che viene conficcata in una spalla con fare sornione, senza nascondere l’onore di un gesto così estremo, capace di unire il dolore provato alla gioia, al simbolo della lotta. Inutile nasconderlo: la letteratura di Lamborghini è ostica, stratificata. È sua intenzione scrivere testi caratterizzati da architetture narrative definite in un sistema di spazi ristretti grazie a un lavoro di cesello, di precisione.
César Aira racconta di come Lamborghini avesse sempre sostenuto che i romanzi lunghi dessero come risultato una frase, un’esclusiva piccola frase molto bella. Evidentemente non abbastanza per osservare il mondo. Quel mondo descritto con una lingua caotica in cui forme dialettali e varianti alte e basse di uno o più idiomi sono pronte a coesistere nella scrittura di un autore abituato a riempire fogli e fogli di parole casuali per poi poter studiare i collegamenti nascosti tra di esse. Significativa anche la vicenda di Porchia contenuta in Sebregondi Retrocede, il testo più criptico dell’autore argentino. Romanzo breve del ’73, al cui centro figura un marchese omosessuale e cocainomane e i suoi incontri tra donne, bambini e personaggi eccentrici. Tra questi vi è anche l’enigmatico Porchia, un vecchio operaio in pensione dedito a scrivere un’opera costituita esclusivamente da frasi zen, del tipo «prima di seguire il mio cammino, io ero il mio cammino».
Il romanzo era nato come una raccolta poetica e fu modificato, dopo una lunga e combattuta discussione con l’editore, per allontanarlo dall’ermetismo proprio della poesia stessa, che però popola (forse) ancora questa trama di incontri indefinibili. Anche qui non manca l’anima politica, ma spicca con maggior chiarezza la violenza sessuale, la tradizione di De Sade unita ad alcune atmosfere kafkiane, senza dimenticare il vero e distintivo lato lamborghinano: quello psicologico. La psicologia e l’etica dell’uomo saranno anche le colonne portanti de La causa giusta. Ancora una volta una trama borderline: la vicenda di un culo grosso e di un discusso atto orale disputato tra uomini. Nel mezzo, la scala delle gerarchie politico-sociali tra amore e morte.
Tra queste pagine si ride, si ride tanto. In alcuni frangenti potrà sembrare di osservare un tavolo al quale Juan José Saer e Witold Gombrowicz discutono con naturalezza di bassifondi, così come dei massimi sistemi, fino ad arrivare a Hegel. Lamborghini è un papà di Saer, un fratello di sangue di Gombrowicz.
Ne Le figlie di Hegel, scritto da Lamborghini nel periodo della sua convalescenza a Mar de la Plata, prima della sua morte prematura (avvenuta nel novembre del 1985), ritorna anche il filosofo tedesco e lo fa in una sorta di testamento travestito da romanzo.
Quanto alla letteratura, io preferisco i limpidi turbinii di José Hernández (di nuovo: effettivamente sono maledetto e pazzo – come un pazzo – a tal punto). Sono effettivamente stregato e la pagherò presto e cara, con la mia stessa collottola. Quanto alla letteratura, preferisco il sistema di incisioni non programmato di Horacio Quiroga, non programmato, però, buco dopo buco, ogni gesto dà subito inizio a un movimento, si avvolge in un suicidio, salta come una molla e precipita, inesorabile, verso la sparizione di “un soggetto”; perché il suo eterno movimento vorticoso porti la piaga della risurrezione.
Questo dice la voce narrante, una voce sovrapponibile a Lamborghini stesso. Una prima persona che parla con sincerità partendo dalla sistematizzazione del reale di Hegel, secondo il quale la realtà si riduce a spirito in un continuo movimento. Nel delineare il suo ultimo racconto di pazzia e di prostituzione, Lamborghini crea una sua realtà composta proprio da quelle donne ai margini della società e dalla classe operaia. Non sarà quindi un caso veder figurare il 17 Ottobre in questa narrazione-testamento, la data della nascita del peronismo tanto sentita dagli operai argentini.
Tra il sesso e la violenza dell’autore argentino si inserisce l’attenzione alla politica, affrontata sempre con un taglio che arriva dai grandi filosofi e le grandi opere di spiccata argentinità lette in vita dall’autore. Penso al Facundo di Domingo Faustino Sarmiento o a Una excursión a los indios ranqueles, una cronaca giornalistica di una spedizione fatta dal generale Lucio V. Mansilla per negoziare un accordo di pace con gli indios ranqueles. Testi ottocenteschi con una spiccata componente politica, poco conosciuti in Italia ma indelebili nella formazione del Lamborghini lettore. I meccanismi politici vengono analizzati servendosi del lato famelico e violento del sesso. La violenza sessuale veicola queste narrazioni, i rapporti della società del tempo e solleva dagli uomini il mantello della bugia attraverso il gioco letterario.
Leggere Lamborghini significa scoprire una voce capace di muoversi tra poesia, teatro e prosa. Un uomo, forse distorto come tanti dal suo alone di maledettismo, che si assicurava con un fare approssimativo le minime condizioni di sopravvivenza, spostandosi come ospite indesiderato tra case di parenti e amici. Venne tacciato più volte di infantilismo, di essere un bohémien perso in una realtà che affrontava con troppa immaturità. L’infantilismo non faceva però parte di Lamborghini, a lui, come ai suoi personaggi, il racconto dell’infanzia e dell’innocenza non è mai appartenuto.
Con La pianura degli scherzi ci viene restituita la voce di un maestro, di chi è riuscito a forzare con il suo estremismo ogni confine letterario, agganciandosi con le sue provocazioni ai significati più nascosti della realtà che ha vissuto e che ancora oggi è di grande interesse. Il libro non ci restituisce solo l’Argentina del suo periodo, ma la combinazione per aprire la porta della letteratura più fine e disturbata del Novecento.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:
http://www.altrianimali.it/2019/11/29/la-pianura-degli-scherzi-osvaldo-lamborghini-riscoprire-un-maestro-sesso-violenza/

Dic 5, 2019 | RECENSIONI
IMMEDIATAMENTE
A cura di Anna Cavestri
Con la traduzione di Francesco Forlani, Miraggi pubblica un cult di non facile recensione. Libro che è una raccolta di pensieri e riflessioni “sciolte ” come fosse un taccuino di viaggi, frammenti appunto come dice al termine del libro, dopo la parola Fine.
Dietro il libro Immediatamente di Dominique de Roux ora in edizione italiana c’è un curiosa storia di censura politico-intellettuale-editoriale che vale la pena ricordare. Pubblicato in Francia nel 1972, era una sorta di carnet personale, annotazioni di letture, considerazioni, riflessioni, descrizioni, incontri di chi si era già imposto come un enfant prodige delle lettere francesi.
Era un romanziere, un reporter, un editore: un letterato estremamentecompetente, morto appena quarantaduenne, nel 1977. Aveva fondato, nemmeno trentenne, la rivista «Cahiers de l’Herne», giocata per monografie dedicate a figure laterali, maledette e rimosse della cultura europea: ciò avveniva per lo più per basse ragioni ideologiche e spesso per bieche rappresaglie politiche. Stando a quanto ci riferisce nel risvolto di copertina dell’edizione Miraggi, la pubblicazione di questo suo personalissimo diario frammentario, Immediatamente, irritò il mondo intellettuale ed editoriale francese, in primis Roland Barthes, “costringendo de Roux ad abbandonare la Francia per diventare corrispondente giornalistico e autore televisivo”.
Figlio nobile di una famiglia monarchica, errante tra Germania, Spagna e Inghilterra sul finire degli anni Cinquanta, polemico, traduttore, visionario,internazionalista gollista, vagabondo nei primi anni Settanta in Svizzera e Portogallo, si rifugia a Lisbona e si dedica al giornalismo, diventando corrispondente nelle colonie lusitane e intimo amico del discutibile Jonas Savimbi. Nell’aprile del 1974, al tempo della Rivoluzione dei Garofani, è l’unico giornalista francese presente a Lisbona.
A 25 anni, aveva scritto il suo primo romanzo, aveva consolidato una posizione di battitore libero in controtendenza rispetto al proprio tempo: il «nouveau roman» lo faceva “piangere di noia, il maggio francese gli era sembrato una mitomania collettiva, la sinistra intellettuale una tribù antropofaga che faceva carriera sul cadavere del marxismo.”
La prima provocazione ha a che fare con un giudizio su Georges Pompidou, scritto quando quest’ultimo non era ancora presidente della Repubblica: «Pompidou – questa bella Venere di Lapougue della politica francese – sa tutto. Sa come si incula una mosca, come il 15 agosto presentare i suoi ossequi alla Vergine Maria. Conosce pure l’Inferno e i francesi. Porta sulla Francia uno sguardo da veterinario poiché la Francia di Pompidou è una truffa politica». Prende di mira come accennato sopra,Roland Barthes, pontefice massimo dell’intellighentia parigina: «Un giorno, con Jean Genet, mi dice Lapassade, parlavamo di Roland Barthes; di come avesse separato la sua vita in due, il Barthes dei bordelli con ragazzi e quello talmudista dicevo: Barthes è un uomo da salotto, è un tavolo, una poltrona… No, ribatté Genet: Barthes è una pastorella».
L’Eliseo, così come l’Académie a difesa diGenevoix, fecero pressioni sull’editore di Presses de la Citè, Barthes minacciò di procedere per via giudiziaria contro le edizioni Bourgois. Risultato: la pagina relativa a quest’ultimo venne tagliata via dalle copie ancora in deposito e, su mandato imperativo dell’editore, i librai fecero lo stesso con le copie in loro possesso, de Roux venne licenziato in tronco da Presses de la Citè e si ritrovò messo praticamente alla porta da quella stessa casa editrice che aveva contribuito a fondare. Immediatamente, ha i pregi e i difetti dei libri fatti di frammenti. Nomi, luoghi e bersagli polemici che al momento sembravano importanti, si rivelano con il tempo di circostanza, e le stesse provocazioni che allora lo fecero mettere all’indice, oggi rischiano di apparire incomprensibili Vissuto in un Novecento in cui l’homo ideologicus teorizzato da Cochin per spiegare la Rivoluzione francese e il Terrore aveva ormai raggiunto la sua piena maturità, de Roux venne etichettato dai suoi nemici come «fascista», cosa che nel libro si legge con questa considerazione: «Mi viene voglia di presentarmi così: Io, Dominique de Roux, già impiccato a Norimberga». Quell’etichettatura faceva del resto parte di una singolare inversione del vocabolario: «Il mercenario diviene volontario, l’agente speciale un consigliere, il questurino un patriota, i corpi di spedizione l’aiuto al Paese fratello, l’aggressione deliberata, un’assistenza militare per abbattere la reazione. Il tutto con L’Internazionale in sottofondo».
C’è nel libro un lungo giudizio di Romain Gary a questo proposito, proprio perché Gary con l’homo ideologicus aveva poco o niente da spartire. Scrive bene de Roux, dice Gary, «un autentico scrittore», ma il suo piglio polemico rimanda non tanto a una «questione di fascismo di fondo», quanto a un «fondo fascista». Che però, ammonisce, non esiste: «Il fascismo è sempre stato un contenitore che soffre del vuoto interiore, del suo vuoto, ecco perché può trasformarsi facilmente in fosse comuni. I cadaveri fanno sempre molto contenuto». Ancora Gary : è tempo che De Roux affronti «non altri ma se stesso con ferocia, coraggio e senza pietà. Io è un contenuto che lo chiama, il grande appuntamento letterario è con lui».
Immediatamente è sotto questo aspetto la risposta che proprio Gary avrebbe voluto. Nelle parole di Forlani ( il traduttore): “De Roux non solo fa parte della tradizionedegli infrequentabili del Novecento, ma potremmo dire che sia stato il primo a intuire, di quelle nature scomode e insieme necessarie alla cultura occidentale (Céline, Artaud, Pound, Gombrowicz, Bernanos, tra gli altri), il ruolo di visionari, una grandezza da proteggere a tutti i costi […]. La vocazione di de Roux è in questa funzione vitale di conservazione, diffusione, traduzione e allo stesso tempo crescita parallela della parola che da materiale diventa quasi subito spirituale, corpo a corpo, senza risparmiarsi”.
La bellezza – e anche la forza – di Immediatamente è data dal senso di incompiutezza che pervade tutto il volume. Frammenti che devono essere interpretati, parole che richiamano a un’infinità di parole non scritte, attacchi al moralismo in cerca di una libertà nuova, profondamente soggettiva, che Dominique de Roux nei suoi libri e nei suoi articoli ha ricercato per tutta la vita.
Titolo: Immediatamente
Autore: Dominique De Roux
Edizioni: Miraggi
Pagg.: 256
Prezzo: € 18,00 (in e-book: € 9,99)
Voto: 8
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

Nov 28, 2019 | RECENSIONI
CON GLI OCCHI CHIUSI PER SFUGGIRE AL NAZISMO
Gentili lettori, in quanti modi si può guardare alla Storia? Ci sono eventi chehanno inciso solchi nelle coscienze e impedito, per contro, l’intuizione di un’esistenza minima.
Roger Salloch, scrittore, sceneggiatore e fotografo statunitense sembra avere trovato una chiave di lettura di un periodo cogente del nostro passato che, sublimando il dolore, rappresenta una metafora storica d’incisiva visione filosofica.
«Quando tutto diventa collettivo, il privato diventa compulsione». È una frase contenuta in “Una storia tedesca”, libro che inaugura la collana “tamizdat” dell’editore “Miraggi”.
«Col termine tamizdat si indicavano, nel blocco comunista e in Urss, le opere straniere, per lo più occidentali, fatte circolare clandestinamente». E clandestinamente “Una storia tedesca” si aggira per il mercato editoriale, fatto dai giganti ingordi di spazi e lettori.
Laura Berna traduce con soavità un dispositivo narrativo di grande caratura letteraria e metafisica, fatto di rimandi continui alla pittura, alla filosofia, al cinema, alla musica e ai miti religiosi.
Siamo a Berlino nel 1935 e seguiamo la vita di Reinhardt Korber, maestro d’arte in una scuola frequentata da adolescenti come potrebbero essere quelli attuali. Leggono poco, sono immersi nel contesto politico per via del nazismo. Si odono gli stivali dei soldati in adunata. Si respira il clima del totalitarismo. Tra gli studenti spiccano Rebecca e Lotte, le allieve predilette. Korber
ha un dialogo onesto, emancipato e lungimirante con le ragazze. Rebecca è ebrea e seguirà il suo destino; Lotte è ariana ma nemmeno per lei l’esistenza sarà libera. Ogni pagina è intrisa di splendore e miseria, tanto quanto è possibile vivere dell’uno e dell’altra in tempo di guerra. Korber di tanto in tanto va a trovare la madre, che ha l’ossessione per la storia dei tre Re Magi. Essi, nonostante gli ordini di Erode, fecero ritorno nei loro paesi per un’altra strada per non fornire alcuna informazione circa il luogo in cui si trovava Gesù.
Sembra prendere vita da questo passo biblico la metafora di Salloch sulla storia. Korber, Rebecca e Lotte, seppur travolti dalla vita, manterranno integri gli spazi esistenziali che hanno creato insieme. Quando Korber viene sorpreso durante la sua lezione al bianco, al vuoto di senso, all’interno della Stadt-Galerie, da un delegato dell’esercito che proclama: «Non c’è niente da guardare qui», il maestro d’arte dice che sono lì per quel motivo e Lotte risponde: «Siamo qui per chiudere gli occhi». È la soluzione finale, il male che annichilisce. L’arte ha fatto il suo tempo, è stata svuotata, censurata, proibita. Ci si rivolge al vuoto, al mistero. Salloch interroga quel mistero e lo sostanzia con la Storia per disarcionare ogni certezza. In fondo la vita vera nasce dal buio, ma solo la consapevolezza ci può scuotere e portarci in salvo. Come per Rebecca e la sua piccola casa su una foglia adagiata sull’acqua. Sarà in salvo, lontana dal male.
L’Antiquario vi saluta,
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:


Ott 7, 2019 | RECENSIONI
LAMBORGHINI A TUTTO GAS VERSO IL PIACERE
Non c’è traccia di colpa o vergogna nei racconti dell’irregolare scrittore argentino Osvaldo Lamborghini (1940-1985). Lo riscopriamo oggi a poco più di trent’anni dalla morte grazie all’editore Miraggi che pubblica La pianura degli scherzi, una raccolta di quattro racconti che, per la loro impossibile aderenza a un canone già noto, sembrano provenire dal futuro.
Già César Aira lo eleva a «maestro», suo e degli scrittori argentini a venire, perché fu «qualcosa di eccezionalmente nuovo», scrive nella postfazione all’edizione completa in spagnolo delle sue opere. Pensatore arguto, in vita pubblicò molto poco, ma fu un personaggio stravagante. «Quel che fosse Osvaldo è difficile dirlo» prosegue Aira: «era un signore distinto, azzimato, dai modi aristocratici, un po’ altezzoso ma al tempo stesso molto affabile». Tuttavia, era anche capace di lasciarsi il pigiama sotto gli abiti da giorno. E poi, a letto mezzo svestito – com’è immortalato in molte fotografie – o seduto al tavolo da lavoro, scriveva circondato da pile di riviste pornografiche comprategli dalla moglie, da cui ritagliava le immagini per dedicarsi all’ancillare attività di pittore. Realizzava dipinti, fotomontaggi e collage che per la potenza evocativa richiamavano gli scatti più estremi di Robert Maplethorpe (nel 2015 tutta la sua produzione visuale è stata presentata al MACBA di Barcellona).
I protagonisti di questi quattro racconti vivono immersi, quasi annegati, nell’ambivalenza erotica tra delizia e dolore, tra l’essere vittime o autori del paciere. Eppure, soltanto all’apparenza è il sesso (e le sue perversioni) il centro d’attrazione della scrittura di Lamborghini, che invece lo utilizza e lo esaspera per estrarre alla fine il bello dal turpe: proprio come nei suoi quadri, anche in questi cuentos-collage (tradotti da Vincenzo Barca e Carlo Alberto Montaldo) i partecipanti a un’orgia di Il fiordo, il marchese gay e cocainomane di Sebregondi retrocede, le prostitute tratteggiate in Le figlie di Hegel e l’ambiguo ingegnere giapponese di La causa giusta vengono tutti colti mentre appagano i loro desideri. Nell’universo di Lamborghini è dunque il desiderio l’innesco di tutto. Ed è qui, mentre sottrae alla sua scrittura funambolica i concetti di salvezza e condanna, felicità o infelicità, e annulla ogni giudizio morale, che riesce a creare un mondo senza colpa o vergogna.
La rivoluzione generata da Lamborghini, la missione tutta politica della sua ispirazione per la quale è spesso accostato a Pasolini o Foucault, era liberare la letteratura argentina dal senso di colpa della tradizione culturale catto-europea (dunque dei conquistadores). E ci riesce benissimo.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:


Feb 1, 2019 | RECENSIONI
 Mi piace definire Dominique De Roux il Karl Kraus francese. Scrittore e intellettuale fuori dal comune, cavaliere delle lettere in territorio nemico, fa parte degli irregolari e degli impresentabili del Novecento.
Mi piace definire Dominique De Roux il Karl Kraus francese. Scrittore e intellettuale fuori dal comune, cavaliere delle lettere in territorio nemico, fa parte degli irregolari e degli impresentabili del Novecento.
Fu il creatore dei «Cahiers de l’Herne», una collana che riportò al centro della vita culturale scrittori maledetti, liberi e anticonformisti (che molto gli somigliavano) come Céline, Pound, Artaud, Lovercraft.
De Roux riuscì a presentare criticamente al grande pubblico autori del calibro di Borges, Gombrowicz, Solženicyn, Koestler e movimenti come la beat generation.
Siamo davanti a un grande scrittore controverso che decise di essere sempre un uomo libero, di non appartenere a nessuna banda letteraria. La sua penna e la sua intelligenza si schierarono apertamente contro il mondo culturale del suo tempo.
De Roux, come Kraus, nelle sue invettive non risparmiò proprio nessuno.
In Italia non è molto conosciuto e soprattutto è pubblicato poco. Grazie a Francesco Forlani da Miraggi edizioni esce Immediatamente, libro di frammenti e aforismi in cui l’irriverente scrittore francese intinge la sua penna corrosiva di provocatore e di agitatore culturale.
Immediatamente esce in Francia nel 1971 e De Roux è vittima di una violenta reazione del mondo intellettuale francese. Il primo a scagliarsi contro di lui fu Roland Barthes.
Dolo l’uscita del libro «l’impresentabile» De Roux fu costretto a lasciare la Francia.
Dominique De Roux è uno straordinario inattuale che vale la pena conoscere e approfondire. Uno scrittore irregolare che rientra a pieno titolo nella tradizione dei pensatori controcorrente.
Un uomo e un intellettuale che veste da uomo sempre libero i panni del polemista e scrive del proprio tempo sedendosi orgogliosamente dalla parte del torto, in compagnia degli spiriti scomodi e degli infrequentabili.
Immediatamente è un libro di illuminazioni che folgorano. Dominique De Roux è uno scrittore che scrive per disturbare e con i suoi aforismi taglienti ha squarciato, come sanno fare soltanto gli irregolari e gli uomini di pensiero che decidono di rispondere soltanto alla propria coscienza, tutto il marcio di un’epoca che sa solo esprimersi attraverso la rappresentazione ipocrita di se stessa.
«Viviamo il tempo degli istrioni di massa. Coloro che fanno gesti differenti non sono più originari di nessuna parte»; «Al gaullismo succederà la Germania, o peggio ancora i francesi».
Per De Roux scrivere è rinunciare al mondo. Una grande e coraggiosa lezione inattuale.
Quando le epoche si fanno torbide dobbiamo assolutamente leggere gli inattuali. Perché solo loro sanno dirci le cose come stanno.
Leggiamo assolutamente Dominique De Roux che, come Cioran, Kraus, Céline e tutti gli altri infrequentabili, ha diffamato e squartato il suo tempo.
Dominique De Roux (1935-1977) fu un letterato fine e controverso. Il primo romanzo, Mademoiselle Anicet, è del 1960; nel 1963 fonda la rivista «Cahiers de l’Herne», raccolta di numeri monografici dedicati alle figure maledette o misconosciute della letteratura europea (Céline, Gombrowicz e Pound, tra gli altri). Nel 1966 dà alle stampe il saggio La morte di Céline (Lantana), che inaugura il catalogo della casa editrice Christian Bourgois, co-fondata dallo stesso De Roux.
Immediatamente esce nel 1971 e la violenta reazione del mondo intellettuale, con Roland Barthes in prima linea, costringe De Roux ad abbandonare la Francia per diventare corrispondente giornalistico e autore televisivo. Inviato soprattutto in Portogallo, documenta le guerre nelle colonie africane e nel 1974 è l’unico inviato speciale francese a Lisbona durante la rivoluzione dei garofani, che portò alla caduta di Salazar e della dittatura portoghese.
Pubblica l’ultimo romanzo, Le Cinquième Empire, cinque giorni prima di morire improvvisamente per infarto, nel 1977; La Jeune Fille au ballon rouge e Le Livre nègre usciranno postumi.
:: Immediatamente di Dominique De Roux (Miraggi Edizioni 2018) a cura di Nicola Vacca

Apr 19, 2018 | RECENSIONI
Recensisco un altro “Tamizdat” di cui a questo punto vale la pena spiegare il significato o perlomeno cosa si intende: “Tamizdat” era il termine che indicava le opere occidentali (provenienti da “tam”, cioè da “là”) in circolazione clandestina tra Trieste, Gorizia e Berlino, nei deprimenti anni della Guerra Fredda.
“Viaggiare senza smettere, tra le curve, di scrivere il proprio romanzo” potrebbe essere un epitaffio oppure una sinossi ben strizzata della destrutturata enciclopedia proposta da Petr Kral, intelligenza ceca esule per questioni politiche, surrealista antisovietico che offre il titolo “Nozioni di base” Miraggi edizioni, al flusso di coscienza su cui struttura il suo lavoro.
Mi sembra utile pensare alle curve che armonizzano un percorso che spazia tra natura e artificio, fulmini e giochi pirotecnici come espedienti che rendano l’idea di qualcosa che brilla nella penombra cosmica e individuale, nella quale si fluttua o si fluttuava (se vogliamo contestualizzare) quotidianamente al cospetto dell’incessante buio che tuttavia può sempre essere esorcizzato.
Che legame si instauri tra i vari paragrafi è il vero studio da cui partire a mio parere, l’autore abbandona come Svevo la cronologia poco fertile e ci sbatte davanti ad un “cancello” da aprire; se riuscissimo a scardinarlo troveremmo però un ostacolante “muro” da abbattere o guardare, a discrezione personale.
Cosa si prova realmente nel tuffarsi nella porta girevole di un hotel per scomparire vorticosamente in un qualunque senso di precarietà che rifugge nell’illusione dell’attesa di un nuovo giro? Attendo pure io. Ho aspettato fino all’ultima goccia di carta scritta per trovare una bottiglia semipiena di un epilogo che non si leggerà mai.
Petr incita ad attraversare la strada o a salire su un tram per valicare quel confine ostico e avvilente che separa il mondo dalla vita e la vita da sé stessi. C’è uno studio quasi paranoico degli spazi e della dislocazione degli oggetti con una immediata smania metodica di trincerazione degli stessi, come a volerli appendere in una parete verticale, ben visibile dall’osservatore.
Elenca nomi comuni di cosa destinati ad essere dipinti o a diventare icone metaforiche di una realtà immobile in cui le pedine animate si muovono stando attente a non inciampare. Il tema del viaggio è la colata di cemento più volte versata, bacino in cui si muovono i paragrafi imperniati sulla resistenza delle “cose”.
Sostiene Milan Kundera che questa raccolta di scritti brevi del poeta Petr Král sia una “bella e strana ‘enciclopedia esistenziale della vita quotidiana’”, la incornicia come “lezione di modestia impartita al nostro individualismo”. Secondo Yves Hersant, siamo di fronte a una raccolta che restituisce “l’antica potenza delle forme brevi”: “dinamitardo delicato, Petr Král apre brecce nel quotidiano […] da grande educatore dello sguardo”.
Persino Topinambur è un titolo scelto.
Nozioni di base è un quaderno di 123 capitoli brevi, che comincia da un caffè che ci unisce ai vivi “un po’ di sbieco”, “osservando incuranti la strada e il suo sfuocato viavai”, per restituire con chiarezza la propria presenza.
Král parla di starnuto, riso, luce, buio, cipolla, macchie, vento, sud, madri e figli, colori, nudità, e più delicatamente di cosa significhino verbi come “spaventare”, “unire e separare”, “attaccare”, “sfiorare”; analizza le parole “solitudine”, “assenza” e si concentra sulla “settimana” per azzardare un parallelismo tra domenica ed esistenza.
“la bianca trappola in cui la domenica ci attirava, dopo il promettente grigio del sabato, si apriva a perdita d’occhio verso l’interno, verso l’immagine del deserto staliniano in cui siamo cresciuti, e di quella guerra fredda che per noi era l’esistenza stessa”
È un piccolo breviario di meditazione in cui non risparmia riflessioni insoddisfacenti che corazzano la pelle da emozioni malriuscite.
“Anche quando siamo davvero presi dal momento e la sensazione perdura, quando ci lasciamo andare al sonno, o all’amore, o da un luogo freddo entriamo in una stanza riscaldata e il calore ci invade dentro e fuori, proviamo un senso di benessere totale, ma non completo”.
Si serve del sorriso per scontrare l’insoddisfazione, un sorriso comunque amaro per ingannare l’esistenza che sguscia per poi rintanarsi e nascondere le chiavi di lettura di una vita che non vuole essere letta ma interpretata.
E’ proposto un obiettivo durante la gara con se stessi, riuscire a prendere il treno..
“Dover correre per prendere un treno è sempre umiliante, perderlo è fatale: su quel treno non saliremo mai più. Quando invece il treno riusciamo a raggiungerlo non è mai solo un colpo di fortuna; entriamo nel vagone e riponiamo la valigia sulla cappelliera come se niente fosse, cercando di nascondere l’affanno, ma sappiamo che la corsa ha dato al nostro viaggio una possibilità in più. Anche rispetto a coloro che, puntuali, hanno occupato i loro posti”.
Mentre ricopio mi accorgo di come possa divenire un “credo” collettivo subito dopo esser divenuto il mio.
Ombretta Costanzo
Ott 6, 2017 | RECENSIONI

Rappresentante del caos e del postmodernismo d’Oltrecortina, Venedikt Erofeev è una delle più rappresentative incarnazioni della letteratura russa del secondo Novecento. Condusse una vita dissestata, dedita all’alcolismo e all’accattonaggio, segnata da un continuo vagabondaggio di città in città. Scrisse la sua opera più importante, Mosca-Petuškì, nel 1970 (pubblicata inizialmente solo in Israele), in cui l’alter ego di Erofeev vaga per la città come un ubriacone, scoprendo infine la propria dimensione esistenziale.
Da poco è uscita, per la prima volta in Italia, Memorie di uno psicopatico (traduzione di Lidia Perri) per i tipi di Miraggi edizioni, nella collana Tamizdat (mai termine è stato più appropriato, in quanto nel blocco sovietico si indicavano con questo termine le opere, per lo più straniere, fatte circolare clandestinamente, destino che tutti i lavori di Erofeev hanno subito fino alla caduta del Muro).
Memorie di uno psicopatico è una raccolta di diari giovanili che mette in luce i temi dell’autodistruzione e dei mali della società contemporanea. Mischiando esperienze autobiografiche con riflessioni filosofiche e grottesche, talvolta assurde e comiche, l’autore riesce a dare un ritratto onesto e impietoso della Russia destalinizzata. Tutto passa attraverso l’alcol. Bere e scrivere sono collegati: una via di fuga dalla pochezza quotidiana ed estasi della libertà emotiva, il lirismo e il cinismo. Una testimonianza indimenticabile di un grande scrittore che già da giovane non faceva sconti a nessuno, a partire da se stesso.
Sempre per Miraggi edizioni sono usciti altri testi interessanti, molto diversi tra loro. Si tratta del nuovo, brevissimo romanzo di Roberto Saporito, Respira, viaggio letterario sulla morte, legato idealmente al crollo delle Torri gemelle, da cui prende spunto il plot, e che investiga, supportato da una miriade di consigli letterari e di citazioni, sull’evasione e sulla libertà spirituale e intellettuale. Non disturbare, di Claudio Marinaccio, dialoghi e riflessioni (più taglienti le seconde) di vita quotidiana. Intoppi di comunicazione che assillano tutti: telefonate con offerte commerciali, i testimoni di Geova, incontri in metropolitana, spalle su cui piangere dopo una delusione d’amore. Quello che dice una cameriera, di Nicola Manuppelli, raccolta poetica incisiva e ritmata che deve molto a scrittori americani contemporanei, di cui l’autore è un importante traduttore e biografo.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/03/letteratura-russa-il-miraggio-di-venedikt-erofeev/3891776/
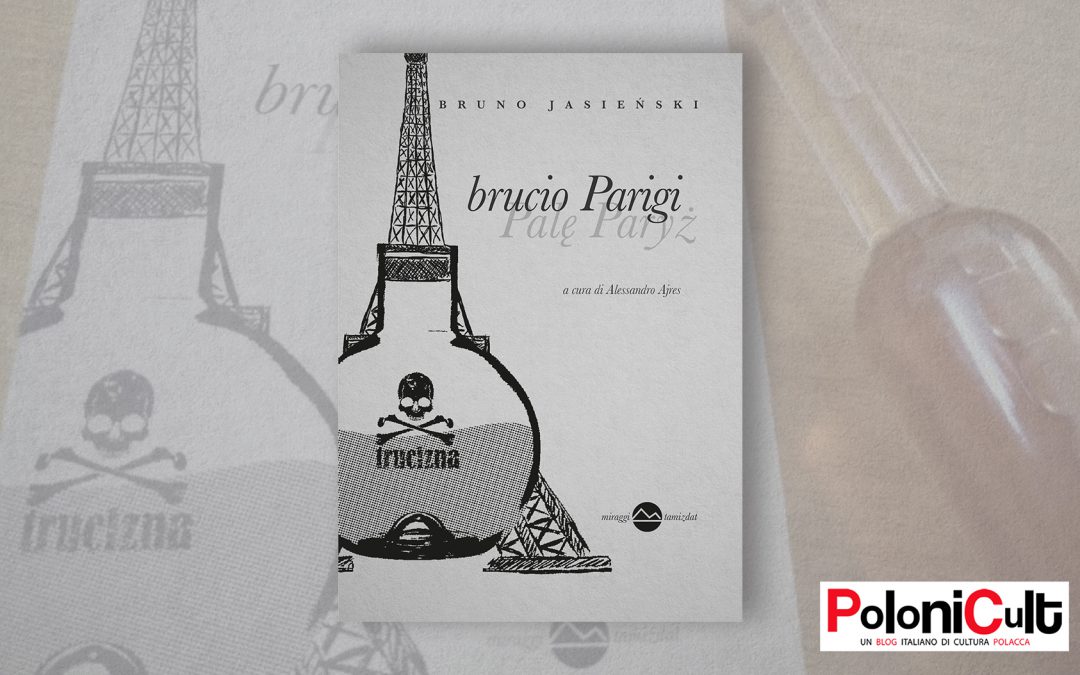






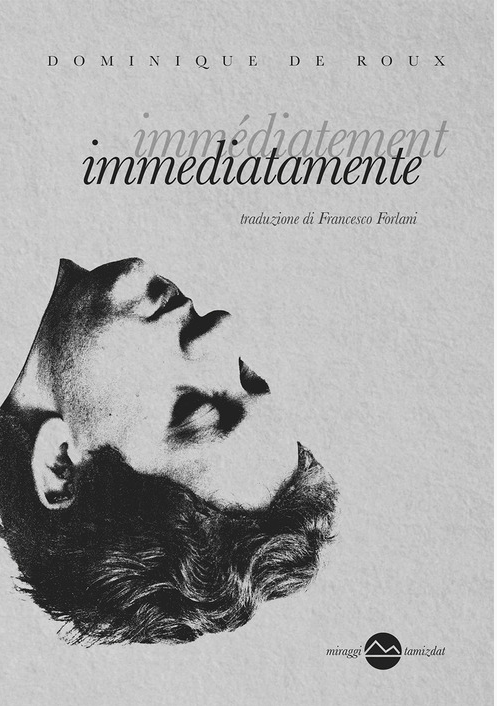





 Mi piace definire Dominique De Roux il Karl Kraus francese. Scrittore e intellettuale fuori dal comune, cavaliere delle lettere in territorio nemico, fa parte degli irregolari e degli impresentabili del Novecento.
Mi piace definire Dominique De Roux il Karl Kraus francese. Scrittore e intellettuale fuori dal comune, cavaliere delle lettere in territorio nemico, fa parte degli irregolari e degli impresentabili del Novecento.
