
Giorgio Scianca e Alessandra Comazzi nel podcast «Il Posto delle Parole»
di Livio Partiti

di Livio Partiti

Tra bravura, bellezza e avanguardia, le dive della belle époque come modelli di lotta ed emancipazione.
Per l’immaginario maschile, tra Otto e Novecento, attrici e danzatrici erano oggetto di attrazione e repulsione, di fascino e di orrore. Per le donne invece erano un modello di forza, di grazia, di bellezza, di successo e libertà. Durante la Belle Époque il teatro era il media più influente e di maggior diffusione e nella figura e nel corpo della diva si andava definendo la nuova immagine della donna ben lontana dal sofferente e languido angelo del focolare caro alla società patriarcale.
Le vite e le opere di Sada Yacco, Cléo de Mérode, Edith Craig, Valentine de Saint-Point e Emmy Hennings non ci raccontano solo dell’effervescenza avanguardista del modernismo, ma anche delle lotte delle donne per affermarsi con un ruolo attivo nella società. Averle marginalizzate o persino rimosse dalla storia ufficiale ha significato dimenticare quelle battaglie da cui è sorta la donna moderna. Riportarle alla memoria non ci ricorda solamente che il teatro non è stato riformato solo dai “padri della regia”, ma anche quanto delle donne di oggi è debitore delle lotte delle dive di quel tempo lontano.
Enrico Pastore (Stresa 1974), ha svolto periodi di formazione con registi come Pippo Delbono, François Tanguy (FR), Jakob Shokking (DK), Fernando Dacosta (SP). Regista e direttore della Compagnia DAF fondata nel 1998. Dal 2006 al 2011 è stato direttore operativo degli Incontri Cinematografici di Stresa. Dal 2012 al 2018 ha scritto sulle pagine di «Passparnous», «web revue of art», come critico di spettacoli di teatro e danza. Nel 2017 è stato co-curatore con Ambra Bergamasco e Edegar Sterke del MovingBodies Festival di Torino. Oggi scrive su «Rumor(s)cena».
QUI l’articolo originale: https://ilpostodelleparole.it/libri/enrico-pastore-che-peccato-essere-una-curiosita/

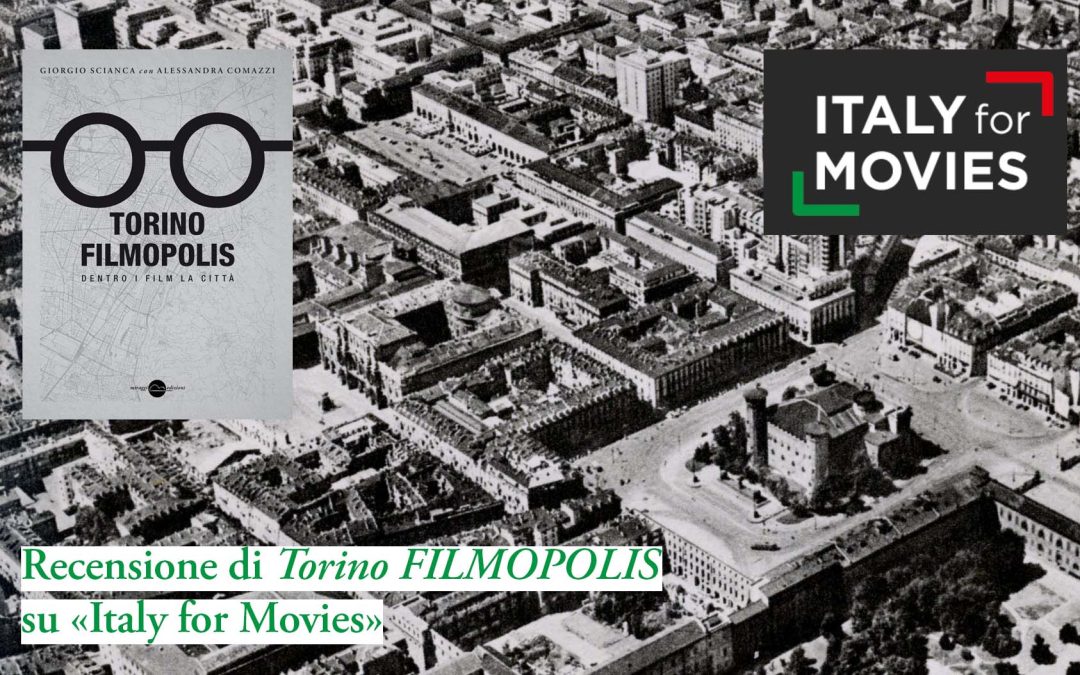
In “Torino Filmopolis. Dentro i film la Città”, il volume scritto da Giorgio Scianca con Alessandra Comazzi per Miraggi Edizioni, il capoluogo piemontese torna ad essere patria della settima arte.
Ispirato da Italo Calvino, l’architetto appassionato di cinema mescola in questo libro il suo lavoro e la sua passione: ne viene fuori un’originale guida della città, suddivisa in quattro stagioni, a cui corrispondono 458 film, che riscrive la storia del cinema torinese attraverso strade, piazze, ponti, giardini e parchi sempre più spesso utilizzati come set. Ogni angolo è un fotogramma e la sensazione è quella di passeggiare in luoghi familiari anche per chi non conosce la città.
Una ricerca approfondita – attraverso siti italiani, stranieri e locali, gli archivi in rete dei giornali, i titoli di coda, i trailer e le foto di scena e i social – che si completa con un QR code tramite cui si approda all’elenco completo dei film esaminati, con trailer e clip, in un continuum tra parole scritte e immagini.
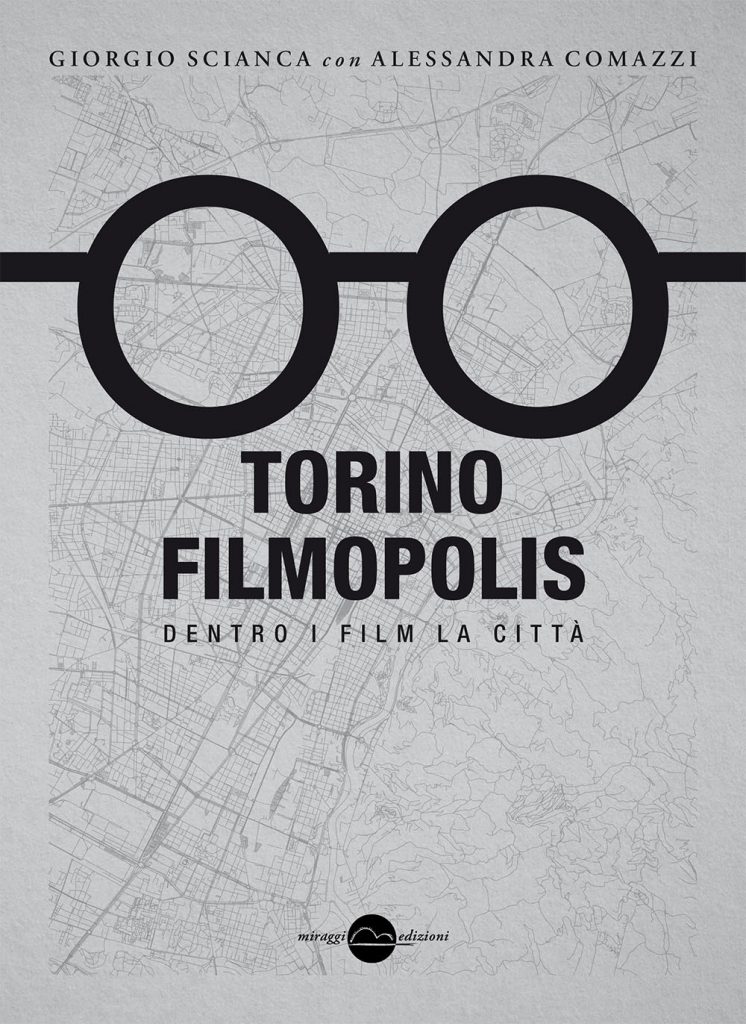
Ad ogni stagione i suoi luoghi…e i suoi film: Scianca parte con l’estate, la stagione più cinematografica dell’anno, grazie alla sua luce, ai colori, ai contrasti.
Torino viene definita città trasformista, che interpreta se stessa ma può facilmente trasformarsi in altro: è stata Milano, Roma, Parigi, Sarajevo, Zurigo, Monaco di Baviera e addirittura New York. Lo stesso avviene per i suoi luoghi nevralgici. il Po, protagonista di una cinquantina di pellicole, è stato, tra gli altri, la Senna o il Tevere (Fast x) o la Miljacka di Sarajevo (The King’s Man – Le origini), ma anche il Tamigi, il Neman, la Limmat etc.
L’estate è l’occasione per parlare, attraverso il cinema, di architettura radicale, degli elementi che compongono i palazzi più rappresentativi della città: dai mattoni dello scenografico palazzo Carignano, al ferro usato originariamente a copertura di diversi punti e poi riutilizzato a servizio dell’industria bellica, fino al vetro della “Bolla” comparsa del 1994 nello skyline della città, sopra la storica fabbrica Fiat del Lingotto. E poi ci sono i tetti, che, a partire dalla Mole Antonelliana, forniscono, a varie altezze, tanti punti di osservazione per ammirare Torino dall’alto.
Il cinema permette anche di “fotografare” luoghi che non esistono più o mostrarne la trasformazione nel tempo, come il parco Dora, un tempo sede degli stabilimenti della Fiat, oggi testimonianza di archeologia industriale. O di testimoniare la trasformazione urbanistica di centro e periferie, come ci mostra la cinematografia recente (Anywhere anytime, La chiocciola, Confidenza).
Nella bella stagione rientrano anche i parchi, come il Valentino, capace di un viaggio nel tempo unico nel suo genere e ispiratore di tanto cinema, e la musica, colonna sonora imprescindibile delle immagini in movimento.
L’autunno segue l’estate con i suoi colori, i mercati e la sosta nelle piazze. Qui è la stagione del cinema, quello girato e quello proiettato. La storia del cinema passa anche per la storia delle sale cinematografiche, delle loro trasformazioni, cambio di destinazione e denominazione per rispondere alle esigenze delle epoche storiche che oltrepassano, immortalate più volte dalla macchina da presa.
Tra i luoghi più rappresentativi della cinematografia, le piazze hanno un punto di vista privilegiato. Sono più riconoscibili di altre location e a Torino coincidono spesso con i mercati. Il più noto, ma non l’unico, quello di Porta Palazzo, immortalato più volte e in vari momenti, con la nebbia mattutina (in Mimì metallurgico ferito nell’onore), o a fine giornata, quando si consuma il rito della raccolta degli scarti. Scianca dedica un capitolo a ciascuna delle piazze più significative, più o meno riprese dal grande cinema: piazza Carlo Alberto, piazza Carignano, piazza Carlina, piazza Solferino, piazza Bodoni, ciascuna con la sua fisionomia, i palazzi che vi affacciano, una o più storie da raccontare.
L’inverno, la stagione fredda, dal tempo incerto, in cui si transita sotto i portici, o in galleria, nel tram – di cui il cinema ci restituisce i percorsi storici e la storia dei percorsi – al Museo del Cinema, allo stadio, ad ammirare luci e luminarie. All’inverno Scianca associa gli spazi militari, come la Caserma Pietro Micca, recentemente vista nella fiction Il nostro Generale, dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa o in L’eroe della strada, con Erminio Macario. Esistono alcuni luoghi nevralgici, come le gallerie, che il cinema, specie quello d’azione, ha amato molto. Come non ricordare galleria San Federico, “profanata” per la prima volta sul grande schermo nel 1969 dalle tre famose Mini Minor di Un colpo all’italiana, o quel labirinto stratificato di galleria Umberto I, immortalata negli anni da Antonioni, Argento, Scola e più di 20 registi.
All’inverno appartengono anche, nell’immaginario del regista, piazza CLN, indissolubilmente legata a Dario Argento, e la Mole, che compare in tutte le pellicole che vogliono localizzarsi a Torino, ripresa più volte da Davide Ferrario, che addirittura ambienta nel museo del cinema al suo interno Dopo mezzanotte.
La primavera è la stagione della rinascita, dei parchi, dei giardini, dei fiumi, delle passeggiate, delle letture alla luce naturale. Torino è la città italiana più ricca di verde pubblico e il cinema non poteva non notarlo. È anche l’occasione per ricordare quanto Torino sia legata ai libri e alla letteratura (ne è testimonianza il Salone del Libro), così come ai film tratti da libri o fatti di cronaca e tutte le volte che librerie storiche (a volte scomparse) sono rivivono tra i fotogrammi.
***
Nel 2020, in occasione del ventennale della Film Commission, Italy for Movies e Film Commission Torino Piemonte hanno dedicato ai principali set della città un suggestivo itinerario, Girando per Torino.


di F. Div.
Scenografia e location, ma anche contesto e funzione allegorica. La città nel cinema ha aspetti nascosti e mai scontati che Sere d’Estate di Ivrea analizza con un evento promosso dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa, dall’Associazione Rosse Torri e dalla Libreria Mondadori. L’appuntamento è fissato mercoledì, dalle 18.30 nella sede dell’Archivio in viale della Liberazione 4 a Ivrea, in compagnia di Giorgio Scianca e Alessandra Comazzi, autori di Torino – Fil-mopolis, e da Anna Rowinski, autrice di Torino adagio (Enrico Damiani Editore). Se in Filmopolis (Miraggi Edizioni) Comazzi si concentra sul fenomeno (in crescita) delle serie televisive girate in città, Scianca ripercorre e riflette su oltre un secolo di «apparizioni» cinematografiche del capoluogo sabaudo.
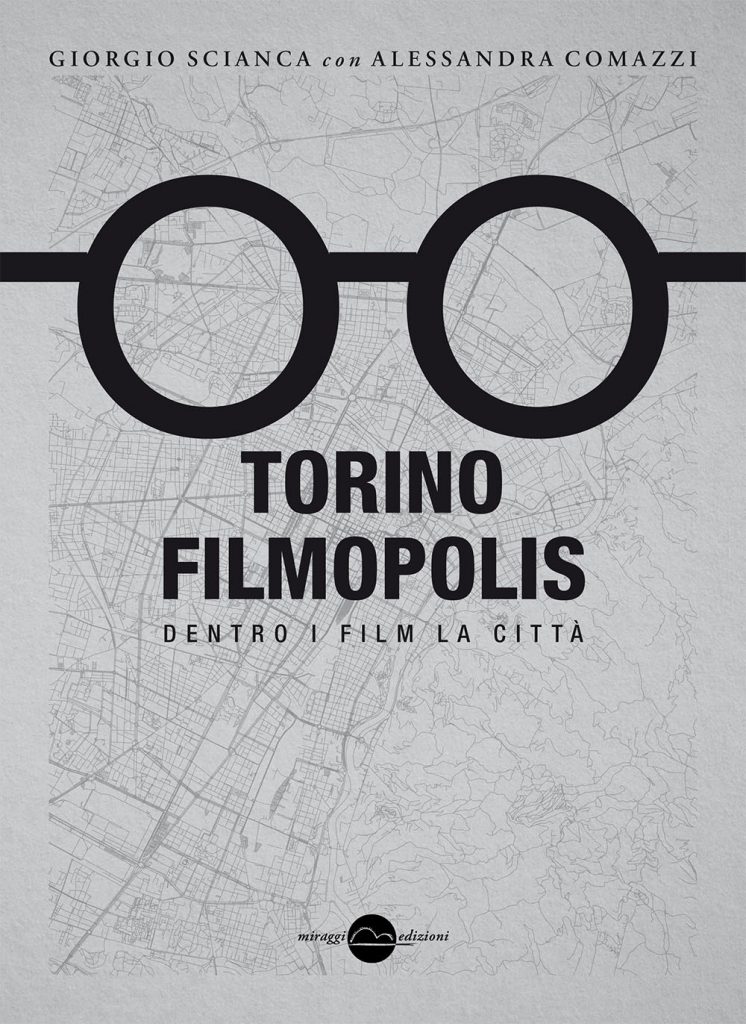
Tratto dagli articoli pubblicati dal 2023 sulle pagine del Corriere Torino, il volume non si limita a una cronologia di titoli e set ma esamina, piuttosto, l’evoluzione architettonica e sociale della città attraverso una galleria di siti, situazioni e spazi (fisici e mentali) in continua evoluzione. Diviso in 4 stagioni me-taforiche, Filmopolis permette così di monitorare spazi architettonici pubblici e istituzionali (gallerie, scorci e piazze, ma anche tram, locali di ritrovo e di divertimento) che, filmati nel corso del tempo — e talvolta scomparsi –, consentono un’inconsueta visione prismatica sulla città, preziosa per storici e cinefili, del presente e del futuro.
La serata prosegue con Italo Calvino nelle città realizzato da Davide Ferrario in occasione del centenario della nascita dello scrittore. Nel documentario che raccoglie rari documenti filmati e letterari di Calvino, si ripercorre la vita dell’autore de Le città invisibili attraverso il suo rapporto con i luoghi in cui ha vissuto e lavorato e che lo hanno ispirato nella creazione dei suoi immaginifici universi. A introdurre il film sarà Steve Della Casa, oggi conservatore capo della Cineteca Nazionale; insieme al presidente anche Arrigo Tomelleri, ripercorrerà la tradizione cinematografica di Ivrea, che in Adriano Olivetti e i suoi cineforum ha un’origine storica ben precisa, e della ristrutturata sala cinematografica che – finalmente – sta per risorgere in città.
Infine, a proposito di visioni sospese tra cinema e arte pura, andrà in scena Film/a/ To di Ugo Nespolo, opera sperimentale che, con la partecipazione «in corpo e voce» del poeta Edoardo Sanguineti, offre un approccio originale alla grande storia cinematografica torinese.


di Maria Dolores Pesce
In Europa tra fine ‘800 e inizio ‘900, per poi oltre proseguire, esplode, dentro una concezione borghese del patriarcato che riproponeva i consueti schemi di subordinazione e sudditanza ma insieme paradossamente li smentiva nel trionfo della libertà personale e individuale, la contraddizione del femminile proprio per la sua (del femminile) nascente indisponibilità a farsi imprigionare in quegli schemi.
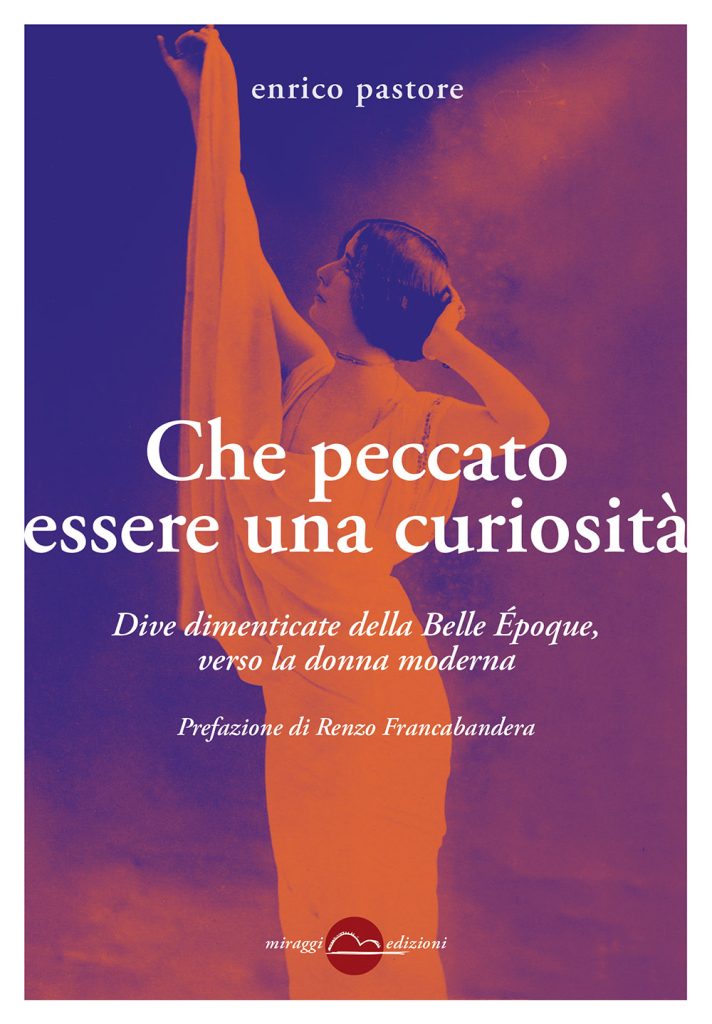
È innanzitutto la drammaturgia nordica ma non solo, tra l’altro quasi esclusivamente maschile, a farsi portatrice dei quella contraddizione e di quella indisponibilità che lo sguardo appunto maschile ‘pativa’ anche angosciosamente mentre, secondo l’insegnamento szondiano, contribuiva non poco alla crisi, speculare a quella sociale, del dramma moderno. Questo bel libro di Enrico Pastore affronta però il tema da un punto di vista diverso, quello delle artiste cioè, oggi diremmo performer, che non furono solo oggetto di quella mutazione ma se ne fecero concretamente carico subendone anche gli effetti. Non solo personaggi, da Salomè all’Olympya di Hofmannsthal, ma veri e propri corpi alieni che ribaltavano la percezione del femminile, incidendo sulla struttura stessa della rappresentazione. Nomi di artiste, da Sada Yacco a Cléode Mérode, da Edith Craig a Valentine de Saint-Point e Emmy Hennings, non a caso, come spesso capitava e ancora capita a molte artiste, praticamente dimenticate nonostante l’impulso essenziale che hanno saputo dare al rinnovamento del teatro. Ma non è un bagno di memoria, è soprattutto un riconoscimento di valore, dovuto e comunque tardivo. Forse altrettanto importante di quello che in precedenza segnò l’esordio sulla scena della donna, non solo come personaggio ma in carne ed ossa, e così capace di modificare anche il senso stesso del personaggio teatrale. Un lavoro importante e approfondito, come testimoniato dalla corposa bibliografia, quello di Enrico Pastore, definito da Renzo Francabandera nella sua prefazione non solo un’operazione di rottura, ma soprattutto di condivisione capace di dare l’avvio a forme sempre più complesse, nel Teatro e nella Società. Una dimostrazione ulteriore di come l’attività di quelle artiste ‘eversive’ non fosse rivolta esclusivamente alle donne nel teatro ma anche, modalità questa tipica del femminile, all’intero teatro e inevitabilmente alla intera Società. Un volume ricco e articolato da consigliare perché parlando del passato parla soprattutto al nostro presente.
QUI l’articolo originale: https://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39243:che-peccato-essere-una-curiosita-di-enrico-pastore&catid=53&Itemid=45

Culture diverse, modi di vivere differenti, storie nazionali che seguono il proprio percorso, ma qualcosa ci accomuna: il desiderio di vivere la nostra vita in dignità e autodeterminazione. La Resistenza è una terra di tutti e di nessuno, appartiene all’Uomo. Quello che è fedele a se stesso.
Fedele a se stesso lo è di certo František Wiendl, protagonista di Tempo confinato. Memorie di un prigioniero politico tradotto dal ceco da Annalisa Cosentino per Miraggi Edizioni. La sua è una vita singolare ed insieme anche una fra le tante, una rappresentazione perfetta della vita di un cittadino Boemo del Novecento. Come tante, è una vita impigliata nelle maglie della grande Storia – quella a cavallo tra i due regimi totalitari – . È proprio questo suo essere vittima del sistema/dei sistemi che lo rende comune. La storia del singolo si eclissa dietro un numero quando la tragedia da storicizzare è troppo grande o anche quando la volontà di narrare manca.
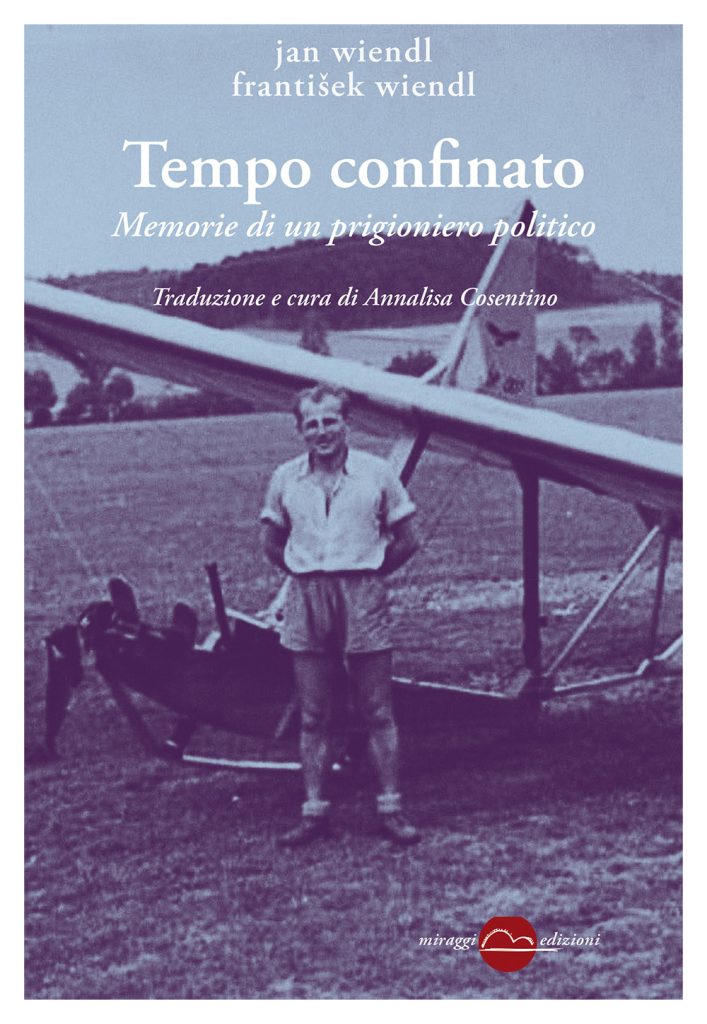
Ma la vita di František è anche una vita singolare, a suo modo, per quella forza di autodeterminazione non solo desiderata passivamente, ma praticata attivamente e per la dignità che ha conservato in ogni circostanza, anche quando la Storia l’ha reso una vittima fra le tante.
Inoltre, se una storia acquista vividezza nel momento in cui la si racconta, anche per le generazioni a venire, la vita di František Wiendl, unica nelle sorti comuni, acquisisce la sua aura di unicità per la volontà del figlio di narrarla.
Trama – La struttura narrativa di Tempo confinato segue la forma di un dialogo, quello generazionale che intercorre tra Jan e František Wiendl. Jan è il figlio ansioso di ricostruire la storia paterna, prima che questa cada nell’oblio con la sua morte. Ma è anche il rappresentante di una generazione che non ha davvero sperimentato in prima persona la parte più brutale dei regimi totalitari. Jan, come noi lettori, è quello che viene dopo, il post-. Il suo metodo è l’indagine che scava nella memoria del padre: pone le sue domande, chiede un chiarimento.
František è ricettivo, paterno e fattuale allo stesso tempo. È, soprattutto, il testimone oculare, la vittima e l’oppositore che ha lottato per ottenere la democrazia di cui Jan, da un certo punto in poi della sua vita, ha potuto godere.
La conversazione segue, dunque, la parabola della vita di František: da partigiano, figlio di un partigiano, durante il regime nazista ad oppositore del bolscevismo durante il regime sovietico, per poi diventare un prigioniero politico. È proprio la scena del processo, quello che cambierà per sempre la vita di František, la scena introduttiva. Dopo la condanna, per aver aiutato alcuni fuggiaschi a passare il confine dall’allora Cecoslovacchia verso la Germania Ovest, František subirà l’umiliazione e la durezza dei campi di lavoro. E poi, una volta libero, il difficile rinserimento nella società.
Nella narrazione inevitabilmente vengono inglobati, oltre agli accadimenti storici, gli altri coprotagonisti di questa pagina nera della Storia. I “complici” ma anche i compagni di prigionia, che hanno aiutato František a non perdere di vista l’aspetto umano. Tempo confinato è inoltre arricchito da foto e dalle commoventi lettere che František inviò nel corso degli anni di prigionia a sua madre e suo padre.
Non voglio assolutamente fare l’eroe, ma nel considerare questa domanda ripenso alla situazione di allora, e in quel momento le possibilità erano queste: entrare nel Partito Comunista […] Oppure si poteva non fare niente, restare a guardare. La terza possibilità era opporsi al loro insediamento non democratico. Era questo il nostro caso, volevamo difendere i diritti democratici. Ciò significa che abbiamo scelto consapevolmente di opporci, considerandolo un nostro dovere, senza avere paura. Eravamo consapevoli anche delle conseguenze.
– Tempo confinato
Ho scelto di proporvi questa citazione perché mi sembra esemplificare al meglio il senso della vita di František Wiendl. Dalle sue risposte al figlio non emerge mai una volontà di eroicizzare le sue azioni. Quando piuttosto quella di sottolineare che la gente comune si è trovata a dover prendere scelte fuori dall’ordinario perché i tempi lo richiedevano. Di fronte a questa verità viene quasi spontaneo chiedersi “cosa avrei fatto al suo posto?” Giudicare da una posizione confortevole non è mai giusto. Forse lo sapremo quando la Storia chiamerà il nostro turno. Ma forse quell’ora è già arrivata.
QUI l’articolo originale: https://giochilinguistici.it/tempo-confinato-jan-e-frantisek-wiendl/
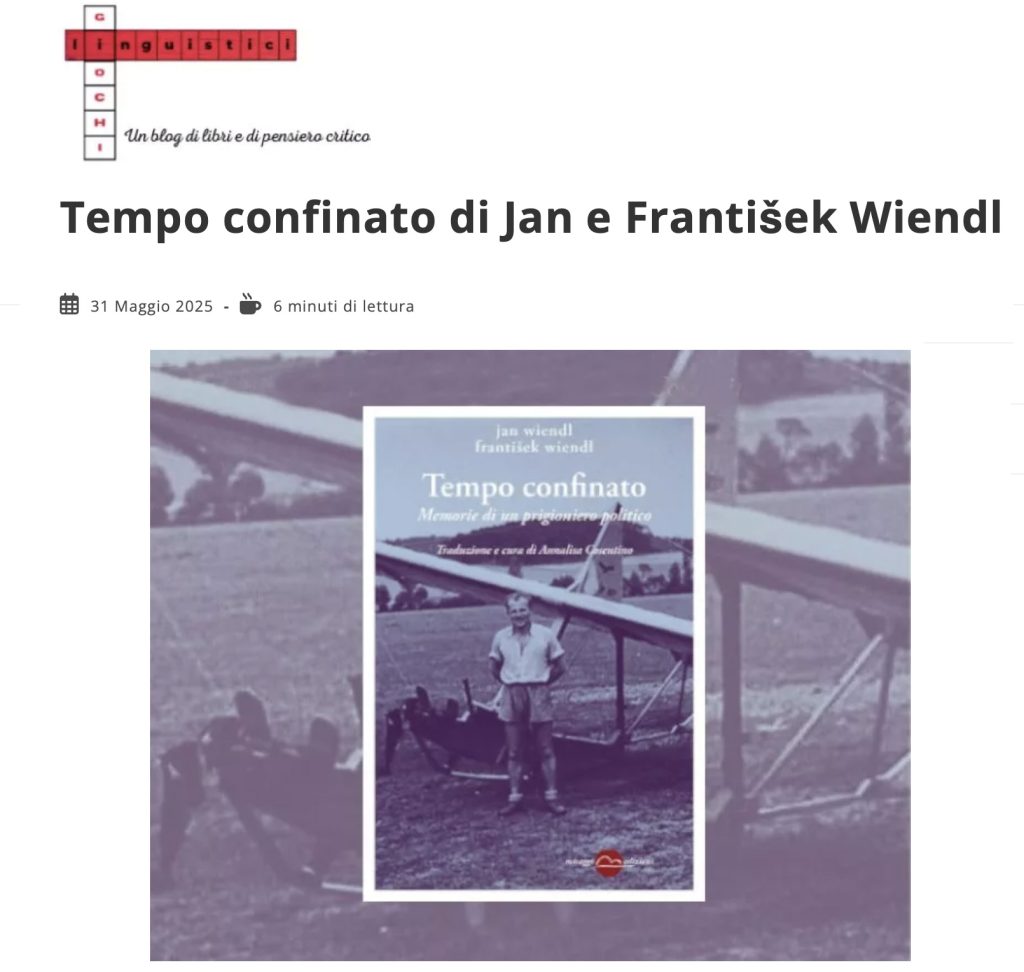

di Maria Dolores Pesce
In Europa tra fine ‘800 e inizio ‘900, per poi oltre proseguire, esplode, dentro una concezione borghese del patriarcato che riproponeva i consueti schemi di subordinazione e sudditanza ma insieme paradossalmente li smentiva nel trionfo della libertà personale e individuale, la contraddizione del femminile proprio per la sua (del femminile) nascente indisponibilità a farsi imprigionare in quegli schemi.
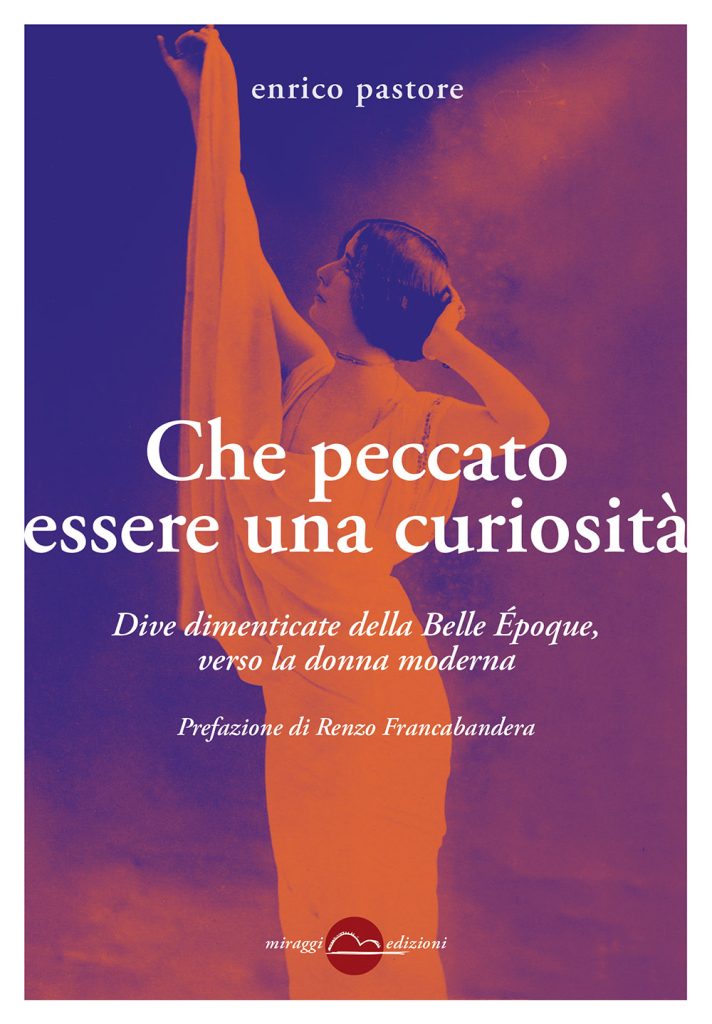
È innanzitutto la drammaturgia nordica ma non solo, tra l’altro quasi esclusivamente maschile, a farsi portatrice dei quella contraddizione e di quella indisponibilità che lo sguardo appunto maschile ‘pativa’ anche angosciosamente mentre, secondo l’insegnamento szondiano, contribuiva non poco alla crisi, speculare a quella sociale, del dramma moderno. Questo bel libro di Enrico Pastore affronta però il tema da un punto di vista diverso, quello delle artiste cioè, oggi diremmo performer, che non furono solo oggetto di quella mutazione ma se ne fecero concretamente carico subendone anche gli effetti. Non solo personaggi, da Salomè all’Olympya di Hofmannsthal, ma veri e propri corpi alieni che ribaltavano la percezione del femminile, incidendo sulla struttura stessa della rappresentazione. Nomi di artiste, da Sada Yacco a Cléode Mérode, da Edith Craig a Valentine de Saint-Point e Emmy Hennings, non a caso, come spesso capitava e ancora capita a molte artiste, praticamente dimenticate nonostante l’impulso essenziale che hanno saputo dare al rinnovamento del teatro. Ma non è un bagno di memoria, è soprattutto un riconoscimento di valore, dovuto e comunque tardivo. Forse altrettanto importante di quello che in precedenza segnò l’esordio sulla scena della donna, non solo come personaggio ma in carne ed ossa, e così capace di modificare anche il senso stesso del personaggio teatrale. Un lavoro importante e approfondito, come testimoniato dalla corposa bibliografia, quello di Enrico Pastore, definito da Renzo Francabandera nella sua prefazione non solo un’operazione di rottura, ma soprattutto di condivisione capace di dare l’avvio a forme sempre più complesse, nel Teatro e nella Società. Una dimostrazione ulteriore di come l’attività di quelle artiste ‘eversive’ non fosse rivolta esclusivamente alle donne nel teatro ma anche, modalità questa tipica del femminile, all’intero teatro e inevitabilmente alla intera Società. Un volume ricco e articolato da consigliare perché parlando del passato parla soprattutto al nostro presente.
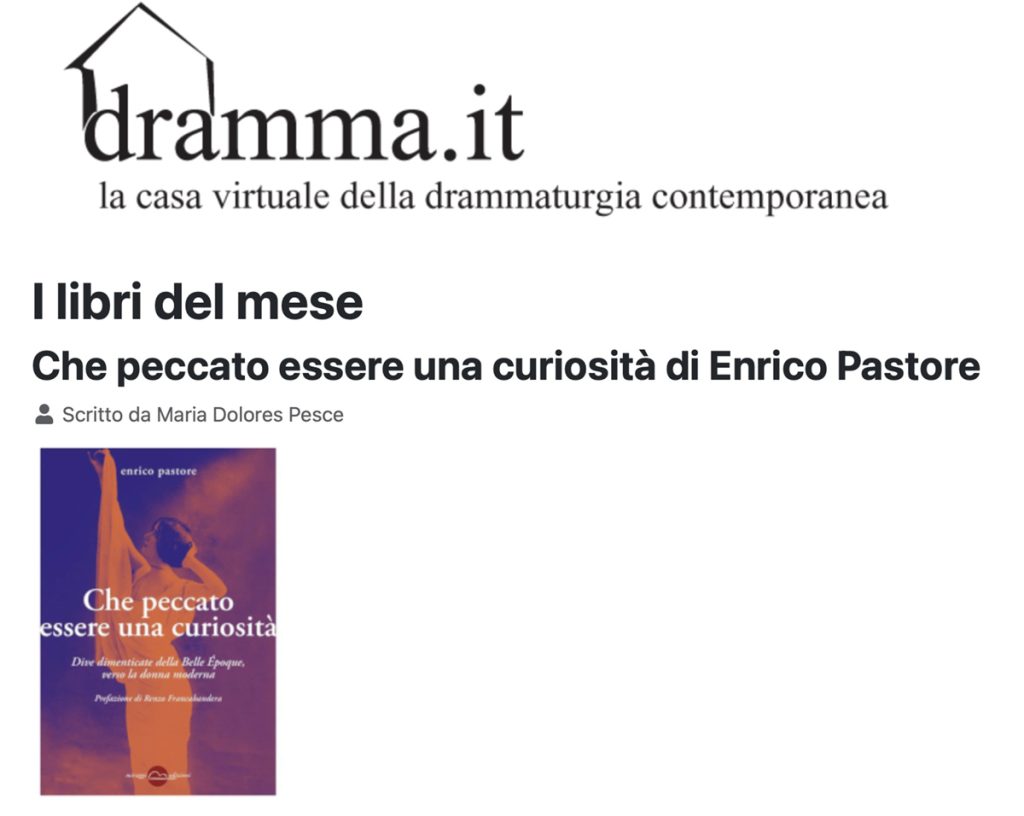
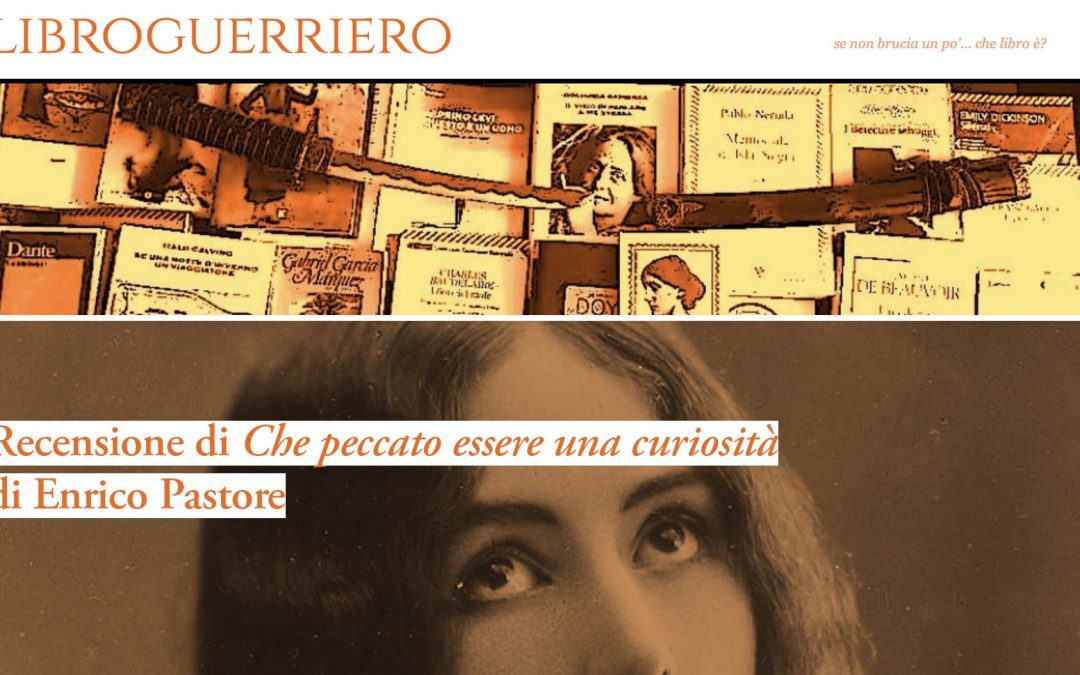
di Linda Cester
Molto interessante e ben strutturato il saggio di Enrico Pastore, recentemente pubblicato da Miraggi Edizioni con la prefazione di Renzo Francabandera, è un viaggio affascinante e coinvolgente negli anni a cavallo fra Ottocento e Novecento – periodo storico significativo e importante che ha visto l’Occidente nel suo massimo splendore -, alla riscoperta della vita e delle opere di cinque artiste straordinarie, che non solo hanno rappresentato le tendenze e le caratteristiche di un’epoca, ma che hanno anche lasciato, attraverso la loro grande personalità, un segno profondo nel difficile percorso di emancipazione della donna.
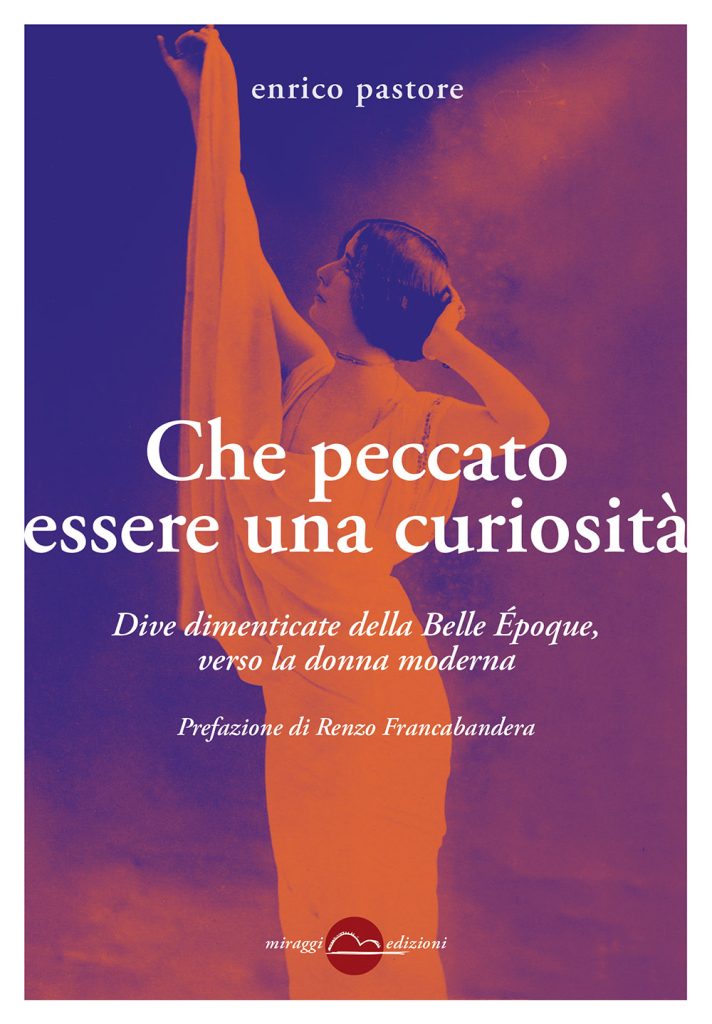
Un’opera che si inserisce nel solco di quella produzione letteraria preziosa, volta al recupero e alla valorizzazione di una serie di figure femminili – del mondo dell’arte, della cultura e non solo – che, colpevolmente dimenticate, hanno invece determinato un passaggio fondamentale nello sviluppo della costruzione dell’identità femminile moderna, protagoniste accantonate da quella Storia che ci appartiene e soprattutto ci riguarda tutte e tutti da vicino. Grazie a una scrittura scorrevole, mai pesante, capace di incuriosire il lettore cogliendo dettagli essenziali senza mai perdere l’armonia del discorso complessivo, Enrico Pastore ci conduce così in quegli anni vivaci e accesi della Belle Èpoque, fra cafè chantant, numeri di cabaret, danze ammalianti e spettacoli innovativi, fra le pieghe più interessanti e anticonformiste di una società frizzante in cui il teatro era uno dei mezzi di comunicazione più influente. Ed è proprio in questo luogo magico e così importante da un punto di vista sia culturale che sociale, che le donne, le artiste protagoniste del volume, hanno potuto imporre una propria visione rivoluzionaria della figura femminile, che non è più mite e rassicurante angelo del focolare, ma che diventa anima libera, emancipata, indipendente, intraprendente, lasciando che il corpo diventi campo di battaglia, fulcro significativo di una lotta che intreccia vita privata e pubblica, politica e svolte sociali, nella definizione di un nuovo approccio femminile all’arte scenica che spazia dalla danza all’espressione, dalla scrittura alla regia. Sada Yacco, Clèo de Mèrode, Edith Craig, Valentine de Saint-Point, Emmy Hennings. Cinque donne meravigliose, cinque modelli d’ispirazione, cinque dive purtroppo dimenticate, che grazie al saggio di Enrico Pastore ci vengono restituite in tutta la loro eccezionalità, capaci di lasciare un’impronta decisiva, concreta e duratura, in un mondo culturale, dove purtroppo l’opera delle donne, non solo teatrale, viene ancora vista come un’eccezione, o come direbbe Josephine Baker – e da qui il titolo del volume – “una curiosità”.
Un ultimo accenno merita in conclusione la copertina del romanzo, che grazie all’immagine della bellissima Cléo de Mérode riesce a evocare alla perfezione le atmosfere della tematica trattata incuriosendo il lettore.
QUI l’articolo originale: https://libroguerriero.wordpress.com/2025/05/30/che-peccato-essere-una-curiosita-di-enrico-pastore-miraggi-edizioni/2/
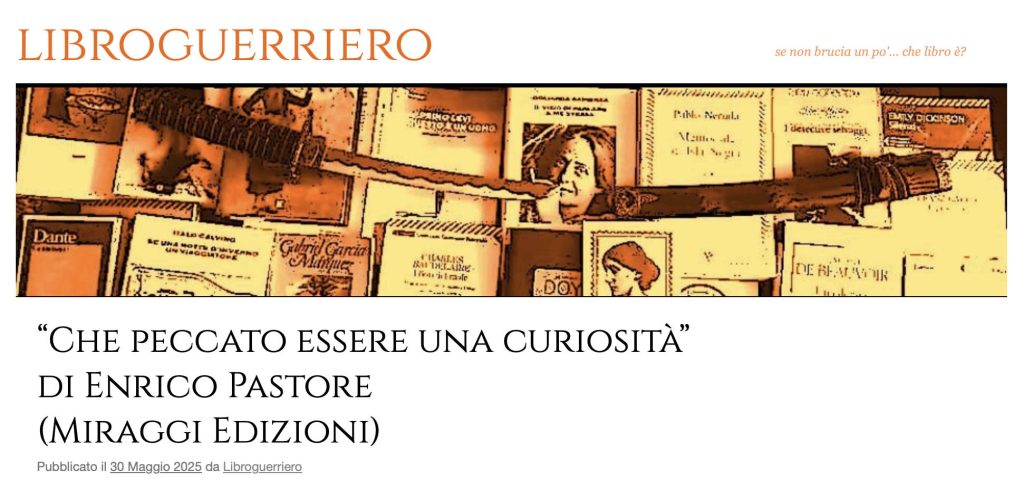
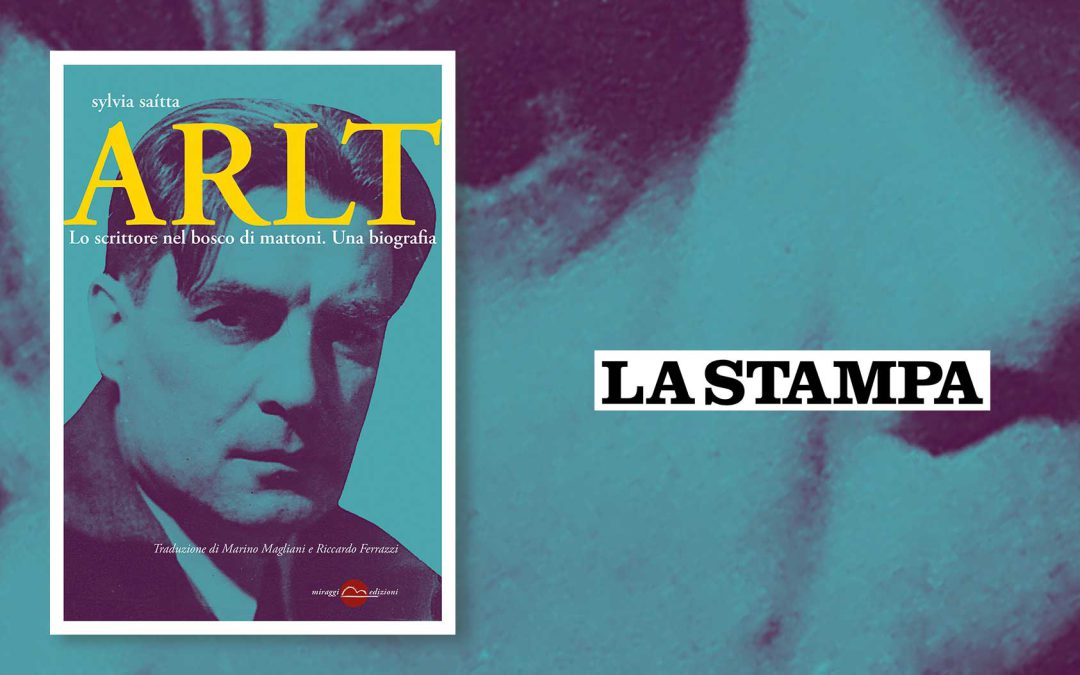
Incontro letterario lo scorso 27 febbraio al bar Ligure di Arma di Taggia promosso da Casa Balestra, di Molini di Triora, che scende così, per una volta, in riva al mare.
Ci saranno gli scrittori Giacomo Revelli e Marino Magliani, che ha appena tradotto (con Riccardo Ferrazzi) la biografia del collega argentino Roberto Arlt. Si soffermeranno inizialmente su questo testo. Toccherà quindi alla presentazione del libro «Arlt-Lo scrittore nel bosco di mattoni» di Sylvia Saitta (Miraggi Edizioni, Torino). Opera pubblicata nell’ambito del programma Sur di supporto alle traduzioni del Ministero degli Esteri. Conclusione con il libro «Il cannocchiale del tenente Dumont», uno delle rivelazioni dello scorso anno, scritto dallo stesso Marino Magliani. Quest’ultimo, scrittore di Prelà che si divide fra l’Italia e l’Olanda, sta vivendo un momento felice negli Stati Uniti dove i suoi libri sono saliti nella Top 20 dei più venduti. E, nelle versioni in inglese, sono venduti in Cina. Il suo ultimo libro è stato recensito, un termini molto favorevoli, da tutti i maggiori organi di informazione. M.C.
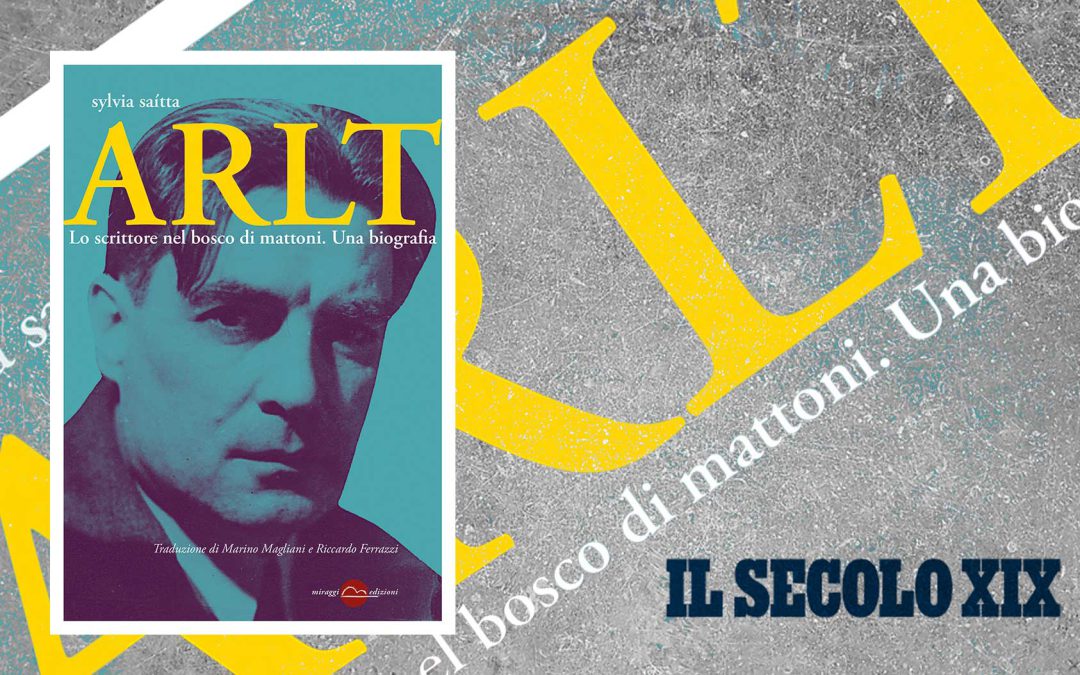
Evento letterario speciale ad Arma di Taggia, Marino Magliani dialogherà con lo scrittore Giacomo Revelli oggi alle 18 al bar Ligure, in piazza Tiziano Chierotti, organizzato dall’Associazione culturale Casa Balestra (in trasferta nell’occasione dalla sede di Molini di Triora).
In “Officina Magliani” i due protagonisti presenteranno la biografia dello scrittore argentino Robert Arlt tradotta da Marino Magliani e Riccardo Ferrazzi; si concentrerà poi l’attenzione sull’ultimo libro di Magliani. L’ingresso al bar Ligure potrà avvenire con Green pass, con consumazione obbligatoria. Si comincerà con il volume “Arlt-Lo scrittore nel bosco di mattoni” di Sylvia Saitta (Miraggi edizioni Torino), opera pubblicata nell’ambito del programma Sun di supporto alle traduzioni del ministero degli affari esteri, del commercio internazionale e del culto della Repubblica Argentina. Roberto Godofredo Christophersen Arlt, nato nel 1900 e deceduto nel 1942 a Buenos Aires, in Argentina, era uno scrittore, drammaturgo e giornalista. Figlio di un immigrato prussiano, KarlArlt, e di Ekatherine Iobstraibitzer, originaria di Trieste e di lingua italiana, ha pubblicato il suo primo romanzo nel 1926, “El juguete rabioso” (Il giocattolo rabbioso), la storia autobiografica di un ragazzino che fugge da scuola e si trova coinvolto in avventure di ogni tipo cercando di intraprendere una scalata sociale. Il secondo romanzo di Arlt, è stato “Los siete locos” (I sette pazzi) nel 1929, il terzo “Los Lanzallamas” (I lanciafiamme) nel 1931.
Al bar Ligure Marino Magliani presenterà il suo ultimo romanzo, “Il cannocchiale del tenente Dumont” (L’Orma editore). «Perché disertare non significa mica sbandato, uno sbanda e bene o male si risolve, ma disertare è qualcosa che non finisce, diventa una missione, una carriera. Un grado. A uno dovrebbero scriverlo sulla pietra». Marino Magliani vive tra la sua Liguria e la costa olandese, dove scrive e traduce. E’ autore di numerosi libri tra cui “Quella notte a Dolcedo” (Longanesi 2008), “L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi” (Exorma 2017) e “Prima che te lo dicano altri” ( Chiare lettere 2018).

Porta la firma di Marino Magliani, insieme a quella di Riccardo Ferrazzi, la traduzione dallo spagnolo del libro di Sylvia Saitta appena pubblicato da Miraggi Edizioni.
Il libro intitolato “Arlt. Lo scrittore nel bosco di mattoni. Una biografia” racconta la storia dello scrittore e giornalista di Buenos Aires, in principio incompreso, ma oggi considerato uno dei padri della letteratura argentina. Magliani, apprezzato narratore, è da sempre attivo anche come traduttore, sia dallo spagnolo che dall’olandese. Noè Jitrik, Haroldo Conti, José Luis Cancho e lo stesso Arlt sono alcuni degli scrittori tradotti dall’autore di Prelà.
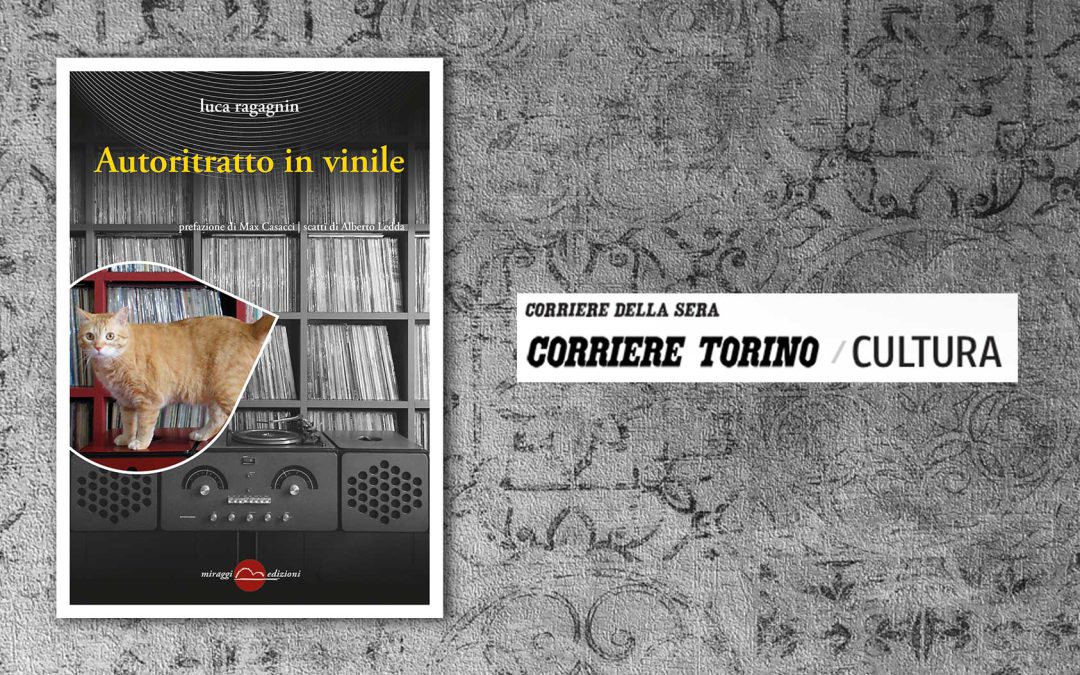
«Nei momenti difficili… sento il bisogno di ritornare lì. In quella camera dove tutto è rimasto classificato con amore, dove i titoli dei brani sulla copertina delle cassette sono battuti diligentemente a macchina, dove i momenti preziosi di quel passato restano custoditi. Il rifugio mentale che mi permette di non tradire mai la mia giovinezza». La scrive Max Casacci la prefazione al nuovo libro di Luca Ragagnin Autoritratto in Vinile edito Miraggi, con le foto di Alberto Ledda, che lo scrittore presenterà oggi alle 18.30 al Blah Blah in compagnia del leader dei Subsonica e di Flavio Ferri dei Delta V che si esibirà in alcuni brani tratti dal suo nuovo album Testimone di passaggio , i cui testi sono stati scritti in toto da Ragagnin.
In quella cameretta azzurra che ricorda Casacci lei ci è tornato.
«È stata la mia cameretta di bambino e oggi sono tornato a frequentarla come uomo adulto. Era diventata la stanza dei gatti di mia mamma Giuseppina, che era professoressa di lettere e che è stata la persona che mi ha trasmesso la passione per i libri, mi insegnò a leggere che ero molto piccolo. Cinque anni fa, quando è mancata, ho sfidato qualunque legge della psicanalisi e sono tornato in questa casa e l’ho ripristinata esattamente com’era 30 anni prima. Per prima cosa ho fatto ridare quell’azzurro che i miei amici ricordano alle pareti della mia stanza. È esplosa: ci ho messo dentro 30 anni di musica e di libri. Di dischi ne avrò sui diecimila titoli, i libri stanno intorno ai seimila. Tanti li comprai al villaggetto di bancarelle sotto il tetto di lamiera in corso Siccardi che purtroppo non c’è più».
È la casa di Luca grande o di Luca piccolo?
«Di Luca grande. Anche se non è facile ritornare nel luogo dove sei cresciuto. Negli ultimi anni ho scritto un grande romanzo, nel senso di dimensioni poderose, in cui c’è il tema dell’infanzia e della memoria, non è un memoir ma una storia composita che dovevo scrivere per andare altrove. Volevo chiudere i conti con quel ragazzino. Inizia negli anni 70 e finisce l’11 settembre. Uscirà il prossimo anno».
Cos’è invece «Autoritratto in vinile»?
«Un libro occasionale. Sono piccole scritture nate in un periodo in cui, ogni giorno per sei mesi, pubblicavo su Facebook un disco e un libro affiancati da alcuni miei aneddoti personali, ben lontani dal voler essere una critica musicale o letteraria. Ne pubblicai 150. Non sono mai più stato e né mai sarò tanto attivo sui social. Per il libro ne abbiamo scelti 50».
Quali?
«Con i ragazzi di Miraggi, che da qualche tempo è la mia casa editrice, siamo stati severi per eliminarne 100. Abbiamo scelto quelli dove entravo più come autore e meno legati al quotidiano. Non faccio il professorino della musica, ma c’è una sorta di proselitismo musicale un po’ nascosto: c’è molta musica anni 70».
C’è qualche brano del suo autoritratto che ama di più?
«Il primo, che è su Ummagumma dei Pink Floyd, un disco che entrò nella mia vita di quattordicenne nel 1979. La prima volta lo ascoltai in cuffia, e non c’erano i volumi e continuavo ad alzare. C’era un tappeto sonoro bassissimo che poi erompeva con un urlo agghiacciante di Roger Waters. Io, che avevo il volume al massimo, feci un salto terrorizzato e versai il caffè ovunque».
Da dove si parte per scrivere il testo di una canzone?
«È una questione di sartoria, bisogna mettersi al servizio completo dell’artista e della sua storia. Tutte le mie collaborazioni con vari musicisti sono nate in maniera spontanea. Nei prossimi mesi potrebbe cominciare un mio corso dedicato al song writing per i ragazzi che fanno trap. Per loro la parola è molto importante».
QUI l’articolo originale: