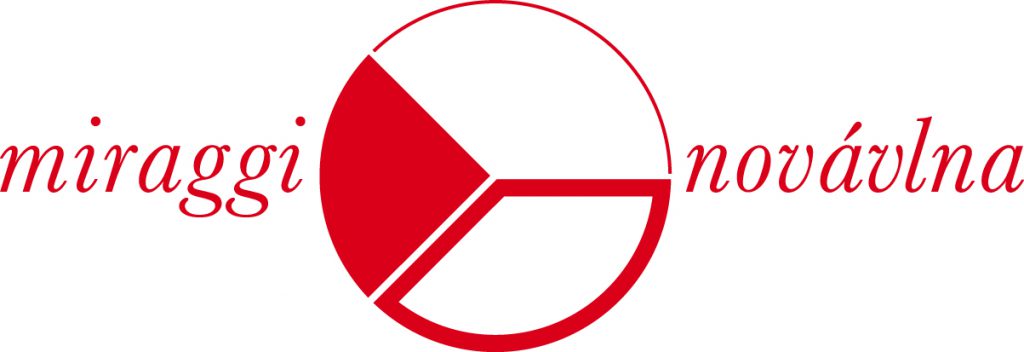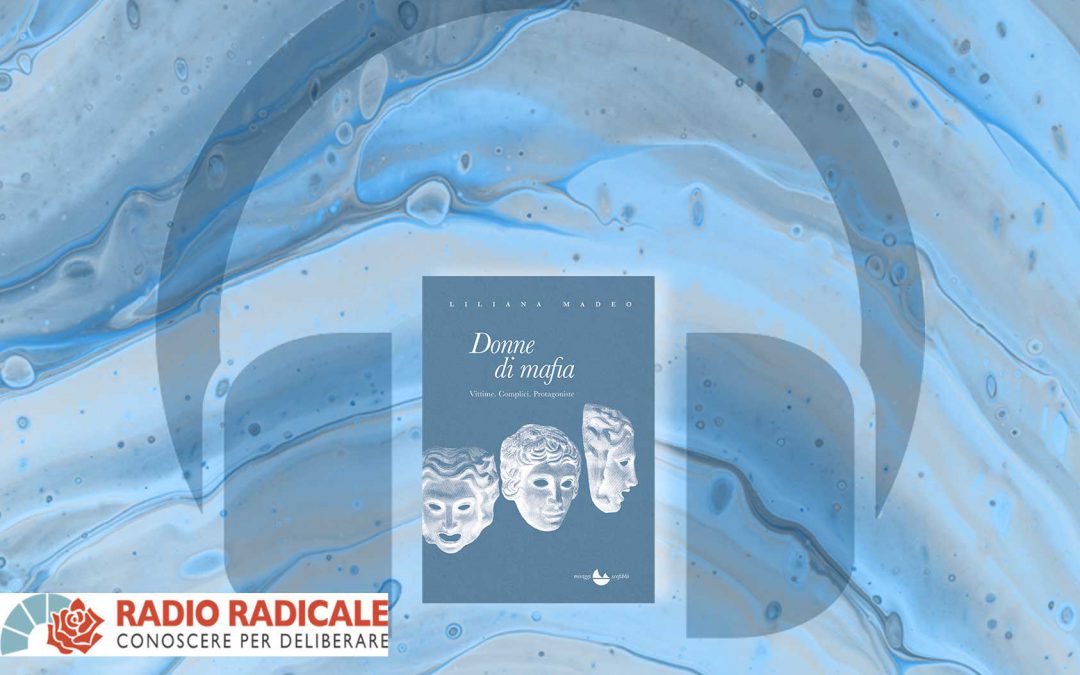
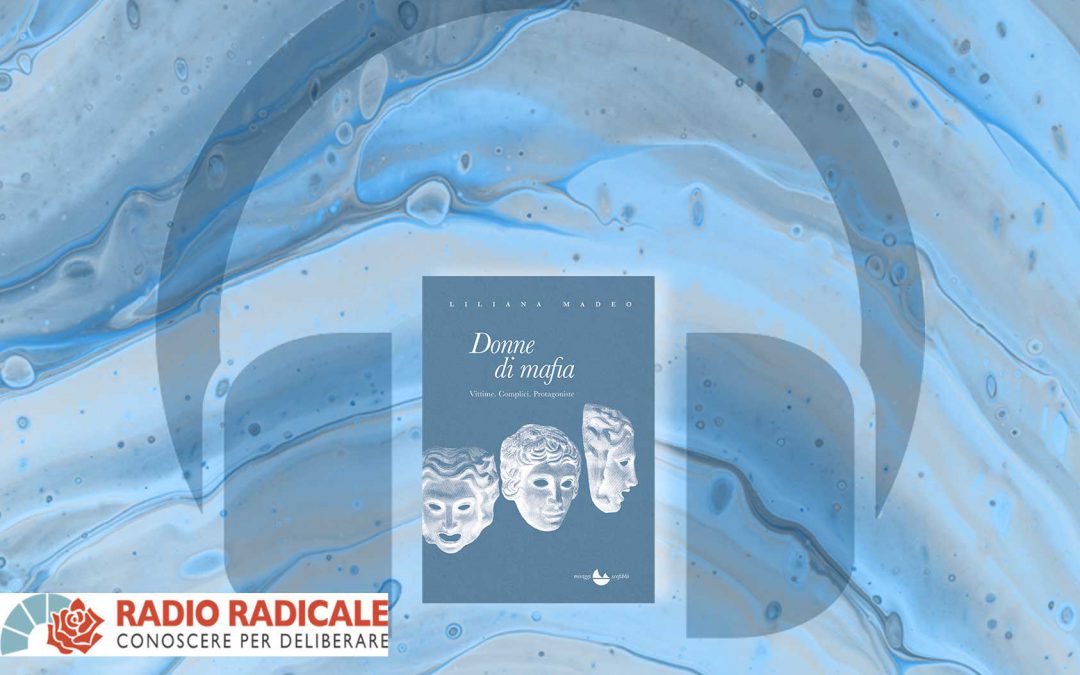
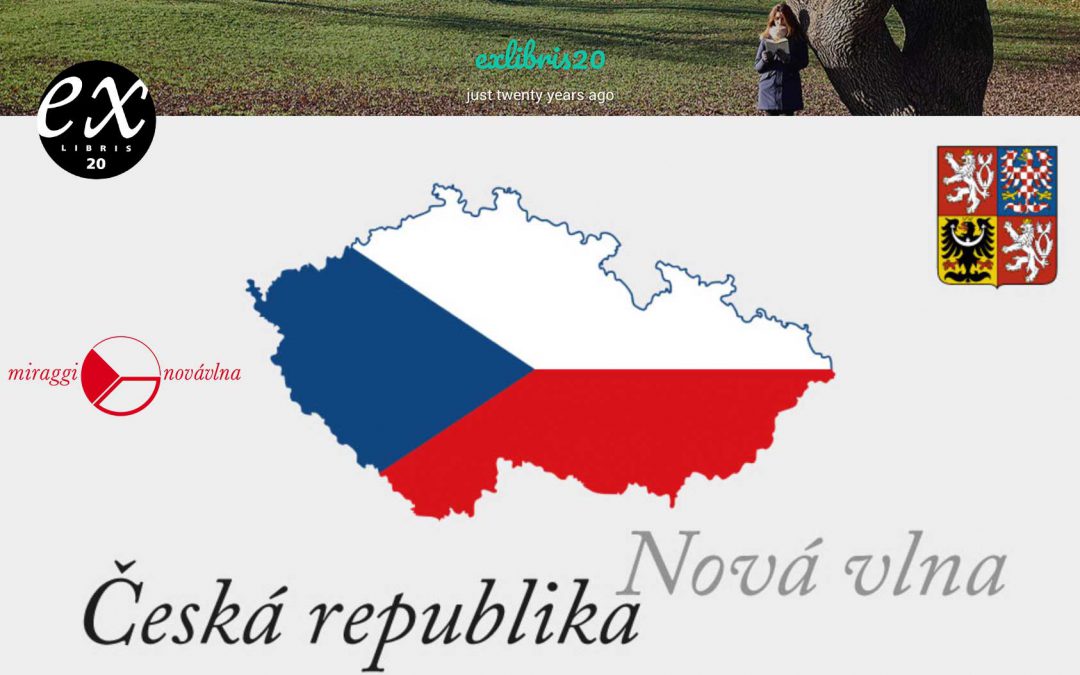
Nová Vlna: un’“onda” di autori europei dalla Repubblica Ceca – intervista ad Alessandro De Vito di Angela Vecchione su Exlibris20
Cinque domande per un editore.
Questo spazio è dedicato da qualche tempo alle case editrici che nella loro programmazione editoriale riservano uno spazio a una letteratura straniera in particolare. Questo appuntamento ha per protagonista la casa editrice Miraggi e nello specifico la linea NováVlna, collana di letteratura ceca curata magistralmente da Alessandro De Vito, editore e traduttore. Da cosa nasce l’esigenza di titoli appartenenti a una sfera culturale spesso accantonata in favore di un interesse angloamericano dilagante e spesso dominante in un paese come il nostro, da decenni anglofilo? Le risposte, le perle tradotte, le voci più autorevoli di un ambiente affascinante e storicamente vicino, nuovi autori e una riflessione sulla nostra identità di narratori in questa edificante intervista che riportiamo integralmente.
Miraggi e NováVlna.
1 – «NováVlna» è la collana dedicata alla letteratura ceca. Il nome Nová vlna, sia in ceco che in slovacco, vuol dire “Nuova onda”. Anche se trae origine dal movimento cinematografico degli anni Sessanta del secolo scorso, questa selezione di libri si promette di far vibrare nuovi stimoli. Da cosa è nato il vostro interesse per la letteratura ceca?
Come tutti gli amori, la decisione di dar vita a una collana interamente dedicata alla letteratura ceca nasce un po’ per caso, per accorgersi subito dopo che si trattava di una necessità. Innanzitutto per me: io sono per metà ceco, dire che non ci avevo mai pensato prima sarebbe troppo, ma sicuramente non sarebbe accaduto senza un’occasione. Qualche anno fa, con il fondamentale apporto e l’ispirazione di Francesco Forlani, straordinario esempio di intellettuale organico, disorganizzato e totale, con cui abbiamo poi stretto una grande amicizia, abbiamo cominciato a pensare alle traduzioni letterarie “laterali”. Abbiamo allora fondato la collana Tamizdat, primo embrione di quella casa editrice nella casa editrice che è diventata Miraggi Baskerville. Lì abbiamo inteso proporre testi “clandestini”, come erano quelli che circolavano di nascosto nei regimi del socialismo reale: libri che, mutatis mutandis, in moltissimi casi ci pareva fosse difficile vedere oggi in libreria, almeno in Italia. Dopo poco mi sono “ricordato” delle mie origini, ho preso a studiare sul serio il ceco, lingua materna che ho sempre parlato in casa, e nel giro di due anni abbiamo dovuto creare uno spazio specifico per quelle traduzioni, altrimenti la collana Tamizdat avrebbe subìto una vera e propria “invasione ceca”.
Così è nata NováVlna. Fondamentale è stato conoscere Laura Angeloni, una delle più esperte traduttrici dal ceco attive oggi in Italia, che collabora stabilmente con noi e ha tradotto quasi metà delle nostre scelte. Altrettanto importante è poter contare, in generale ma principalmente per le riedizioni dei classici, sul supporto del boemista Alessandro Catalano. A proposito dei traduttori mi preme sottolineare che quasi sempre hanno un ruolo da protagonista: non siamo noi a cercare qualcuno che traduca, ma chiediamo al traduttore di farci una proposta, così si finisce per lavorare su un proprio libro del cuore. Diamo importanza al traduttore, vero “veicolo umano” di lingua storie e cultura, sia ovviamente citandolo in copertina e risvolto, ma anche facendogli scrivere una nota di traduzione, che spesso coincide con la quarta di copertina e, se più articolata, è inclusa nel volume. Nessuno – e qui lo dico da traduttore – è così dentro e vicino a un libro di chi lo traduce.
Bisogna ammettere anche che la lungimiranza del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca dà a noi e a tutti coloro che si dedicano alla traduzione della letteratura ceca – lo stesso vale per altri Paesi – un importante supporto, finanziando generosamente la nostra attività e consentendoci di lavorare in tranquillità e di poter scegliere anche autori di grande valore ma meno commerciali, come è stato il caso di Jan Balabán (Chiedi a papà) di cui mi piacerebbe tradurre tutta l’opera. Autori che danno spessore all’idea stessa di letteratura, almeno alla nostra.
2 – In questa sezione trovano spazio testi della tradizione letteraria caduti nell’oblio. Vi occupate del loro recupero facendo un attento lavoro di ricerca, rintracciate esordi preziosi come quello di uno dei maggiori scrittori del Novecento Bohumil Hrabal, La perlina sul fondo, in uscita in questi giorni. Perché altre case editrici italiane, di dimensioni più grandi, secondo voi non hanno pensato di tradurre libri che avrebbero avuto esito tra lettori appassionati?
Uno degli intenti è proprio questo. Accanto alla proposta di nuovi autori ancora sconosciuti nel nostro Paese, da lettore prima che da editore, e certamente da lettore che ha frequentato quella letteratura in passato, stupisce, e personalmente mi addolora, se non è un’espressione troppo forte, che grandissimi autori e opere siano completamente dimenticati oggi. E si tratta di un duplice fronte: a volte si tratta di recuperare libri che erano giunti in Italia, soprattutto grazie alla meritoria opera di Ripellino, tra gli anni Sessanta e Ottanta: oltre a Einaudi ricordiamo la celebre collana diretta da Kundera dell’editore e/o. Essendo passati 40-50 anni, scegliamo senz’altro di ritradurli, ed è una sfida non da poco. Abbiamo cominciato da un mio vecchio pallino, che deriva dai miei studi in storia del cinema. Il bruciacadaveri di Fuks è un capolavoro letterario da cui è stato tratto subito dopo un capolavoro cinematografico, non mi davo pace del fatto che ormai fosse un libro solo per collezionisti. Tanto più che, riproposto oggi, racconta molto bene e sorprendentemente, pur a tanti anni di distanza, cosa sta accadendo alle nostre società oggi. Con umiltà, consapevolezza e studio pare che i nostri sforzi vadano nella giusta direzione.
In altri casi, come per la citata primizia di Hrabal, il primo libro pubblicato dal grande autore ceco, quello che l’ha portato al successo in patria nel ’63 dopo gli anni più bui dello stalinismo, si trattava di colmare incredibili vuoti editoriali con una prima traduzione. A volte le vicende librarie hanno dell’imponderabile, e non è facile risalire al motivo per cui di un autore così grande – e di grande successo – ancora oggi non sia stato tradotto tutto. Di Hrabal, con la relativa liberalizzazione della Primavera di Praga e l’eco che ebbe la sua repressione nel ’68, giunsero all’estero molte opere contemporaneamente, si spiega che allora si sia operata una scelta privilegiando soprattutto i romanzi, rispetto ai racconti della Perlina, che pure sono di uno scrittore ormai maturo, basti pensare che furono pubblicati quando aveva già 49 anni.
Detto questo, non siamo certo i soli, per fortuna, a tradurre letteratura ceca. Einaudi continua, pur con il contagocce (dell’anno scorso un altro inedito di Hrabal, Lezioni di ballo per anziani e progrediti), e Keller ne annovera parecchi nel suo catalogo, basato sulle zone geografiche dell’ex Impero Austro-Ungarico di cui anche la Boemia faceva parte. Splendido e consigliato l’ultimo Topol, che mi sarebbe piaciuto pubblicare: Una persona sensibile.
Siamo lieti e orgogliosi di fare la nostra parte, meglio per noi se altri ritengono che certa grande e grandissima letteratura “non valga più la pena”, per motivi commerciali o per mode che cambiano. Certo non è facile.

3 – “In passato come oggi la letteratura ceca è stata molte volte portatrice di freschezza e innovazione, col suo carattere ironico, grottesco e surreale, e la capacità di immergersi nelle profondità esistenziali.” Come selezionate gli autori contemporanei da proporre al pubblico italiano?
Pur esplicitandole in molte sfumature differenti la letteratura ceca – e direi cecoslovacca, tornando indietro nel tempo – ha delle caratteristiche tipiche, piuttosto riconoscibili, a volte più di tono grottesco e tetro, a volte più leggero e surreale, ma è vero, sempre teso alla profondità, a tuffarsi per “scorgere il fondo dell’animo umano”, per parafrasare ciò che Hrabal dice a proposito della sua Perlina sul fondo. Vivendo personalmente la doppia appartenenza italo-ceca, ho sempre trovato che sia molto stimolante vedere le cose con gli occhi degli altri, perché poi si torna a considerare diversamente anche le cose che si hanno sotto gli occhi. La Boemia, in fondo, è vicina geograficamente, ormai da trenta e più anni è accessibile, turistica, forse sarebbe il momento di conoscerla più a fondo, dato che è sempre stata parte della nostra stessa vicenda comune europea. Proprio per la divisione in blocchi durante la Guerra Fredda il solco è aumentato, e si sono interrotti rapporti culturali, e non solo, sia antichissimi sia più recenti. La Boemia era la regione più sviluppata dell’impero Austro-Ungarico, molti ignorano che tra le due guerre è rimasto il solo paese democratico dell’Europa centrale, la cosiddetta Prima Repubblica cecoslovacca, e uno dei più industrializzati. Un altro aspetto che mi piace ricercare, oltre la bellezza letteraria in sé, è proprio questo: avvicinare le due realtà, conoscersi a vicenda, perché siamo vicini… di casa. E si ritrova un po’ dappertutto, nei racconti “cinematografici” del regista Němec, i cui si trovano molte tracce “italiane” (Volevo uccidere J.L. Godard), nel romanzo della Pilátová che racconta la storia della famiglia Bata, che da più di un secolo mette le scarpe al mondo intero ed era ceca (Con Bata nella giungla), e per le similitudini delle vicende storiche: l’ascesa del nazismo a Praga nel 1938 nel Bruciacadaveri, o le questioni tra minoranza tedesca e ceca nelle zone di confine tra i due paesi, nei Sudeti, per tanti versi simili a quelle del nostro confine orientale (Grand Hotel e il prossimo I parenti di Germania, tutto incentrato su una divisione familiare a cavallo della cortina di ferro). Credo ci sia sempre da imparare.
Gli autori poi vengono selezionati secondo alcuni canali: sono tutti autori (e molte autrici) molto noti nella Repubblica Ceca, quasi sempre vincitori di Premi internazionali e nazionali come il Magnesia Litera, che ci vengono presentati da agenti letterari, da traduttori e che ormai troviamo anche direttamente. Sono giovani, sono sui social, ci si può conoscere, leggere ecc. e dimostrano un’accoglienza e un amore per l’Italia davvero grande. Sin da subito ho riscontrato lo stesso atteggiamento di curiosità, di apertura, e una cortesia non solo di maniera, anche in tutti i referenti degli enti con cui ci interfacciamo: Centro Letterario Ceco, a Praga e in Italia, case editrici e non ultimo il Ministero della Cultura. Capita spesso anche che, nonostante Miraggi sia una realtà molto piccola, oltre alla fiducia professionale si creino anche rapporti personali di stima, come è capitato con Bianca Bellová, straordinaria e originalissima prosatrice, di cui pubblicheremo presto l’ultimo libro, Mona, tra i primi al mondo. Certo poter usare la lingua mi facilita non poco il piacevole compito.
4 – Tra gli autori italiani contemporanei e quelli cechi, quali differenze riuscite ad evidenziare nello stile e nei temi trattati perché le vostre proposte editoriali possano definirsi imperdibili?
Difficile fare un discorso unico, prima abbiamo evidenziato alcuni possibili comuni denominatori, ma spesso oltre quelli ogni poetica autoriale è differente, così come lo stile. È come se fossimo di fronte una squadra in cui le individualità sono molto forti, per usare un paragone. Purtroppo da quando faccio l’editore il tempo che riesco a dedicare alla lettura è molto scemato, spesso “vado a vedere” e saltabecco, cerco di restare informato ma non sempre leggo libri interi. Oltretutto leggere in lingua per scegliere le nuove pubblicazioni, oltre all’attività di traduzione e alla direzione della casa editrice con i miei soci mi tiene davvero molto occupato. Parlerò quindi di una sensazione personale, che potrebbe essere fuori strada. Ho come l’impressione che salvo rari casi chi scrive in Italia – e ci sono autori di grande pregio, giovani e meno giovani – si rivolga maggiormente, quasi necessariamente, al pubblico italiano, o presuppongano una imprescindibile conoscenza del nostro ambiente. Senza meritare per forza l’accusa di essere “ombelicali”, forse, per così dire, mi pare che non alzino troppo la testa a uno sguardo sul mondo. Gli scrittori cechi, e sottolineo che vanno per la maggiore molte autrici donne, credo abbiano più interesse per storie più universali, forse perché vivono in un paese e in un sistema culturale più piccolo, si sforzano di più di essere meno provinciali, proprio perché hanno maggiore coscienza di non essere al centro del globo. Poi magari sono quelli e quelle che piacciono a me, per cui non posso dire di essere del tutto obbiettivo. Per cui la definizione di “imperdibili” forse è eccessiva, ma può essere molto utile, piacevole e sorprendente per il lettore italiano leggere punti di vista sulla contemporaneità che non siano né i nostri, né quelli “universali” e un credo un po’ troppo mainstream che provengono dall’influentissimo e pervasivo Occidente angloamericano. Ci sono particolarità e aspetti tipicamente centroeuropei che senza nostalgie otto e novecentesche sono ancora oggi in grado di produrre senso. Personalmente ho sempre trovato curioso, anche se comprensibile per il corso degli eventi, che si trovi più naturale riferirsi agli USA, a quel modo di vivere, rispetto a paesi che rispetto a due estremità del nostro stesso stivale italiano sono più vicini geograficamente e come storia secolare. La porta a Est, verso il mondo slavo, è stata sempre meno frequentata rispetto alla direzione opposta, e spesso identificata prevalentemente con la Russia. Molto ha fatto la koiné del dopoguerra, l’inglese, il cinema, la civiltà dell’immagine e dei consumi. Andiamo però a vedere di persona: traduciamo anche per consentire questo al lettore italiano.
5 – Parlaci dei prossimi titoli in uscita.
Compatibilmente con la situazione di blocco che stiamo vivendo, i lavori nella nostra cucina proseguono. La perlina sul fondo di Hrabal è pronto in magazzino, appena stampato, è stato un lavoro molto lungo e difficile, è un autore tanto piacevole e divertente da leggere quanto infido e particolare da tradurre. Laura Angeloni ha fatto un lavoro straordinario, e dobbiamo ringraziare moltissimo la disponibilità alla revisione e alla cura del volume del prof. Alessandro Catalano dell’Università di Padova, che con rara generosità (e direttive precise e puntuali) ci ha accompagnato con sicurezza in questa difficile impresa, corredando il testo, come nel caso del Bruciacadaveri di Fuks, con una utilissima postfazione critica.
Di seguito, e per forza di cose l’uscita slitterà a quando torneremo a una certa normalità, avremo il nuovo romanzo di Bianca Bellová, Mona, di cui abbiamo acquisito i diritti addirittura prima che il libro uscisse in Repubblica Ceca. Il lago, il precedente romanzo, è stato parecchio apprezzato, anche se non ha avuto una grande circolazione, in questo nuovo lo stile è sempre il suo, estremamente riconoscibile, per cui chi l’ha amato lo leggerà con piacere. Chi non la conosce ancora, li adorerà entrambi, e certamente la inviteremo di nuovo in Italia per qualche evento, in collaborazione con i Centri culturali cechi di Roma e Milano, che ci danno il loro fondamentale supporto.
Intervista a cura di Angela Vecchione
Per sostenere le librerie ordina da quella più vicino casa: scopri qui l’elenco.
QUI L’ARTICOLO ORGINALE:

Intervista a Alessandro De Vito su «Lidové Noviny», giovedì 2 aprile 2020
Ci vorrebbe un nuovo piano Marshall, dice l’editore Alessandro De Vito
Alessandro De Vito (1971) è ceco per parte di madre, ma vive e lavora in Italia. Dirige la casa editrice Miraggi, dove tra le altre pubblica traduzioni di scrittori e scrittrici cechi, per esempio Hrabal o Fuks, Bellová o Pilátová. Nonostante la pandemia abbia fermato la sua impresa, ritiene che il libro sopravvivrà.
LN – Qualche giorno fa avete pubblicato La perlina sul fondo di Hrabal. Oggi l’Italia legge, compra libri?
ADV – Miraggi, la nostra casa editrice, festeggia quest’anno 10 anni di vita, e il numero dei lettori è in crisi costante da prima che cominciassimo il nostro lavoro. Non sono più i tempi degli anni 80, e il libro, culturalmente, ha perso molta della sua centralità rispetto ad altre forme di formazione e intrattenimento, ma mantiene la sua importanza. Gli italiani leggono meno di altri paesi, è un fatto. Il mio punto di vista è quello di un piccolo editore, e in questo senso la situazione è confortante: i „lettori forti“, anche se non numerosi come percentuale, leggono molto e soprattutto cercano e scelgono anche le produzioni minori, le case editrici indipendenti.
Purtroppo il libro di Hrabal, molto importante per noi e per far conoscere di più tutta la collana ceca che pubblichiamo, arriva in un momento difficile, in cui è tutto fermo per la pandemia. Sarà un ottimo punto per ripartire, per fortuna è un libro senza tempo, un grande classico che gli italiani non hanno ancora mai letto.
LN – Qual è stata la tiratura de La perlina sul fondo? Hrabal è ancora popolare in Italia?
ADV – Di solito usciamo con una tiuratura di 2000 copie. Per Hrabal siamo saliti a 3000, è pur vero che Hrabal ha avuto il suo maggior successo una ventina di anni fa, ma un autore di quella grandezza ha l’attenzione dei lettori e dei recensori garantita anche oggi. Il supplemento letterario Tuttolibri del quotidiano nazionale La Stampa di Torino gli ha dedicato di recente 4 intere pagine! Hrabal è forse il più grande scrittore ceco del Novecento, e poter offrire al lettore italiano la prima traduzione del suo primo libro è stato un sogno per noi.
LN – Quali saranno le conseguenze della pandemia sul mercato librario italiano? Quali saranno i maggiori problemi per gli editori italiani?
ADV – La pandemia ha fermato tutta la filiera del libro, dal magazzino dell’editore alle mani del lettore. Io credo che adesso sia difficile vedere ancora tutti i problemi, dipenderà molto da quanto durerà questa situazione. Al momento ci sono libri fermi, librerie e canali on line chiusi, alcuni libri previsti nei prossimi mesi usciranno in ritardo per fare spazio a quelli già pronti ora. Sarà però molto diverso ripartire dopo 2-3 mesi, o se il periodo sarà più lungo. E dipenderà anche da come ne uscirà tutta la società, potremmo vedere una crisi economica molto forte per cui molti potrebbero avere altre e più grandi preoccupazioni che non comprare dei libri.
LN – La situazione attuale potrebbe portare anche qualcosa di positivo?
ADV – Credo che cambieranno molte cose. Il mercato del libro ha molti difetti, la distribuzione, l’eccesso di produzione, l’eccessiva rapidità di produzione e la velocità con cui i libri muoiono. Come piccolo editore siamo meno soggetti a questi meccanismi, noi lavoriamo sempre sul catalogo e molto meno sulla novità: spesso i nostri libri non vendono molto in un breve periodo come i bestseller, ma sul lungo periodo continuano la loro corsa per un tempo più lungo. In dieci anni non abbiamo ancora messo nessun libro fuori catalogo. È difficile dire ora come cambierà, credo che molte case editrici non si risolleveranno, e che le più grandi dovranno ristrutturarsi radicalmente e ripensare la loro attività. Almeno lo spero, che vengano anche cambiamenti positivi.
LN – Gli italiani leggono gli e-book? Ascoltano audiolibri? E questi potrebbero andare a colmare la perdita di libri cartacei che si prospetta?
ADV – Da anni gli ebook hanno una quota quasi costante nelle vendite, e non aumenta di molto. Negli ultimi anni anche gli audiolibri hanno riscosso un certo successo, ma per ora è un settore limitato. Sono convinto che entrambi aumenteranno le vendite, anche se una delle comprensibili reazioni in questa situazione è un’angoscia che molti descrivono come una difficoltà a concentrarsi e anche a leggere. Se la situazione dovesse durare sicuramente il settore venderà di più, e in generale c’è una spinta all’acquisto on line: anche la spesa ordinaria, e tutti i servizi che molti utilizzavano ancora in modo tradizionale. Non credo che arriverà mai a rimpiazzare del tutto le vendite cartacee, che in ogni caso riprenderanno. Per un piccolo editore come noi, che in proporzione spende molto per la stampa, sarebbe una buona cosa: a me piacciono molto i libri di carta, ma se vendessimo solo ebook, e molti di più, avremmo molte meno preoccupazioni. Non credo che accadrà: il libro è una tecnologia antica, e resta ancora oggi molto efficace, durerà a lungo ancora.
LN – Il governo italiano prevede degli aiuti per l’editoria?
ADV – Direi di no, in generale non esiste nulla del genere come i contributi del Ministero della Cultura ceco, che oltre a finanziare le traduzioni dei libri cechi all’estero sostiene la produzione interna con contributi per i vostri libri. Abbiamo dei contributi, più spesso regionali, per la partecipazione alle fiere come il Salone del libro di Torino, ma non mi viene in mente altro. Non esiste neppure un piano di acquisto generale dei libri da parte delle biblioteche pubbliche, come in altri paesi. Ma in generale l’Italia investe molto poco nella scuola e nella cultura, compreso l’immenso patrimonio artistico e monumentale che abbiamo ereditato.
LN – E sono previsti degli aiuti per l’attuale eccezionale situazione?
ADV – Per questa situazione di emergenza non ci sono a oggi ancora provvedimenti specifici: le case editrici sono ferme, le librerie sono ferme, le spese fisse vanno avanti (per esempio gli affitti) e ci sono solo provvedimenti molto limitati per i lavoratori, ma valgono per i dipendenti, quindi per le realtà più grandi. Sarà presto a disposizione un contributo di 600€ per i titolari di P.Iva, quindi anche per tutti i lavoratori autonomi che lavorano nella filiera senza un contratto da dipendente, come noi tutti. Non può bastare.
LN – Qual è l’umore nella società italiana?
ADV – Come sempre ci sono opinioni diverse, tra speranza, depressione e catastrofismo. La dinamica dei social network, quando sei costretto a casa, amplifica i suoi problemi: si diffondono fake news, false speranze, complottismo, ma abbiamo per la prima volta una rete che ci unisce, può anche informare correttamente e fornire aiuto, dare grandi e piccole indicazioni utili, per esempio sui negozi aperti, restare in contatto con le persone sole. Alla preoccupazione per il contagio si somma sempre di più la preoccupazione economica, ed è normale che si patisca anche psicologicamente il fatto di dover stare in casa e di non sapere come evolverà la pandemia. Credo che man mano la situazione sarà la stessa in tutta Europa, e in tutto il pianeta. Una volta passata l’emergenza, credo che dovrà esserci una risposta economica forte da parte di ogni singolo stato. RE non solo: anche da parte dell’Unione Europea o della Banca Mondiale. Una sorta di piano Marshall o un New Deal alla Roosevelt.
LN – La sua casa editrice pubblica regolarmente autori cechi, in ordine sono uscitiBalabán, Fuks, Rudiš, Bellová, Boučková, Pilátová. Cos’è che i lettori e i recensori italiani apprezzano in quei libri, che ccosa piace della letteratura ceca?
ADV – Al momento, anche se piccoli, siamo gli unici ad avere una collana interamente dedicata alla letteratura ceca, in passato il legame culturale è stato più stretto, grazie a persone come Angelo Maria Ripellino e per l’interesse per la dissidenza dopo la fine della Primavera di Praga. Io credo che i lettori accolgano bene il nostro progetto: da un lato riproponiamo autori già pubblicati in italiano molti anni fa, e ingiustamente dimenticati (come Ladislav Fuks), o pubblichiamo opere non ancora tradotte di grandi classici (come Hrabal). Forse non è molto, ma è un filo che non dovrebbe essere interrotto.
LN – Perché?
ADV – I due paesi sono molto vicini, moltissimi italiani vanno a Praga da turisti e non sanno nulla della cultura che vanno a visitare. Allo stesso tempo apprezzano lo sguardo dei nuovi autori e autrici. La letteratura ceca ha un modo molto personale di esprimere il suo punto di vista sul mondo, a volte più leggero e divertente, a volte più grottesco e tetro, ma sempre profondo. A lungo abbiamo guardato il mondo solo attraverso le vicende italiane, o attraverso il racconto degli americani. Cerchiamo di aprire un passaggio a Est. Molti ci dicono essere una strada giusta: verso il centro della comune storia europea.
LN – Ha personalmente tradotto alcuni dei libri che ha pubblicato. Lei è stato prima traduttore o editore?
ADV – Ho cominciato come editore, e da quasi vent’anni svolgo i vari mestieri intorno al libro. Come traduttore ho cominciato da poco, da 3-4 anni. E seguendo un percorso particolare e non canonico. Non sono un boemista e non ho mai studiato ceco o traduzione all’università. Sono però di origine ceca, mia madre è di Ostrava, e ho sempre parlato la lingua, anche se in casa e alla buona. Poi mi sono messo a studiarla, e avendo esperienza del lavoro con i libri ho messo insieme le cose. Ho studiato latino, greco antico e francese, e sapere il ceco mi ha sempre aiutato con tutte le lingue. Ora le altre lingue e la loro traduzione mi stanno aiutando con il ceco.
LN – Per lei il ceco è una lingua difficile? Più difficile dell’italiano?
ADV – Purtroppo non ho mai vissuto in Rep. Ceca, salvo le vacanze di ogni anno dai nonni nello Slovácko e a Slezská Ostrava, per cui ho una certa difficoltà a parlare e a scrivere in ceco. A leggere però lo capisco molto bene, in quel caso c’è tempo di studiare tutto del testo e conta molto la conoscenza della lingua di destinazione. Credo che per un italiano, e non è il mio caso, ci sia una difficoltà insormontabile, la pronuncia di alcuni suoni come la ř, e il fatto che sia una lingua flessiva. Per il resto la struttura del ceco e dell’italiano sono simili. Almeno rispetto all’arabo, al cinese o all’ungherese.
Radim Kopáč

PENULTIMI – intervista a Francesco Forlani su Radio Radicale
Ascolta l’intervista (4/11/2019)

PENULTIMI – intervista a Francesco Forlani su Radio GRP
Ascolta l’intervista

“Volevo uccidere J.-L. Godard” – Giovanni Fierro intervista Alessandro De Vito su Němec (Fare Voci)
Non dare la mano al cameriere

Un libro che è autobiografia e che si legge come un romanzo.
È “Volevo uccidere J.-L. Godard” di Jan Němec, che contiene trentuno racconti, pagine scritte dal 1970 al 1990, e che narrano la vita di questo importante cineasta cecoslovacco.
Testimonianza della sua vita artistica, e della sua vita di ogni giorno divisa dal periodo vissuto nella terra dove è nato e l’America, dove ha dovuto andare nel 1974, visto che in Cecoslovacchia gli veniva impedito di lavorare.
Perché Jan Němec, scomparso nel 2016, è stato uno dei nomi di spicco della Nova Vlna, la nouvelle vague cecoslovacca, e anche l’unico regista capace di filmare l’invasione di Praga da parte dei carri armati sovietici, il 21 agosto 1968, per poi varcare la frontiera con l’Austria, e far sì che all’indomani mattina la televisione austriaca mostrasse al mondo quelle immagini.
E Němec era anche sicuro di prendere un premio all’edizione di Cannes del 1968, ma al festival scoppiò il maggio francese e registi come Godard e Truffaut proposero di interromperlo, e non ci fu nessuna premiazione….
E allora la lettura di “Volevo uccidere J.-L. Godard” è un’immersione completa nella vita di Jan Němec, lo si accompagna nei suoi sogni di gloria artistica e di pura sopravvivenza umana, si intrecciano e si respirano mondi opposti, la Cecoslovacchia sovietica e l’America capitalista, dove sopravvisse girando film di matrimoni, e inseguendo progetti cinematografici che non si realizzarono mai. Per poi tornare a Praga alla fine del 1989.
Nemec è stato anche un autentico viveur, una anima irrequieta che amava le feste e le donne e che era sposato con una delle più grandi cantanti ceche dell’epoca, Marta Kubišová.
Sono pagine rocambolesche, si vivono situazioni surreali e divertenti, si respira la passione e la rabbia, sempre però con uno sguardo che mette nudità al tempo narrato, alla società in qui ha vissuto.
“Volevo uccidere J.-L. Godard” è lettura consigliata, e per la quale abbiamo intervistato Alessandro De Vito, che ha tradotto il libro in italiano, e che è anche uno dei fondatori di Miraggi, la casa editrice che lo ha pubblicato.

Dal libro:
“L’obiettivo della cinepresa può essere una piccola mitragliatrice, o cannone, e la verità, impressa sulla pellicola, può avere una forza, difensiva o offensiva, maggiore dei proiettili. Non a caso, qui da noi in America, usiamo la stessa parola per ‘sparare’ e ‘girare’: shoot!”
“Il cielo si chiuse. Nuvoloni neri si distesero su Praga. La cometa passò da qualche parte sopra di noi, ma nessuno poté scorgerla. Si era arrabbiata con noi, e vi aveva fatto sapere che non avrebbe scintillato, non si sarebbe accesa, dato che il nostro amico Jirka non c’era più.’”
“Lo scaltro Kgb aveva quindi scelto Lád’a K., e lui ci mandava dei segnali: anche in una società così disciplinata come uno stato comunista sotto la tutela sovietica, si poteva sempre trovare una breccia per essere individualisti, e perfino decadenti. perché il Filmexport cecoslovacco aveva bisogno di film da poter proporre in Occidente, prendere dei premi ai festival, e giustificare così l’esistenza dei suoi uffici all’estero, che erano solo un’altra forma di spionaggio rispetto a quella dei consolati o delle agenzie di viaggio bulgare, tramite le quali metti che si organizzi un attentato al papa.”
“Ah, comunisti e russi, divoratevi pure il cuore del continente, che mi avete rubato! Io non ci sono più.”

Intervista ad Alessandro De Vito:
(traduttore di “Volevo uccidere J.-L- Godard)
Quale la differenza fra lo Jan Němec ceco e quello ‘americano’? Ma anche tra il regista cinematografico e il narratore?
La differenza, purtroppo per lui, è ed è stata enorme, tra gli anni in Cecoslovacchia e quelli dell’esilio negli Stati Uniti. Negli anni 60, in patria, durante la Primavera di Praga, seppure fosse un giovane regista, aveva dimostrato a più riprese un talento fuori dal comune, uno stile assolutamente personale, realizzando dei veri capolavori che meritano di restare nella storia del cinema, già il corto “I diamanti della notte” e soprattutto “La festa e gli invitati”, film visionario e filosofico, sottile e crudo nell’indagine della natura umana, già molto maturo.
Němec è stato anche molto abile a insinuarsi – insieme ad altri giovani registi che hanno fatto parte di quella straordinaria Nouvelle Vague cecoslovacca (citiamo solo Forman, Menzel e Passer, venuto a mancare pochi giorni fa) – tra le maglie della censura e nel meccanismo di produzione cinematografica di Stato comunista, rivolgendolo a proprio vantaggio. Evidentemente l’invasione sovietica del 1968 ha interrotto tutto.
Era inoltre un personaggio noto pubblicamente, dato che allora è stato anche sposato con la più nota cantante ceca dell’epoca, Marta Kubišová, che è come dire Mina in Italia negli anni 60.
Ma anche le similitudini….
Certamente Jan Němec era un carattere particolare, deciso, sarcastico, autoironico, con un’irruenza che è stata sinonimo di energia e forza, di ricerca indomita della libertà e dell’arte, ma anche un ostacolo. Un’incapacità al compromesso, ancor più in senso artistico che politico, che l’ha danneggiato maggiormente negli USA, dove per lavorare bisogna sottostare alle regole dello show business delle major cinematografiche.
Non era il genere di persona capace di mandare giù dei rospi.
Passando alla narrazione scritta e parlando di similitudine, è la parola migliore per descrivere quanto il suo modo di narrare con parole sia simile alla sua visione cinematografica.
Cosa porta del suo sguardo da regista in questo suo narrare? E come lo usa?
Jan Němec è un regista anche mentre scrive. Non evoca, vede, sceglie il punto di vista, inquadra, monta le scene e fa vedere. Spesso nei suoi racconti, sempre basati su esperienze vissute, troviamo immagini, tagli, inquadrature, descrizioni che sembrano “scritte” con la macchina da presa più che con la penna, un andamento registico più che da scrittore.
A volte questo provoca anche qualche salto nella narrazione, anche se bisogna tenere conto che i racconti sono stati scritti nell’arco di vent’anni, dal 1970 al 1990 circa, e a volte in situazioni personali precarie.
Non è una scrittura pulita e levigata, ma assomiglia molto anche a lui: troppa energia per poterla contenere sulla pagina. Il che aggiunge interesse, spesso si ha l’impressione di essere davanti a lui che racconta, seduti davanti a un bicchiere di vino (non birra).
Nel libro, pur immergendosi in situazioni sempre intense, dove le persone si incontrano e si scontrano, dove c’è sempre l’accadere come punto focale del narrare, mi sembra di percepire un profondo senso di solitudine. Può essere così?
Io credo che derivi dall’esperienza vissuta, il dover abbandonare il proprio amato paese, il fatto di non aver nemmeno potuto lottare contro lo stato delle cose. Negli anni da espatriato è stato certamente un uomo solo, si è dovuto arrangiare, non è riuscito mai a lavorare al suo livello.
Per vivere ha trascorso anni a inseguire progetti poi non realizzati, mantenendosi realizzando film privati di matrimonio. Ma è soprattutto la personalità, fortissima ed egocentrica come capita negli artisti più grandi, che emerge con una forza che si impone. È allora la solitudine dell’artista, unita a un punto ideologico non trascurabile: l’esaltazione della libertà individuale, o dell’individualismo tout court, in un paese dominato da una società e da una retorica collettivista pervasiva, allora era un fatto politico.
Lo stesso titolo originale del libro, che letteralmente sarebbe “Non dare la mano al cameriere”, che si riferisce a uno dei racconti, esplicita questo pensiero. In quel caso l’esaltazione di un comportamento che si può definire classista (un suo amico, artista anche lui, celebre perché “non dava la mano al vecchio cameriere”, non con fare sprezzante, ma per tenere una distanza.
Con le sue parole: “Il nostro credo era questo, e penso lo sia ancora: vogliamo spassarcela un po’, andate a fare in culo, bolscevichi, voi e i vostri programmi, i piani quinquennali, i processi e le riabilitazioni. Raccontavamo queste cose alle ragazze, completando quel rapido giro panoramico della città. Ogni tanto bevevamo un bicchierino, facevamo un giro anche contromano e stavamo bene, perché sapevamo che nessuno ci avrebbe manganellato per un reato contro lo Stato”.
Volevano essere dei giovani liberi, non diversamente dai loro coetanei occidentali.

Jan Němec è sicuramente un autore fuori dal coro. Quanto questo gli ha permesso di sviluppare una propria originalità, e quanto invece è stato un qualcosa di limitante, anche in prospettiva politica nella Cecoslovacchia sotto il controllo sovietico?
Němec era certamente fuori dal coro, ma in realtà il “gruppo” dei registi della Nová Vlna… non era un gruppo. C’erano sostegno reciproco, collaborazioni, un background comune, in fondo venivano dalla stessa scuola di cinema, la Famu, e lavoravano tutti negli studi di Barrandov, la Cinecittà di Praga, ma ognuno portava avanti le sue idee, soprattutto dal punto di vista estetico.
Ed erano lasciati liberi di farlo, Němec stesso afferma che si erano trovati in una condizione di libertà creativa difficilmente eguagliabile: (quasi) senza censura, e con tutti i mezzi produttivi a disposizione.
Finito tutto questo con l’invasione, all’estero sono riusciti a sfondare in pochi, dovendo fare i conti anche col reperimento di risorse, con i produttori. Forman è il campione di questo successo in occidente.
Quale la caratteristica più evidente del suo scrivere, e cosa ha significato tradurlo?
La lingua che usa Němec è piuttosto antiletteraria, quasi orale, gergale, estremamente viva. Pur non mancando di riferimenti “alti”.
Non era uno scrittore, spesso i racconti li potremmo immaginare come dei soggetti per film da girare, un po’ più distesi. Raccontati di persona, in modo molto vivido, con una mescolanza di registri molto marcata, tra l’epico del patriottismo, della propria terra tradita e schiacciata dall’invasore, e un’aneddotica personale che ci fa sogghignare amaro o scoppiare a ridere (come nel racconto in cui ci rende noto che ci si può salvare da un infarto grazie allo sforzo muscolare per non farsela addosso: era in compagnia di una signora, diamine!).
Questo ha portato una certa difficoltà di traduzione dovuta alla varietà del contenuto, ampiamente compensata dalla vita che fuoriesce prepotente tra le righe.
È stato bello passere dei mesi con Jan Němec, che purtroppo ho incontrato una sola volta di persona, poco prima che morisse.
Il libro è scritto a più riprese dagli anni settanta ai novanta. Cosa tiene assieme questo ampio lasso di tempo?
È un ventennio esteso, dato che nei primi racconti si parla degli anni 60. È un’epoca tutto sommato omogenea, il grande cambiamento avverrà alla fine dell’89, con la caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti.
E il racconto si interrompe qui, con il rientro a Praga nel dicembre 89. Non a caso, credo.
Appena ritornato, pur con difficoltà, Němec è tornato a fare il regista, in modo indipendente. Credo sia evidente che la scrittura fosse il surrogato della regia, nei lunghi anni in cui non ha potuto o non è riuscito a realizzare film.
Poi ovviamente è un racconto autobiografico, l’autore è protagonista, e persino quando prevale il racconto di eventi storici importanti, come l’invasione di Praga o il famigerato Festival di Cannes del 1968, lui non va sullo sfondo. È lì, e non è un comprimario.
Anche l’immagine di copertina dà l’idea di un Jan Němec sempre in continuo movimento. È così?
Credo non potesse stare fermo. Emanava luce e movimento quando l’ho conosciuto, due mesi prima di morire, malato su una carrozzina, possiamo immaginare durante tutta la sua vita. L’immagine di copertina richiama uno dei momenti topici del racconto: lui che si aggira per la Praga invasa dai carri armati sovietici con la sua auto sportiva e la macchina da presa, con un certo sprezzo del pericolo, il 21 agosto del 68.
La sera stessa riuscì rocambolescamente (e naturalmente con l’aiuto di una bella donna, altra sua passione eterna) a portare i negativi a Vienna e a far quindi vedere al mondo – documento unico – che cosa stava succedendo davvero a Praga. Non il “fraterno aiuto” degli altri popoli socialisti, ma un’invasione militare. Quel materiale, montato con altro, è diventato il toccante documentario “Oratorio per Praga”.
Quale l’eco della sua fama di regista in Europa, in Italia, nel mondo?
Němec è nella storia del cinema, nell’ambito dei festival (in Italia soprattutto Trieste) viene ancora ricordato e omaggiato, specialmente le sue opere degli anni 60. Ha conosciuto la maggiore notorietà internazionale sull’onda anche emotiva dell’invasione di Praga, grazie soprattutto alle immagini dell’invasione.
(Jan Němec “Volevo uccidere J.-L. Godard” pp. 283, 20 euro, Miraggi edizioni 2019)
Il traduttore:
Alessandro De Vito, classe 1971, lavora in campo editoriale da quasi vent’anni.
È tra i fondatori di Miraggi Edizioni nel 2010, di cui ne è direttore editoriale ed editor.
Per metà di origine ceca, da qualche anno è appassionato traduttore da quella lingua, ispiratore e responsabile, sempre per Miraggi, della collana di letteratura ceca NováVlna.
Il regista ed autore:
Jan Němec, scomparso nel 2016, è stato sempre considerato l’“enfant terrible” del cinema cecoslovacco, l’irriverente, lo sfrontato, quello senza mezzi termini e mezze misure.
Rispetto ai compatrioti Jirí Menzel e Milos Forman, entrambi Premi Oscar, ebbe meno successo, ma fu uno dei nomi di spicco della Nova Vlna, la nouvelle vague cecoslovacca, e l’unico regista a filmare l’invasione di Praga da parte dei carri armati sovietici, il 21 agosto 1968, gesto che lo rese inviso al regime.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

Simone Ghelli (La vita moltiplicata) intervistato da Gianluca Massimini su Lankenauta
“Immobile dinanzi alla distruzione, come l’osservatore esterno nel Naufragio della speranza dipinto da Caspar David Friedrich, Iuri ebbe una visione nitida del quadro che aveva davanti: la realtà era lì a due passi, tumultuosa incandescente, fatta di banchi che si scontravano – proprio come le lastre di ghiaccio nell’opera del pittore tedesco – e che promettevano l’avvento di un mondo nuovo, finalmente libero (forse) dal dominio delle apparenze.”
Abbiamo letto di recente, e con vero piacere, il nuovo libro di Simone Ghelli La vita moltiplicata, una raccolta di racconti edita da Miraggi Edizioni che ci ha colpito per la potenza data dall’autore all’onirico, allo psichico, alla vita interiore dei personaggi, che in questo moltiplicare la vita cercano una via di fuga dalla vita stessa, da una realtà che spesso li sconfessa, li disattende.
Abbiamo approfittato della sua disponibilità per porgli qualche domanda.
Innanzitutto, come è nata l’idea di questo libro, di questa raccolta?
Le mie raccolte sono nate sempre a posteriori, nel senso che dopo un po’ mi sono reso conto di aver scritto dei racconti che avevano per così dire un’aria comune, un’atmosfera che li teneva insieme. Non sono mai partito dall’idea di una raccolta, da un filo conduttore da seguire. È qualcosa che realizzo soltanto dopo. Ovviamente, una volta deciso di metterli insieme, ci torno sopra. Èsuccesso così anche con questa.
Hai affermato in più occasioni che le tue due ultime raccolte di racconti (Non risponde mai nessuno e La vita moltiplicata) andrebbero lette insieme, che ci sono dei fili sottili che le uniscono. Puoi chiarirci meglio questo aspetto?
Le considero un po’ come i due lati di un disco. La raccolta Non risponde mai nessuno è arrivata dopo un lungo periodo di crisi in cui niente di quello che scrivevo mi piaceva. Quando ho realizzato che ero finito in un vicolo cieco, in cui la spasmodica ricerca di una lingua mi aveva fatto perdere del tutto il gusto per la storia, ho sentito il bisogno di rimettere per così dire i piedi per terra. E così sono venuti fuori dei racconti che qualcuno ha definito realisti, degli spaccati di vita in cui emergono delle figure che potremmo definire, con tutto il rispetto per Verga, dei vinti. Dopo quel libro sono riuscito a ripartire da dove ero arrivato; non a caso il primo racconto de La vita moltiplicata, cioè Oboe d’amore, era già uscito in una raccolta di autori vari (Toscani maledetti, a cura di Raoul Bruni) nel 2013. Quello era stato il punto in cui mi ero arenato e dal quale ho ripreso, ovvero l’esplorazione, per mezzo della lingua e dello stile, della dimensione più onirica e inconscia della vita.
Si tratta perciò di due raccolte a specchio, dove il riflesso del realismo è il fantastico. A unirle c’è proprio questa polarità.
Quasi tutti i personaggi de La vita moltiplicata mettono in mostra un tentativo di fuga o di ribellione che prende forma attraverso l’onirico o lo psichico. Questo succede in Oboe d’amore, ne La somma dei secondi e dei sogni, in L’ultima vetrina… Ma la realtà è davvero cosi terribile come sembra?
La realtà sta diventando sempre più complessa, evolve a una velocità che supera le umane possibilità. Questo si traduce, dal mio punto di vista, in una sorta di vita fuori sincrono (a meno che non ci si accontenti di sopravvivere senza provare a capire), in cui gli strumenti a nostra disposizione sembrano sempre insufficienti a comprendere fino in fondo le cose, le connessioni tra i fatti e le persone. Inoltre questa velocità mi pare che tenda ad assottigliarci come esseri, costringendoci a vivere sempre più in superficie, senza avere il tempo di sentirci in profondità. La televisione e internet sembrano dirci che la nostra immaginazione sta già tutta là fuori e così il nostro inconscio (non è un’idea mia, lo diceva già Serge Daney a proposito della televisione), tutto a portata di clic o di telecomando, tracciabile e remunerabile. Messa così direi di sì, che la realtà un po’ terribile lo è.
Si potrebbe parlare, nel caso de La vita moltiplicata, di letteratura o di scrittura onirica? Saresti d’accordo con questa definizione?
In alcune parti direi di sì. Ci sono pagine in cui si potrebbe parlare addirittura di scrittura automatica, o qualcosa del genere. In altre è come se mi fossi messo davanti ai miei personaggi e li avessi psicanalizzati, in certi casi addirittura ipnotizzati.
Fa eccezione, mi è sembrato, il Giovanni de La scatola nera che, di fronte al futuro funesto che sembra attendere la nostra specie, va in giro a far campionamenti, registrando suoni e rumori per poi rimodularli a piacimento, con vero estro artistico. Si potrebbe leggere in questo suo modus vivendi la volontà di riscattare la realtà stessa? E potrebbe essere letta, questa sua predisposizione nei confronti della realtà, anche come una metafora dell’attività dello scrittore?
La figura di Giovanni è un po’ ambigua e in un certo senso leggendaria, perché nel racconto sono gli altri a parlare di lui. Esiste davvero? Chi può testimoniare della sua attività? Si potrebbe dire che Giovanni voglia salvare la realtà, che voglia risarcirla di una dimensione estetica. In questo senso sì, potrebbe essere letta come una metafora dello scrittore, o almeno di un certo tipo di scrittore. Credo che in effetti sia quello che cerco di fare io, anche se i tempi in cui viviamo sembrerebbero dirci che uno scrittore del genere, che creda nel compito di riscattare la realtà, sia destinato al fallimento. Eppure è proprio questo che mi spinge a insistere.
C’è un racconto di questa raccolta al quale sei particolarmente legato per motivi o vicende personali o perché ti ha dato particolari soddisfazioni?
Direi Vera, perché è quello in cui ho sperimentato di più, in cui mi sono veramente lasciato andare, in cui ho abbandonato il controllo per seguire il flusso, superando così il mio limite più grande come scrittore.
Se posso permettermi una domanda più personale, cosa c’è di Simone Ghelli nei personaggi del tuo libro, nelle vicende da loro vissute?
Come sempre c’è molto: ci sono ad esempio le esperienze lavorative (il postino, la fabbrica, la scuola, il call center). Io parto sempre dall’esperienza, anche quando si tratta di trasfigurarla. Credo che in fondo sia così un po’ per tutti, non s’inventa certo dal niente. Io sono la somma di quello che sento, di ciò che ho sperimentato con tutti i sensi, compreso tutto quello che non registro consapevolmente. Vedo ognuno di noi come un cinema ambulante: siamo pieni di immagini, di suoni e parole che dobbiamo soltanto trovare il modo di tirare fuori componendole in nuove forme.
Un aspetto che non è stato ancora messo in luce dei tuoi racconti è, a mio avviso, il legame che essi hanno con il cinema. In una mia lettura de La vita moltiplicata, già apparsa su Lankenauta, ho avanzato l’idea che si possa in fondo leggere la tua raccolta come una sorta di cronofotografia alla Muybridge, come quella evocata nel tuo L’ineluttabile, attraverso la quale, con l’ampio spazio che dai alla vita interiore dei personaggi, metti assieme più momenti, più immagini delle storie di ognuno di noi per cogliere la vita umana nel suo movimento, nel suo farsi. Cosa puoi dirci del legame tra la tua scrittura e il cinema?
Si tratta di un legame fortissimo e la lettura che tu dai della raccolta è assolutamente pertinente. D’altronde il cinema è l’arte su cui mi sono formato, almeno teoricamente. Quella dello scrittore la definisco la mia terza vita, ed arriva dopo quella di musicista prima e di critico cinematografico poi. Le due persone a cui è dedicato il racconto L’ineluttabile fanno infatti parte della mia vita universitaria, quando studiavo il cinema sui libri di Deleuze (e non solo, ma a Siena, alla fine degli anni Novanta, quella corrente di pensiero rappresentava un po’ lo spirito del tempo).
Nel mio caso l’influenza del cinema riguarda sia l’immaginario che un certo modo di vedere – l’importanza dunque del punto di vista, ma anche del montaggio. Quasi sempre inizio a scrivere partendo da un’immagine e procedendo per immagini. Per me è molto importante che il lettore riesca a vedere attraverso le mie parole.
A cosa è dovuta la tua predilezione per il racconto? Qual è la tua idea su questa forma letteraria?
Il racconto è stato definito in tanti modi. Non saprei dire in che cosa consista veramente, se non che necessita di una scrittura in cui ogni riga deve sembrare necessaria. La differenza dal romanzo è essenzialmente questa. In un racconto non ci dovrebbe essere una singola parola superflua, nemmeno una virgola. È esattamente questo il motivo per cui trovo estremamente faticoso lavorare a un romanzo. Per quanto io continui a provarci, ormai da tempo, c’è sempre un momento in cui mi viene naturale isolare l’idea da cui sono partito e trasformarla in un racconto. E poi non riesco ad andare avanti se non sono convinto fino in fondo di quello che ho scritto prima. Non credo che sia possibile scrivere un romanzo a queste condizioni, senza concedersi la libertà di qualche sbavatura.
È opinione diffusa che il racconto sia un qualcosa di semplice, addirittura di occasionale, o peggio ancora il fratello minore del romanzo. Qual è la tua opinione in merito?
Che il racconto sia più semplice del romanzo è una sciocchezza, così come l’idea che possa essere un esercizio per avvicinarsi a quest’ultimo. Per molti scrittori e addetti ai lavori il racconto è anche un modo per farsi conoscere e arrivare alla pubblicazione con un editore; alcuni arrivano addirittura a paragonarlo alla palestra (e con esso le riviste e i siti letterari dove i racconti si pubblicano), dunque a un mezzo per allenarsi e farsi i muscoli. Questa è esattamente la visione che porta poi a considerare il racconto come il fratello minore del romanzo. L’ho già detto che è una stupidaggine? Ecco, lo ripeto, perché il racconto, così come qualsiasi altra forma letteraria, presenta delle difficoltà proprie. Anzi, a dirla tutta penso che sia più difficile scrivere un buon racconto che un buon romanzo, perché nel racconto i trucchi si svelano più facilmente (ok, questa l’ho presa da Carver). E questo è il motivo che mi fa un po’ imbestialire quando vedo che certe riviste di racconti chiedono di scriverne ai romanzieri solo per avere il nome di richiamo in copertina, come se fosse automatico che un romanziere sappia scrivere un buon racconto. Che stupidaggine!
Tu che hai praticato entrambe le forme: il racconto e il romanzo, in base a cosa decidi se usare l’una o l’altra quando hai un tema da proporre? Come cambia l’atteggiamento dell’autore quando si accinge a scrivere l’una o l’altra? E come lavora?
Ho scritto due romanzi, anche se in parte non li considero tali. Il primo (L’albero in catene, pubblicato da NonSoloParole nel 2003) è una specie di viaggio che ho intrapreso senza avere la minima idea di dove stessi andando a parare e, complice anche il fatto che ogni capitolo abbia un titolo, non sono pochi quelli che lo hanno letto come se fosse una raccolta di racconti. Il secondo (Voi, onesti farabutti, pubblicato da CaratteriMobili nel 2012) è stato definito romanzo, ma io lo considero piuttosto un’invettiva, un pamphlet in forma romanzata. Non credo insomma di aver mai scritto un vero e proprio romanzo e questo mi rende difficile rispondere alle domande successive. Immagino che scrivere un romanzo significhi avere ad esempio a che fare con degli schemi, delle schede coi personaggi, tutto un lavoro sulla struttura che mi fa annoiare al solo pensiero. Come ho già detto, per me il racconto parte da un’immagine, dal tentativo di mettere in risalto ogni dettaglio di quell’immagine e trovare il punto (quello che Roland Barthes definisce il punctum) verso cui la storia inizia a precipitare.
Dopo La vita moltiplicata cosa devono aspettarsi i lettori che amano Simone Ghelli? Quali sono i tuoi progetti futuri? A cosa stai lavorando?
In questo momento non sto lavorando a niente di preciso. Leggo, studio e metto da parte le idee. Il lavoro di insegnante, che amo, mi porta via la maggior parte del tempo. Sono fortunato perché è la parte più bella della scrittura: quella in cui s’immagina.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

Intervista With Love a Domenico Mungo a cura di Natalia Ceravolo
> 1) Domenico, raccontaci come e dove è nato il tuo Whit love?
Kurt Cobain era Cristo.
Kurt fece una cosa che solo Cristo avrebbe potuto compiere. Resuscitare un morto. Un morto che si chiamava rock’n’roll. Non solo il punk, non solo la musica alternativa, ma tutto il rock era morto nel 1994: Rock is dead!
E Kurt con quel colpo di fucile a spappolargli il cranio sembrò scuotere il cadavere del rock. E a lui lasciare il passo. Perdendo l’anima. Precipitata nell’inferno.

Missione di questo libro è prelevare l’anima di Kurt Cobain da quell’inferno e spedirla dove merita. Nel nostro amore. Trascinarlo via da quell’inferno rosso e zolfo, col cranio sfondato e il cartello “Suicida” posto al collo nel museo delle cere dove lo hanno messo fra Jimi Hendrix e Jim Morrison, nel “club dei 27. Ma Kurt non era come loro.
No, Kurt morirà più come Cesare Pavese o come Céline. Con un colpo di fucile che fa esplodere il cinema che ha nel cervello. Come uno scrittore o un poeta, non come una rockstar. O forse sì. O forse, ancora, come un grande regista stanco di continuare a girare lo stesso film con un copione già scritto.
Ma With Love è anche la formula attraverso la quale ho sempre cercato di vivere la mia esistenza. Ho sempre vissuto seguendo il sentimento, la passione, quello in cui credo e credevo e riversandovi sopra tutto il mio amore. E naturalmente questa prerogativa ad affrontare la vita in maniera impulsiva, passionale, con il cuore e raramente con il cervello ha avuto i suoi effetti collaterali talvolta fatali per me.
With Love è questo libro dedicato agli anni Ottanta e Novanta, alla Torino tossica, creativa, pregna di vita pulsante, alternativa a se stessa, figlia della rabbia operaia e alla ricerca della propria dignità e della propria identità delle esperienze antagoniste di quella sequenza sgamba di lustri che cambiarono il mondo, la politica, la musica, l’arte, il pensiero, Torino stessa e la mia vita. I gruppi, le case occupate, gli scontri, le occupazioni. I dischi, i libri, le avventurose prime esperienze musicali in prima persona, l’epopea effimera ma significativa della mia band, gli Unconditional poi Malasangre, condivisa con i padri fondatori Nino Azzarà e Marcello Marcelli che ancora annovero tra i miei amici più cari.
Le case occupate ovvero Le isole felici in un mare di niente e noia. Quelle corazzate di stoffa nera che attraversavano i marosi di asfalto e pregiudizio per creare avarie nel sistema e sopravvivere a esso.
With Love è la dichiarazione d’amore a una città e alla sua gente che ho amato, odiato, ripudiato. Una città che non mi ha mai accettato del tutto, che mi ha spesso deriso e sputato via e che io ho voluto invece sempre vivere fino in fondo.
With Love è uno sfondo sul quale si dipana una colonna sonora digrignante, romantica, caotica, rumorosa, poetica come non mai da allora in avanti. Il brulicare di pensieri e azione della mia vita si è innestata sugli accordi dei Nirvana, sicuramente, ed è per questo che ne ho fatto il tema fondante di questo romanzo/antiromanzo, ma anche di tutti gli altri libri di sangue che suonavano, urlavano, pregavano e creavano linfa allora e nei secoli a perpetua memoria.
With Love è una confessione, mia ma anche di Kurt. Kurt che per molti è un esempio da rinnegare, per altri un’icona da santificare. Per me il miglior cantante chitarrista che avrei mai potuto arruolare in una band di cover dei Pixies.
Questo non è l’ennesimo libro sui Nirvana. In senso stretto non è nemmeno una biografia di Kurt Cobain. È un tentativo falso di trovare la mia verità. È un’aureola di pattume che orbita intorno alla testa sfondata di Kurt. E attorno alla mia vita. È un mobilificio dove costruire finalmente la bara a forma di cuore in cui riporrò tutti i miei demoni. E i suoi. Per sempre.
> 2) A che lettore ti rivolgi?
All’universo mondo che desidera vivere la sua esperienza terrena with love…
> 3) Se fosse un farmaco sarebbe…
Imodium
> 4) Descrivi il tuo libro con tre aggettivi tre?
Maleodorante e sensuale come lo spirito di un adolescente.

Intervista a Francesco Forlani di Mirco Salvadori su Rockerilla
L’essere underground
Francesco Forlani, sembra manifestare una certa renitenza ad essere qualcosa, o almeno qualcosa di fissato. Forlani è infatti un dissipatore, un dispositivo di dispendio che esiste in quanto si rilascia e sperpera nel mondo. Forlani si produce nel mancare a se stesso, è quella cosa che è dove prima sarebbe stato, e dove dopo era stato, perché non è mai quello che è appena stato e che sta or ora per essere. È una migrazione continua, un esiliarsi incessante, una sparizione perpetua, che, come certi animali selvatici, è identificabile solo dalle tracce del passaggio, borre, escrementi, carcasse delle vittime, impronte, ricordi annebbiati. Con termine moderno, è il performativo, o il processuale, colui che si definisce in itinere. Ne consegue che la sua dimensione esistenziale è il viaggio, quella narrativa il romanzo picaro, quella espressiva e stilistica, di volta in volta, il video extravagante, la performance teatrale, la scrittura evasiva e noncurante, o addirittura, quella sorta di linguaggio extradoganale e metastorico che si è inventato a proprio uso, e che si potrebbe chiamare il forlanese. Infine per Forlani vale molto l’amicizia, che è quella forma di rapporto sociale libero e liquido, come si dice oggi – il solo non istituzionalizzabile – che gli permette di amare senza essere qualcosa.
Questo scriveva il poeta Livio Borriello di te in occasione dell’uscita di Parigi, senza passare dal via (Contromano-Laterza). Ti riconosci in questo identikit?
Molto e ricordo che in occasione dell’uscita del manifesto del comunista dandy (ed Miraggi) anche il critico letterario Francesco Durante, riprendeva questo tema della mobilità e mi definiva «tra i personaggi più interessanti del nuovo underground letterario italiano». Sono di quelli, non tantissimi, che non vivono di letteratura ma per la letteratura. Underground per me significa aristocrazia che distingui con un solo colpo d’occhio dal sottobosco culturale che vive e vegeta nel paesaggio italico contemporaneo. Da cinque anni sono tornato a Parigi.
Se penso al tuo passato, rimango colpito da quei tre anni che hai trascorso a Napoli come allievo della Scuola Militare Nunziatella. Conoscendoti mi chiedo come mai quella scelta e come ne sei uscito.
Un mio amico editore e gallerista Andrea Semerano, della Camera Verde di Roma, con cui ho condiviso molti bei progetti, diceva che l’umanità si divideva tra chi era stato in collegio e chi no. Penso che sia vero perché l’essenziale di una vita per uomini e donne, si forma in quella età dell’adolescenza. È alla Nunziatella che ho scoperto il valore dell’amicizia, della parola data, il senso che trovi alla sofferenza solo quando è condivisa e soprattutto la forza della mia vocazione letteraria che faceva i conti con una carriera militare tutta in discesa che sarebbe stato utile e conveniente perseguire. E invece no, dovevo fare della mia vita quello che sapevo avrei amato che fosse e mi iscrissi a filosofia. Ricordo che all’epoca mi riconoscevo nei Mods, e il mio amico di Frosinone Stefano Stirpe mi aveva fatto conoscere tutto il mondo delle fanzine e il meglio dell’underground compreso Rockerilla. Alla Nunziatella esistevano delle vere e proprie micro comunità legate all’Underground e questo non deve meravigliare più di tanto se si pensa che da quella scuola era uscito quindici anni prima il fondatore dei Bisca, Giancarlo Coretti e ancor prima Eugenio Barba dell’Odin Teatret fondato ad Oslo.
Sei originario di Caserta, frequenti spesso l’Italia e la tua Terra ma hai deciso di vivere a Parigi. Qual è il motivo di questa scelta?
Le mie radici me le porto a spasso da sempre facendo attenzione ogni tanto a fargli risentire l’odore della terra dell’origine. Per farti un esempio, il progetto della rivista Sud che porto avanti dal 2003 con Giuseppe Catenacci, presidente onorario degli ex-allievi, ha sempre avuto base a Napoli, al Rosso Maniero della Nunziatella e attraverso la rivista sono riuscito a mantenere attiva la “cellula” creativa e soprattutto affettiva di tante persone con cui avevo mosso i primi passi. Parigi è la città in cui sono nato tipo tre secoli fa e con cui mi sono ricongiunto per necessità di destino. Ad Aprile esce un mio nuovo romanzo che ho scritto in francese per l’editore Leo Scheer, e questa cosa s’iscrive nell’estetica della dissipazione di cui parlava Livio Borriello voce tra le più significative, insieme a Viola Amarelli, della terra irpina.
Da frequentatore di circoli (che brutto termine) letterari indipendenti, come vedi la situazione della nostra letteratura ‘indie’, uso un termine desueto ma esemplificativo. Diversamente della nostra musica in pieno conflitto e disfatta – salvo rarissimi casi – contro l’appiattimento verso il basso, esistono realtà combattenti?
La vedo in piena forma nelle forme che conosco e in qualche caso frequento. Innanzitutto a livello editoriale ci sono molte realtà relativamente giovani che hanno occupato lo spazio della qualità letteraria disertato dall’editoria storica e tradizionale. Potrei citarti innanzitutto la casa editrice torinese Miraggi di cui seguo alcuni progetti ma anche le romane l’Orma, NN, Exorma, i napoletani della Wojtek, la cagliaritana Arkadia, gli abruzzesi della Neo, Transeuropa a Massa, la romana Fefé, Liberalia a Bari, La città del sole, di Reggio Calabria, la casa editrice Zona di Caserta, e altre decine di belle realtà che potremmo definire indy. Per quanto riguarda la Rete il discorso non cambia. Le reti carsiche dei blog collettivi continuano il loro lavoro ininterrottamente contro ogni profezia che ne decretava la fine con l’avvento di Facebook. Lo stato di salute di realtà come Minima Moralia, Le parole e le cose, Nazione Indiana di cui faccio parte da una quindicina d’anni mi sembra invece contraddire tali previsioni e premiare il carattere esploratore e visionario dell’Underground.
Siamo ospiti di pagine che si occupano prevalentemente di dischi, anche se la sezione letteratura è ben rappresentata. Chi ti segue, al pari di chi segue un musicista, colleziona i tuoi libri. Amerei tu ne parlassi, descrivessi la tua bibliografia così come si fa con una discografia, dalle ispirazioni iniziali ai contenuti dei vari volumi.
Sai che facciamo? Li metto in fila e li associo a una traccia tipo Mix.
2020 Par-delà la forêt (romanzo)Léo Scheer,
Tear Drop MASSIVE ATTACK
2019 Penultimi (poesie e prose illustrate)Miraggi,
Le vent nous portera NOIR DÉSIR
2017 Peli (pamphlet) Fefè,
Das Model KRAFTWERK
2015 Manifesto del comunista dandy Miraggi,
Internazionale FRANCO FORTINI – IVAN DELLA MEA
2013 Parigi, senza passare dal via, Laterza,
Redemption Song JOE STRUMMER & THE MESCALEROS
2012 Il Peso del Ciao (poesie) Arcolaio,
As time goes by BRYAN FERRY
2012 Turning Doors (romanzo) Quinta di Copertina,
(I can’t get no) Satisfaction DEVO
2011 Le chat noir (graphic novel) con Raffaella Nappo, Camera Verde,
Vienna ULTRAVOX
2010 Blu di prussia (poesia erotica) con Dinahrose, Camera Verde,
All of Me BILLIE HOLIDAY
2009 Autoreverse (romanzo), Ancora del Mediterraneo,
Love Will Tear Us Apart JOY DIVISION
2008 Manifeste du communiste dandy, La camera verde,
Je suis snob BORIS VIAN
2002 Métromorphoses (racconti),Nicolas Philippe,
Psycho Killer TALKING HEADS
1990Posti a sedere per la Primavera (romanzo), Pleiadi,
Abbassando AVION TRAVEL.
Leggendoti si comprende che il confine tra prosa e poesia per te è assai indistinto. Mi riferisco particolarmente a Penultimi, il tuo toccante ultimo volume da poco uscito per Miraggi, edizioni di cui parleremo più ampiamente in seguito.
Credo di avere lo spirito del jazzista, ed è come se ingaggiassi sempre una sfida con il pensiero, la storia, attraverso la frase. Ho bisogno di un ritmo sulla pagina, e a seconda dei tempi, che si tratti di poesia o di prosa, di teatro o di canzoni, ho sempre disegnato le frasi secondo una metrica, un tempo. Da questo punto di vista devo dire che molto ha contribuito un lavoro quasi trentennale con musicisti. Penso a Rosario Natale, violinista, Massimiliano Sacchi, dei Ringe Ringe Raya, a certe incursioni con Canio Loguercio, Sacha Ricci, con il clarinettista Louis Sclavis, Marco Rovelli, Rosario Tedesco, con il sassofonista Gianni D’Argenzio, con Lamberto Curtoni violoncellista e alla recente esperienza al Nexst di Torino insieme alla Lite Orchestra di Verona. Ma è soprattutto con Massimiliano e Franck Lassalle, fisarmonicista, che lavoro dagli anni novanta. E quando scrivo li sento vicino anche se il lavoro non è destinato a un progetto musicale. Questo ritmo, devo ammetterlo, lo sento davvero compiuto nella lingua che mi sono inventato per il teatro, e penso allo Zazà et tuti li ati sturiellet, o al recente Miss Takeche abbiamo portato in scena con Sergio Trapani all’Istituto di Cultura di Parigi più di un anno fa.
“C’era che nel passaggio, sulla tratta i vetri lasciavano vedere la preghiera dei penultimi, la trasparenza”. Voglio iniziare con questa frase che racchiude in poche parole l’essenza stessa del tuo ultimo viaggio, sia fisico che letterario: Penultimi. Parlacene.
Il termine viaggio è quello più appropriato perché proprio di viaggio si è trattato, in senso iniziatico oltre che di trasporti presi alle cinque del mattino per andare nelle periferie in cui insegno. Un’iniziazione fatta di silenzi e cose, in un ordine quasi soprannaturale, metafisico come ha osservato un amico poeta Eugenio Tescione a una recente presentazione dei Penultimi. Una metafisica laica, se è possibile, in cui ogni giorno si disegna una cartografia di volti che sono facce, fatica ma anche ostinazione alla vita. Qualcosa che allo stesso tempo è rituale, in un tempo che si fa scandire per giungere in tempo, e nuovo, ogni volta perché si è in una forma di disponibilità al mondo, alle cose e ogni volta succede che le cose ti parlino. Io lo chiamo attraversare il mondo da antennisti.
Non ultimi ma penultimi, perché?
Mi sono ispirato a un passaggio dell’Abécédaire di Gilles Deleuze. Una lunga galoppata video-filosofica in cui ogni lettera introduce un concetto. Deleuze alla lettera B come il bere, racconta del rapporto che gli alcolizzati hanno con l’ultimo bicchiere, quello della staffa, quello dell’ultimo giro, che in realtà è sempre penultimo. Penultimo perché ci si ferma a quello, più o meno coscientemente, per permettere la successione con il primo del giorno dopo. Se si cedesse all’ultimo si andrebbe incontro alla morte. I miei penultimi rappresentano un’umanità che è prima della fine. Gli ultimi sono quelli che prendono la metro alle sei e mezza, alle sette, e si accalcano, si spintonano, si mandano affanculo, protestano, hanno facce annerchiate, incazzate. I penultimi, no. Nonostante l’ora, le cinque e mezzo, hanno un sentimento quasi collettivo di stare al mondo e ne condividono la fatica, l’ingiustizia dello sforzo che soprattutto a una certa età lo senti.
Nell’irruenza delle parole usate da Biagio Cepollaro nella nota critica al libro, leggiamo: “Forlani salta l’attrazione del male e ne parla bene. La letteratura quindi viene costretta a fare il suo mestiere: dire la bellezza proprio nel momento in cui dice una scomoda verità. Anche se questa verità fa propriamente male”.L’eco di queste parole si riverbera lungo tutte le pagine del tuo testo. Giunge anche tra le righe dedicate alla violenza causata dal terrorismo, quando siamo diventati altro, scrivi. Cosa siamo diventati, Francesco, e cosa ti ha insegnato questa tua esperienza ai margini della notte?
E del giorno, aggiungerei. Che per me è come seguire un corso di umiltà, non che ne avessi veramente bisogno, di riconciliazione con lo stato delle cose, delle responsabilità, un senso del dovere che si accompagna al senso di quello che si fa, che si tratti di un’aula scolastica o di un ufficio, di un cantiere o di un negozio.
Un volume il tuo che mi ha profondamente commosso. Dalla prima pagina all’ultima è un continuo sollecitare le corde più intime, le più fragili forse. Forse le meno visitate per il terrore di smuovere quella parte di finta solidità che ci ripara dal mondo. Il tuo intento era voluto o la commozione fa parte della visione di quel mondo nascosto ma assai popolato che molti si rifiutano di guardare?
Ultimamente ho sentito usare il termine penultimo da una certa destra quasi come rimprovero alla sinistra talmente concentrata sugli “ultimi”, per esempio i migranti, da dimenticare i penultimi, ovvero una grossa fetta della popolazione autoctona che vive alle soglie della povertà. I miei penultimi, ne sono certo, non andrebbero mai a una manifestazione sovranista e si guarderebbero bene dal farsi difendere da Salvini o dalla Le Pen. Si tratta di esistenze che cercano ognuna nel proprio piccolo di rendere possibile la vita sociale e far funzionare strutture e cose che contribuiscono o almeno vorrebbero alla determinazione di uno spazio collettivo. Sanno che è un privilegio farne parte, lavorare, anche a costo della fatica che ci vuole. Credo che questi scritti commuovano perché le cose che vedi commuovono, come l’umanità profonda di quelle ferite sul campo.
“Fino a quando ci saranno i penultimi questo vorrà dire che c’è ancora margine per l’umanità, che non siamo giunti alla fine del viaggio, al termine della notte”.
Chissà che ne direbbe Louis-Ferdinand, Francesco.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE:

Intervista a Liliana Madeo e alle sue “Donne di mafia” a cura di Angela Vecchione
1 – Donne di Mafia Liliana è un’inchiesta giornalistica, molto rispettosa, che non hai voluto romanzare o colorare in alcun modo le vicende trattate. Hai delineato due tipi di donne nelle organizzazioni mafiose: quelle cresciute in famiglie criminali e quelle che ci sono capitate per aver scelto l’uomo sbagliato. Dalla tua indagine, più vittime o più carnefici?
Di avanzare quote, numeri, proprio non me la sento. La scena che mi sono trovata davanti quando mi sono messa a studiare il tema era – ed è – colma di ombre, contrapposizioni. Delle donne che hanno sollevato la testa e pronunciato le parole della denuncia si sa chi sono, il prezzo che hanno pagato per la loro scelta, il sostegno che è stato dato loro per tornare a vivere e a far vivere liberamente i propri figli. Non sono moltissime ma esistono, e il contributo che hanno dato per fare luce sui rapporti fra Stato e criminalità, boss e manovalanza spicciola, è sempre stato riconosciuto, citato. Preziose si sono rivelate anche le ambiguità, le incertezze, le paure fra cui si erano dibattute prima di riuscire a spezzare la regola del silenzio che vige in quel “mondo a parte”, esclusivo, maschile, violento, in cui si erano trovate e che è Cosa Nostra: un percorso, il loro, a noi utilissimo per capire o almeno intuire la gamma dei comportamenti e delle motivazioni interiori che muovono le “altre”, quante all’interno di quel circuito continuano a stare.
Ecco le first ladies. Non parlano. Defilate dietro le quinte, lasciano a lui ogni onore e responsabilità. Nessuno può dire di conoscerle. Nessuno è autorizzato a parlare con loro. Sanno che una delle qualità per cui sono state scelte come spose o compagne, sta nella loro capacità di tacere, non esibirsi, condurre una vita ritirata, non frequentare persone di altro ambiente. È lui, la sua immagine, quello che mai dimenticano.
Le matriarche. Entrare nella famiglia mafiosa ha significato per loro rilievo sociale, soldi, sicurezza. Sanno tutto quello che il compagno fa e gli viene chiesto di fare. Ne condividono le traversie. Non giudicano e non ne parlano con nessuno. L’arresto o il confino in cui può incappare lo sposo o un figlio anima i loro giorni, le costringe a viaggiare, contattare avvocati e amici fedeli, diffondere messaggi, maneggiare fax e telefoni, gestire affari per miliardi. Può anche succedere che lo sposo o il figlio diventi un “pentito”. E allora non possono perdonarlo, non vogliono più neppure vederlo, magari indossano il nero che si addice al lutto delle vedove: quel “tradimento” è un’infamia, la loro vergogna.
2 – Parli di donne come Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, molto attive nel sistema: ha maneggiato soldi, gestito traffici, trasmesso la cultura mafiosa ai propri figli. Come si concilia il senso di maternità e l’alto rischio di mortalità al quale sono esposti i figli cresciuti nel ventre dell’illecito? Si può essere madri affettuose e fredde assassine?
Sì, l’amore materno e l’ombra della morte in agguato si conciliano benissimo nell’animo e nella vita di queste ladies. Ad Agata Barresi uccisero sei figli. Ogni volta lei scendeva in strada e sul cadavere del figlio di turno steso a terra urlava a perdifiato il suo dolore, senza mai dire una parola agli uomini dello Stato, senza dire neanche il suo nome. Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina, meglio di ogni altra sa che il mondo in cui è vissuta – come una star a fianco di un marito che dettava leggi, seminava esecuzioni capitali e accumulava prodigiose ricchezze – è un mondo in cui domina l’etica della violenza e della morte. Certo che ama i suoi figli. E proprio perché li ama, e sa che corrono rischi – perché i nemici, i rivali, gli avamposti di una nuova banda sono sempre in agguato, pronti a colpire i beni i più preziosi dell’avversario, i figli appunto – si è sempre tenuta ben stretta la rete della comunità mafiosa che a lei e alla famiglia garantisce una protezione continua. Ma niente è semplice in un territorio simile: l’amore materno può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Per amore dei figli, per non mettere a repentaglio la loro vita, molte donne – come abbiamo detto – restano fedeli al gioco della mafia. Però può succedere che un figlio venga ucciso e allora – sempre per amore – la disperazione fa uscire la madre dal gioco e la induce a gridare con voce tonante le sue accuse, cioè a “tradire”. Anche la vigilanza del clan non sempre si rivela sufficiente. Ci sono i figli che, nonostante ogni misura protettiva, vengono uccisi. I figli che, riconosciuti dallo Stato responsabili di gravi reati, finiscono in carcere. I figli che, un giorno, per le ragioni più diverse si discostano dalle persone fra cui sono cresciuti, dall’aria che hanno respirato, e girano le spalle all’ ”Onorata Società” .
3 – Il tuo libro è uscito venticinque anni fa. Rispetto a tutti i movimenti come mee tooche danno voce a soprusi dei quali le donne sono costantemente vittime, il ruolo femminile nell’organizzazione criminale è mutato da allora? E tu, ne hai riportato traccia in questa nuova edizione?
La visione arcaica della donna siciliana – colei che esegue gli ordini del marito, ubbidiente e cieca, prototipo della donna di mafia – ha continuato a circolare fino agli anni Ottanta-Novanta negli atti processuali, nelle aule giudiziarie. Già da tempo persone e associazioni femminili autorevoli rintuzzavano questa “verità”. Ma furono l’arrivo sulla scena di donne di mafia con titoli di studio ed esperienze culturali o manageriali alle spalle, e l’occhio critico di una nuova generazione di inquirenti – fra cui anzitutto Falcone e Borsellino – a far cadere i vecchi parametri di giudizio, che oggi non vengono neanche ventilati. Le compagne o aspiranti compagne degli uomini di mafia non stanno più nella penombra. Parlano in pubblico. Esibiscono la loro bellezza e i loro talenti. Non fanno mistero delle competenze che hanno quanto all’uso dei mezzi di comunicazione più avanzati. Sono viaggiatrici instancabili. Si muovono come cinghie di trasmissione fra poli di denaro e di potere sparsi nel pianeta. Il loro potere e la loro complicità con gli uomini del sistema mafioso appaiono lontani anni luce da quelli di un tempo. In realtà – proprio come un tempo, anche se in maniera diversa – continuano ad essere funzionali al successo dei disegni, dei propositi, degli obbiettivi indicati dai capi delle cosche. Un nodo fondamentale della struttura mafiosa continua a esistere, neppure intaccato dai venti dell’apparenza. L’affiliazione – con il giuramento e il solenne rituale che sanciscono l’appartenenza di una persona per tutta la sua vita a Cosa Nostra – resta preclusa alle donne. La donna resta un soggetto inaffidabile, una creatura debole, con molti talenti ma capace di provare emozioni che possono mettere a rischio l’intero territorio su cui la mafia esercita la sua signoria. Il gradino che separa l’uomo dalla donna nell’esercizio del potere all’interno dell’Onorata Società esiste ancora, solido e ben difeso. Una preclusione che riguarda, da sempre, anche il soggetto gay. L’organizzazione è – e resta – rigorosamente monosessuale, maschilista.
4 – Tre aggettivi per descrivere la tua opera.
Tre aggettivi? Tre soltanto?

Angela Vecchione intervista quel “Dio Web” di Matthias Martelli
- Siamo sempre connessi Matthias, ma sempre meno presenti nella vita di tutti i giorni. È questa la molla da cui prende vita Nel nome del Dio web?
La molla è stata questa. Ma un accadimento della mia vita è stato decisivo per farmi concepire questo lavoro. Una volta mi si è rotto l’iPhone mentre scendevo le scale. Ero in ritardo, dovevo avvisare delle persone, in un attimo mi sono ritrovato solo. Sprofondo nella crisi, sia nell’immediato, sia nei giorni successivi durante i quali ho usato un vecchio Nokia senza connessione. Quel vecchio telefono assolveva alla sua funzione primaria: telefonare e mandare messaggi. Ma, nonostante ciò, mi teneva fuori dal mondo. Mi sono sentito in una specie di isolamento. Questa cosa mi ha fatto rendere conto di quante volte io guardassi prima il telefono. Di quanto io ne fossi in qualche modo dipendente. Con quel Nokia, ero connesso con la realtà in maniera diversa. Ho recuperato una parte di me precedente a questa connessione totale e globale. Mi ricordo, da ragazzino, della tecnologia come qualcosa che mi attirava. Non c’era la connessione, c’erano i messaggi, le telefonate. La tecnologia che ad un certo punto potevi spegnere. Così ho riconquistato alcuni spazi.
 Mi è capitato in quei giorni di vedere un filmato fatto da un mio amico quando avevamo quindici anni. Io e i miei amici eravamo in un parchetto e ci comportavamo come ci si comportava in un periodo storico che non ti pone nella costante minaccia di poter essere ripresi. Rivedendo il filmato mi sono accorto che un mio amico guardava nel vuoto. In quella ripresa datata ho notato che se ne stava seduto tranquillo a non muovere un dito. Quel suo non fare nulla mi è sembrato qualcosa di semplice e di straordinario insieme: un ragazzo di quindici anni che guarda in un punto imprecisato, pensa a qualcosa per conto suo, senza essere impegnato a comunicare a distanza con nessuno. Senza sentire l’esigenza di utilizzare quel tempo morto per chattare/postare/cercare/vedere. Era con noi amici, pure se in quel momento non stava parlando. I telefoni quando eravamo piccoli servivano per incontraci: noi volevamo stare insieme. Guardarci in faccia, ridere insieme, annoiarci e pensare ai fatti nostri. Ma senza la solitudine che si avverte oggi.
Mi è capitato in quei giorni di vedere un filmato fatto da un mio amico quando avevamo quindici anni. Io e i miei amici eravamo in un parchetto e ci comportavamo come ci si comportava in un periodo storico che non ti pone nella costante minaccia di poter essere ripresi. Rivedendo il filmato mi sono accorto che un mio amico guardava nel vuoto. In quella ripresa datata ho notato che se ne stava seduto tranquillo a non muovere un dito. Quel suo non fare nulla mi è sembrato qualcosa di semplice e di straordinario insieme: un ragazzo di quindici anni che guarda in un punto imprecisato, pensa a qualcosa per conto suo, senza essere impegnato a comunicare a distanza con nessuno. Senza sentire l’esigenza di utilizzare quel tempo morto per chattare/postare/cercare/vedere. Era con noi amici, pure se in quel momento non stava parlando. I telefoni quando eravamo piccoli servivano per incontraci: noi volevamo stare insieme. Guardarci in faccia, ridere insieme, annoiarci e pensare ai fatti nostri. Ma senza la solitudine che si avverte oggi.
- Come ti è venuta l’idea del prelato (Don iPhone) che tramite il web predica la fede (a modo suo), elargendo consigli con il telefono?
Ho associato in modo naturale le nuove tecnologie alla religione, il sacro mi è sembrato il veicolo più immediato per esprimere questa nuova realtà. La preghiera con idoli coevi è diventata simbolica di un mondo nel quale non poteva che esercitarsi una parodia della nostra contemporaneità. L’approccio satirico, diciamo, mi è venuto spontaneo.
È così pervasiva questa dimensione tecnologica, che al pari di qualsiasi fede religiosa accettata tout court, entra nelle nostre vite senza lasciarci il tempo di porci troppe domande. Negli ultimi anni siamo arrivati al paradosso che, pur condannando questa nuova religione profana, noi la accettiamo supinamente. Anche la “vecchia guardia”, le generazioni cresciute senza questa costante connessione, molto spesso non riescono a ricordare come si stava quando si viveva senza lo strumento che ha stravolto le nostre vite, regalandoci tanto. Ma allo stesso tempo togliendoci anche tanto: lo smartphone.
- Da dove nasce, dove è giunto fino ad ora e dove vuole arrivare Matthias Martelli?
La nascita si rintraccia in un’idea popolare e giullaresca di esibizione artistica, che per me si traduceva in monologo satirico portato nelle piazze. Quello che mi ha fatto recitare qualsiasi cosa prima di approdare a teatro. Il mio obiettivo era quello di generare domande e riflessioni attraverso la risata, senza offrire necessariamente soluzioni. Grazie al lavoro che faccio ho la fortuna di avere un contatto diretto con diverse generazioni, dai ventenni, ai sessantenni. Mi sono reso conto che i ragazzi di venti anni, i nativi digitali, abbiano una difficoltà sempre maggiore di affrontare i rapporti vis a vis. Li maneggiano senza empatia, senza coraggio. I rapporti finiscono con un messaggio, le persone si cancellano dalle chat, i contatti si eliminano. Con il mio, Nel nome del Dio Web, molti spettatori dopo essere stati a teatro mi scrivono, dandomi anche un feedback sulle cose che hanno cambiato grazie ai paradossi portati in scena nello spettacolo che, al netto delle risate, offre loro un po’ uno specchio nel quale guardarsi.
La risata libera energie, ti rende disponibile a recepire dei messaggi che vanno al di là del momento di divertimento e mirano a creare degli squarci per vedere altre cose. D’altronde l’arte serve anche a questo, no? A fermarci.
- Tre aggettivi tre per descrivere la tua opera.
Ironico, corrosivo, sorprendente.

MUSICA SOLIDA – intervista di Alessandro Bottero su Classic Rock
MUSICA SOLIDA
LA MUSICA È SOLIDA, SOLIDISSIMA. MA FORSE, SENZA IL VINILE ABBIAMO PERSO QUALCOSA. IL LIBRO DI VITO VITA RIPERCORRE LA STORIA DEL VINILE E DELL’INDUSTRIA DISCOGRAFICA IN ITALIA
Il sottotitolo recita “Storia dell’industria del vinile in Italia”. Ma è davvero esistita da noi una industria del vinile?
Certo: gli stabilimenti della Ariston a San Giuliano Milanese (che fabbricavano anche i flexy pubblicitari e le “cartoline che cantano”) o quelli della Durium a Erba erano fabbriche a tutti gli effetti, e le aziende erano strutturate con staff dirigenziali, amministratori, strategie di programmazione e così via. Un mondo che occupava migliaia di persone e che ormai è scomparso.
La musica solida è la musica riprodotta in modo industriale. Prima la musica si ascoltava, si ricordava, si studiava, si eseguiva a modo proprio… E oggi?
Oggi paradossalmente si ascolta molta più musica, pensa al sottofondo nei negozi oppure al supermercato, ma tutto scorre via sulle nostre orecchie senza lasciare tracce.
Il tuo libro inizia con la storia della tecnologia con cui si registra e riproduce la musica. Perché?
Era utile inquadrare la nascita della Phonotype nel 1903 e quella delle prime case discografiche milanesi sin un contesto di diffusione nel nostro Paese delle invenzioni d’oltreoceano, grazie ad alcuni pionieri: in questo capitolo tra l’altro c’è una mia scoperta, fatta consultando gli archivi dei quotidiani d’epoca, sul ruolo avuto dall’ex garibaldino Enrico Copello. Dal punto di vista storico, credo che sia una delle cose più interessanti del volume. Il discorso sulla memoria è però alla base di tutto il libro, non di un singolo capitolo: in ogni ambito, l’Italia pare essere un Paese senza memoria.
Nel 1955 “le vendite dei 78 giri e dei primi 45 giri ammontavano a sette milioni di copie”. E oggi?
Siamo messi male. La situazione però non è paragonabile. La musica si ascolta dappertutto e viene meno quindi il desiderio di acquistarla. Sopravvive il live.
Negli anni 60 ci fu il boom dei 45 giri. Da cosa dipese secondo te?
Dal boom economico: all’inizio degli anni 60 la crescita di un ceto medio che comprava la Seicento, andava in vacanza al mare e acquistava i 45 giri. Poi, a metà decennio, con l’arrivo del beat i giovani per la prima volta vennero individuati come consumatori.
Nei 70 mutò il paradigma: dal 45 al 33. Cosa cambiò?
Nel 1949, di ritorno dagli Stati Uniti, Edgardo Trinelli della Fonit-Cetra previde l’affermazione del 33 giri, che consentiva di sviluppare un discorso artistico più completo, e in effetti l’avvento sul mercato degli Lp rese possibili progetti più complessi, i cosiddetti “concept album”. Il primo in Italia fu nel 1963 DIARIO DI UNA SEDICENNE di Donatella Moretti. L’affermazione definitiva negli anni 70 avvenne con il diffondersi prima del prog e poi dei cantautori, ma sostanzialmente non è che la promozione discografica sia cambiata più di tanto. È cambiata la funzione della radio: Per voi giovani poteva ogni tanto trasmettere un album completo (lo fece con TERRA IN BOCCA dei Giganti), ma in televisione casi del genere erano meno frequenti.
Negli anni 80 l’avvento del Cd rappresentò davvero la fine dell’industria del vinile in Italia?
Sicuramente: nel corso degli anni 80 chiudono aziende storiche come la Ri-Fi, la Durium, la Ariston, e altre vengono acquisite da grandi gruppi stranieri come la RCA Italiana. Il fenomeno continuerà negli anni 90 con la Ricordi e la Fonit-Cetra, per esempio.
QUI L’ARTICOLO ORIGINALE: