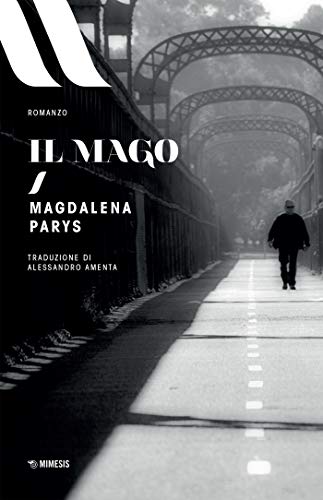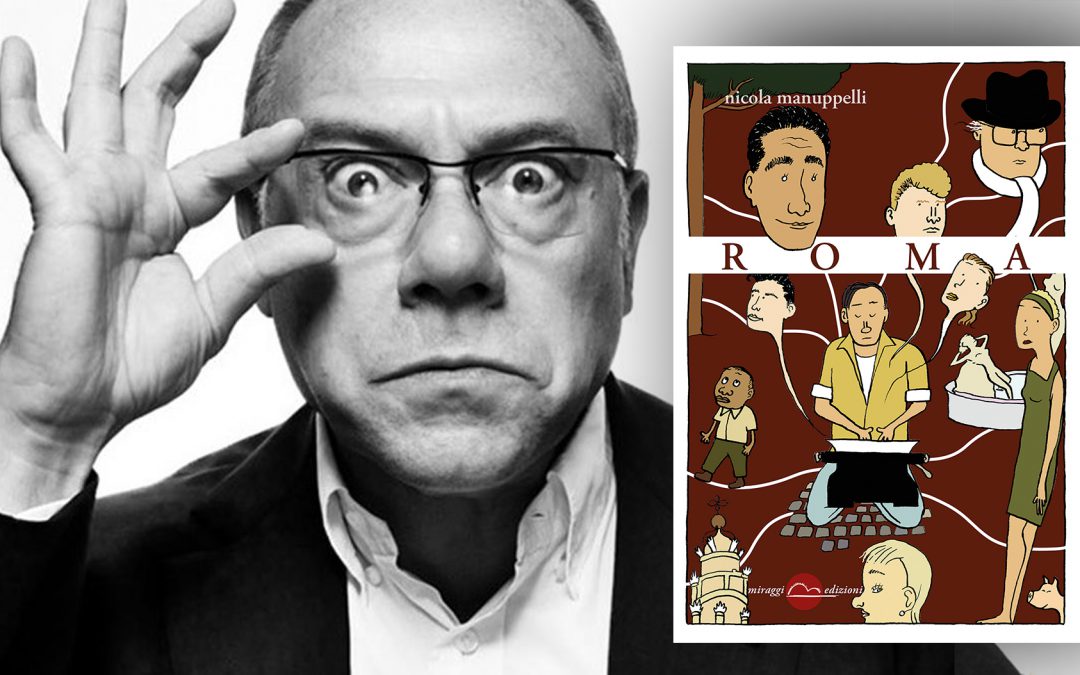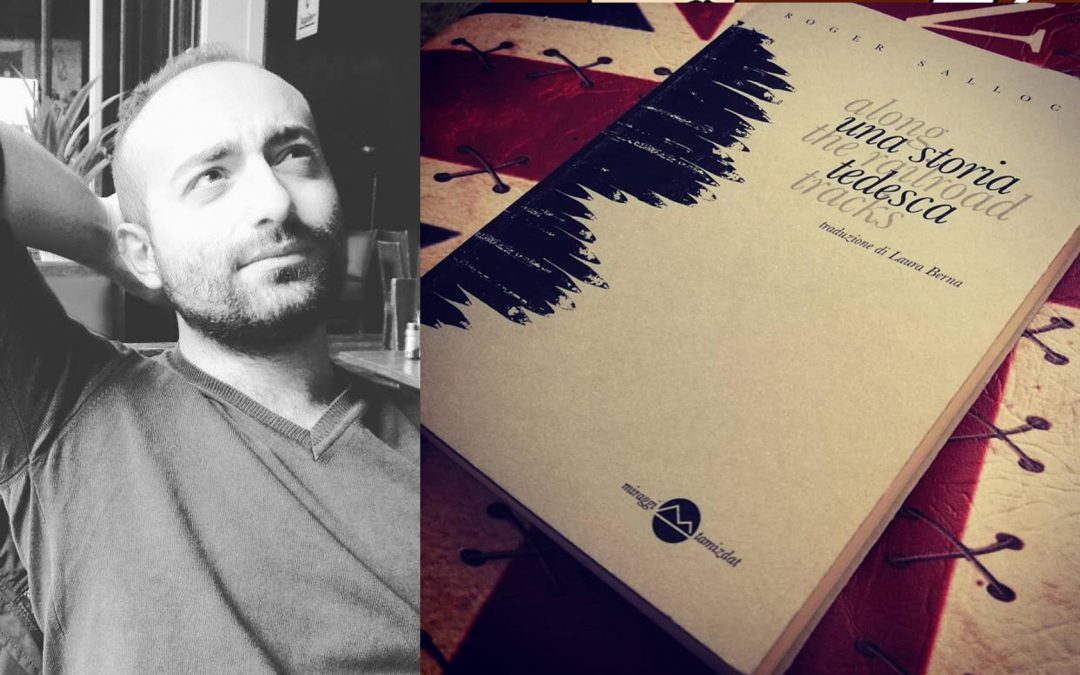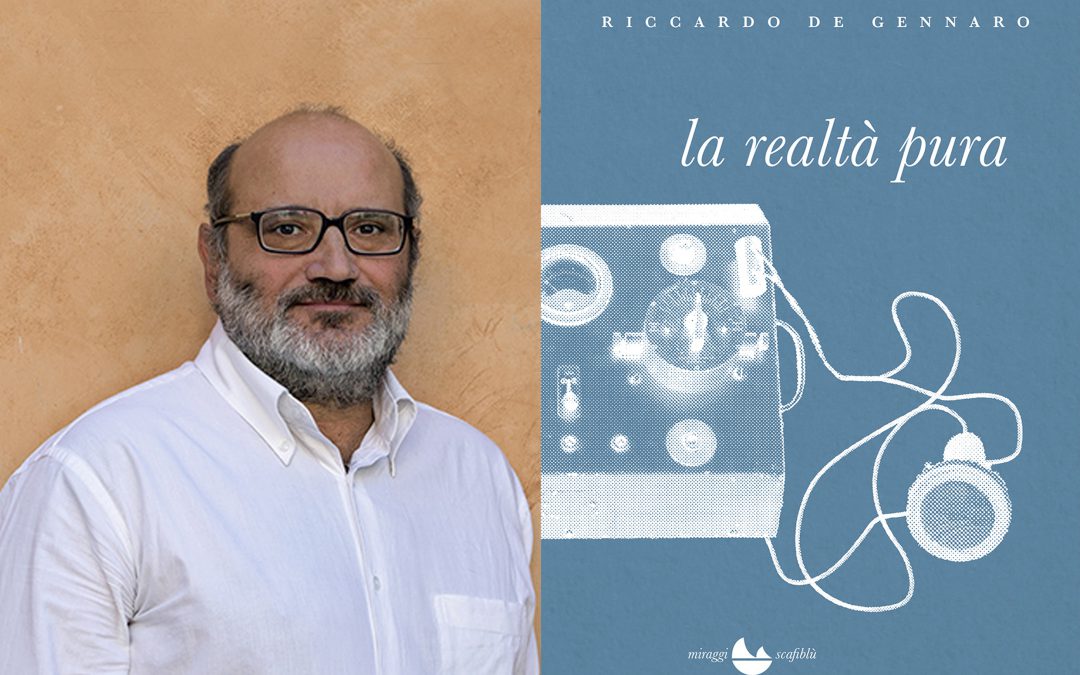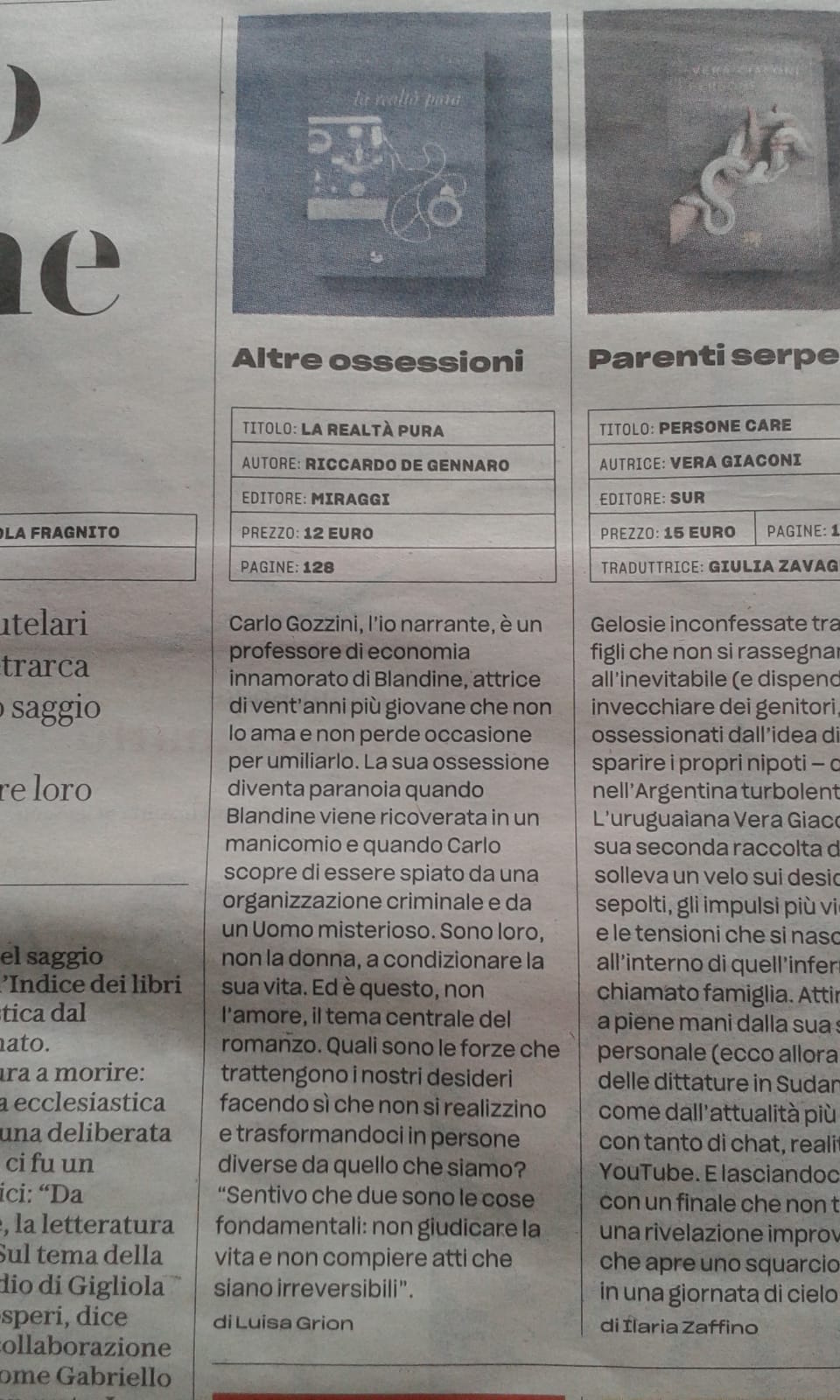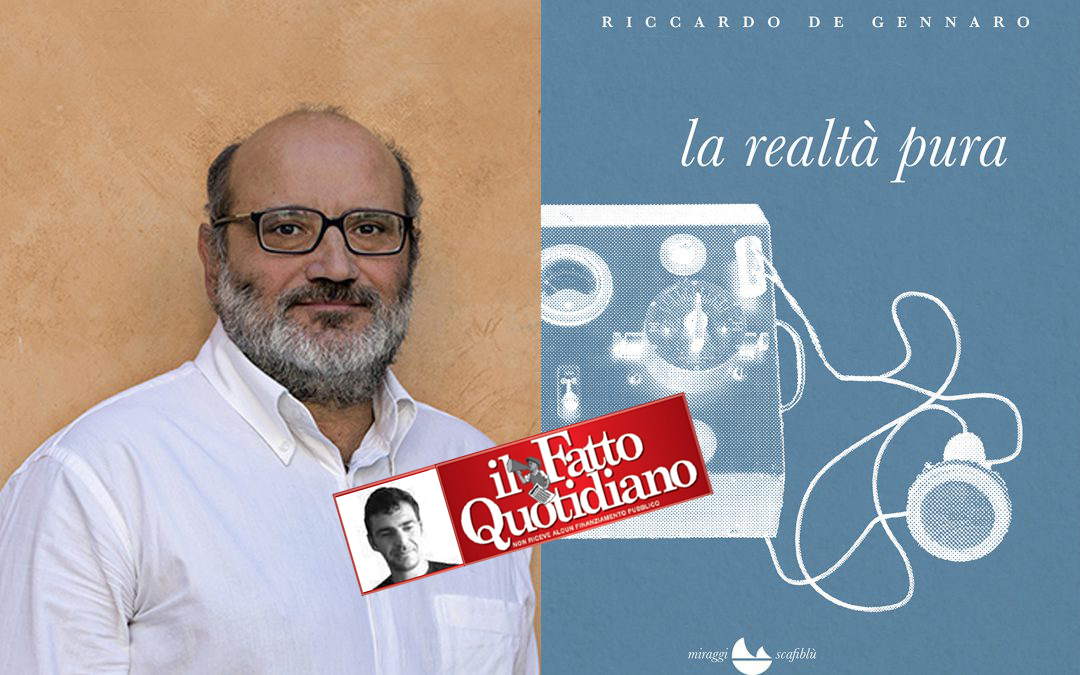Dietro Immédiatement, il libro di Dominique de Roux ora in edizione italiana (Immediatamente, Miraggi editore, pagg. 252, euro 18, traduzione di Francesco Forlani) c’è un curiosa storia di censura politico-intellettuale-editoriale che vale la pena ricordare.
Pubblicato nel 1972, era una sorta di carnet personale, annotazioni di letture, considerazioni, riflessioni, descrizioni, incontri di chi si era già imposto come un enfant prodige delle lettere francesi. All’epoca trentasettenne, de Roux aveva esordito a vent’anni fondando la rivista L’Herne, finanziata con la vendita di alcuni gioielli di famiglia. A 25 aveva scritto il suo primo romanzo, Mademoiselle Anicet, a 26 trasformato la rivista in Cahiers de l’Herne, Pound, Bernanos, Céline, Gombrowicz, Borges… Nel decennio successivo, fra saggi (La mort de L.-F. Céline, L’Ecriture de Charles de Gaulle, L’ouverture de la chasse), pamphlets (Contre Servan-Schreiber), attività editoriali (le edizioni Christian Bourgois, di cui fu uno dei fondatori, Presses de la Citè, di cui era consulente letterario), romanzi (Maison jaune, L’Harmonika-Zug) aveva consolidato una posizione di battitore libero in controtendenza rispetto al proprio tempo: il «nouveau roman» lo faceva piangere di noia, il maggio francese gli era sembrato una mitomania collettiva, la sinistra intellettuale una tribù antropofaga che faceva carriera sul cadavere del marxismo…
Immédiatement segnò per molti aspetti una sorta di cesura fra ciò che c’era stato prima e ciò che ci sarebbe stato dopo e la frase con cui si apre, «Molto spesso, ho preso congedo», farà dire a biografi e familiari che si trattasse di una cesura volontaria, un farla finita con il mondo in cui si era sino ad allora mosso, grazie a una triplice provocazione, politica-letteraria-intellettuale, propedeutica a una sua inevitabile espulsione.
La prima provocazione ha a che fare con un giudizio su Georges Pompidou, scritto quando quest’ultimo non era ancora presidente della Repubblica: «Pompidou – questa bella Venere di Lapougue della politica francese – sa tutto. Sa come si incula una mosca, come il 15 agosto presentare i suoi ossequi alla Vergine Maria. Conosce pure l’Inferno e i francesi. Porta sulla Francia uno sguardo da veterinario poiché la Francia di Pompidou è una truffa politica». La seconda riguarda Maurice Genevoix, segretario perpetuo dell’Académie française: «Uno scrittore per somari». La terza prende di mira Roland Barthes, pontefice massimo dell’intellighentia parigina: «Un giorno, con Jean Genet, mi dice Lapassade, parlavamo di Roland Barthes; di come avesse separato la sua vita in due, il Barthes dei bordelli con ragazzi e quello talmudista (sono io a precisarlo); dicevo: Barthes è un uomo da salotto, è un tavolo, una poltrona… No, ribatté Genet: Barthes è una pastorella».
L’Eliseo, così come l’Académie a difesa di Genevoix, fecero pressioni sull’editore di Presses de la Citè, Barthes minacciò di procedere per via giudiziaria contro le edizioni Bourgois. Risultato: la pagina relativa a quest’ultimo venne tagliata via dalle copie ancora in deposito e, su mandato imperativo dell’editore, i librai fecero lo stesso con le copie in loro possesso, de Roux venne licenziato in tronco da Presses de la Citè e si ritrovò messo praticamente alla porta da quella stessa casa editrice che aveva contribuito a fondare…
La sua vita successiva sarà quella di chi aveva deciso di non rassegnarsi al recinto del letterato. Farà dei reportage in Angola e in Portogallo sarà una sorta di consigliere di Jonas Savimbi, il guerrigliero leader dell’Unita, nella «rivoluzione dei garofani» si illuderà di trovare l’idea di un impero d’Occidente in grado di costruire fra Portogallo e territori d’oltremare una nuova alleanza… Morirà nel 1977, a 42 anni, per una malformazione congenita al cuore di cui era naturalmente a conoscenza e che per molti versi spiega la precocità, l’attività febbrile, le intemperanze ideologiche e di cuore: sapeva che il tempo a disposizione era poco e intendeva sfruttarlo sino all’ultimo.
Immédiatement ha i pregi e i difetti dei libri fatti di frammenti. Nomi, luoghi e bersagli polemici che al momento sembravano importanti, si rivelano con il tempo di circostanza, e le stesse provocazioni che allora lo fecero mettere all’indice, oggi rischiano di apparire incomprensibili. Il suo valore è altrove, nei pensieri umorali, nelle confessioni a viso aperto: «Lo spirito senza la carne è onanismo. La carne senza spirito è bestialità». «Mi dice Jean, dopo aver parlato di mio figlio Guillaume: Non sei che un attore. A volte il fondale va in pezzi e continui a recitare senza sapere che reciti la tua stessa vita». «Essere moderno vuol dire cedere alle circostanze». «L’odio, dimensione borghese della rabbia». «Non voglio più appartenere alle circostanze della mia vita». «Come far capire a certe persone che funziono solo in condizioni aberranti. Allorché, invece, tutto ciò che è borghese è partecipe di un qualsivoglia interesse». «Guadagnarsi da vivere. Tanto tempo perduto in denaro guadagnato».
Vissuto in un Novecento in cui l’homo ideologicus teorizzato da Cochin per spiegare la Rivoluzione francese e il Terrore aveva ormai raggiunto la sua piena maturità, de Roux venne etichettato dai suoi nemici come «fascista», cosa che in Immédiatement gli detta questa considerazione: «Mi viene voglia di presentarmi così: Io, Dominique de Roux, già impiccato a Norimberga». Quell’etichettatura faceva del resto parte di una singolare inversione del vocabolario: «Il mercenario diviene volontario, l’agente speciale un consigliere, il questurino un patriota, i corpi di spedizione l’aiuto al Paese fratello, l’aggressione deliberata, un’assistenza militare per abbattere la reazione. Il tutto con L’Internazionale in sottofondo».
C’è nel libro un lungo giudizio di Romain Gary a questo proposito esemplare, proprio perché Gary con l’homo ideologicus aveva poco o niente da spartire. Scrive bene de Roux, dice dunque Gary, «un autentico scrittore», ma il suo piglio polemico rimanda non tanto a una «questione di fascismo di fondo», quanto a un «fondo fascista». Che però, ammonisce, non esiste: «Il fascismo è sempre stato un contenitore che soffre del vuoto interiore, del suo vuoto, ecco perché può trasformarsi facilmente in fosse comuni. I cadaveri fanno sempre molto contenuto». Sulle «fosse comuni» per la verità il bolscevismo avrebbe potuto dare delle lezioni, così come il Terrore rivoluzionario giacobino, ma questo Gary non lo può dire, altrimenti l’impalcatura del suo ragionamento non sta in piedi e quanto a praticare «letterariamente l’odio», in Francia come altrove la sinistra colta non andrà certo a lezione dalla destra ignorante… Su una cosa però Gary ha ragione: è tempo che de Roux affronti «non altri ma se stesso con ferocia, coraggio e senza pietà. Io è un contenuto che lo chiama, il grande appuntamento letterario è con lui». Immédiatement è sotto questo aspetto la risposta che proprio Gary avrebbe voluto.
Leggi la recensione anche su http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/de-roux-leggere-immediatamente-e-ripensare-calma-1640272.html